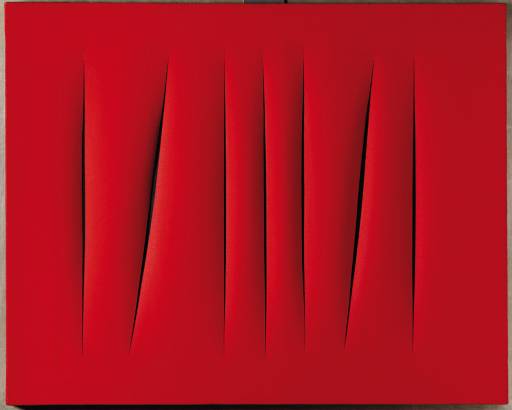-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Musei molto indignados
Politica e opinioni
Le recenti vicende italiane mettono in luce una situazione finanziaria critica ma soprattutto una crisi di idee. Mancano trasparenza e autorevolezza. Cose che non regala nessuno, ma che bisogna conquistare. E poi difendere. Ripartendo ora dall’abc
Avete presenti quelle stupende architetture che ci hanno abbagliato negli ultimi anni? Molte di queste erano musei. Con pareti lucenti di titanio, dove si specchiava una città nuova o che, sebbene di cemento, fluttuavano come gioiose macchine dell’arte in città vecchie, ma volenterose nell’intraprendere una strada sorprendentemente moderna. Cambiate film. È roba del passato. Quelle cose lì, che si son fatte in tempo a costruire – miracolo anche questo, non solo architettonico – non le vedremo più. Almeno dalle nostre parti, in Occidente. Semmai in Cina, in India, dove continuano a tirare su le nuove cattedrali del nostro tempo, i più convincenti biglietti da visita che le nuove economie espongono sulla grande vetrina internazionale.
I soldi che sono stati spesi, c’erano e sono stati, appunto, spesi. Ora sono finiti, ed è tempo di pensare ad altro. Per esempio, «Back to basics», come si dice Oltreoceano: tornare all’abc, ai fondamentali. Esercizio che ogni società, periodicamente, si trova a dover fare. Con la paziente saggezza di guardare oltre il dato, e il disastro, cercando di apprendere una lezione preziosa da quel che è stato. Pare che siamo usciti da quell’ingombrante «paradosso del progresso» di cui già qualche anno fa aveva parlato l’editorialista americano Gregg Easterbrook: sebbene nel decennio passato la vita migliorasse, la gente viveva male. Alquanto infelice. Curioso no? E non è detto che tirare un po’ la cinghia sia necessariamente peggio. Non si tratta di neopauperismo, ma di ritorno, appunto, ai fondamentali, ai valori, a quello che si è perso per strada, specie nei nostri anni berlusconiani.
Sì, ma con i musei che c’entra? C’entra perché la ripresa della nostra Italia incagliata, negli scogli del Giglio e del debito pubblico, dovrebbe passare anche da qui. Dalla valorizzazione, o almeno dal non sprecare quello che è stato fatto. Solo che i politici non ci sentono. Ha problemi di udito chi recentemente ci ha spiegato che con la cultura non si mangia e quanti mettono e tolgono soldi come se stessero a svagarsi al tavolo della roulette, piuttosto che a badare alla pubblica amministrazione.
E allora la palla passa anche a noi, gli operatori del sistema, smettendola di delegare e di aspettare l’ombrello della politica sotto cui accomodarsi. Pare che la crisi obblighi anche a lavorare di più, non tanto ciascuno alla propria scrivania, ma insieme e soprattutto di testa e di fatti.
I recenti siparietti da commedia dell’arte, che sono andati in scena ancora una volta purtroppo al sud, dimostrano che ci sono poche altre chance. Negli anni Novanta a Palermo era stato speso un bel mucchio di soldi per restaurare i Cantieri alla Zisa, i grandi capannoni rimasti dell’ex mobilificio Ducrot a un passo dalla dimora estiva di Federico II. Viavai di mostre e assessori, set cinematografici e poi, improvvisamente, più nulla. Forse perché i Cantieri erano targati Leoluca Orlando, allora sindaco e, come si conviene in un Paese come il nostro affetto ancora di feudalismo, quando cambia il potere cambia tutto. L’attenzione e i soldi quindi si spostano su Riso e Riso decolla. Anche qui dopo un po’ di disinvolti stop and go, discutìbili prove generali che hanno ingoiato un altro mucchio di soldi, viavai di funzionari, curatori, presunti o reali, assessori. Poi si inizia. Va bene per un po’: mostre, progetti di farne l’epicentro di un “museo diffuso”, investimenti in collezione e pochi giorni fa l’annuncio della chiusura, nonostante i 100mila biglietti staccati in due anni, dato che però è difficile verificare. Poi arriva la smentita, i dietrofront. Tutto e il contrario di tutto. Esattamente come accade al MADRE di Napoli, di cui periodicamente si annuncia, o minaccia, la chiusura, perché il direttore non è più espressione della nuova maggioranza e non molla, perché spende troppo (quando i soldi UE ci sono, ma bloccati), perché forse a nessuno in realtà gliene frega niente. Forse perché il museo è nato cagionevole, voluto da un politico appassionato di arte contemporanea. E nel frattempo il MADRE langue, un’agonia che ormai si protrae da un paio d’anni e che, peggio, è quasi accettata con rassegnazione. A Palermo è nato un movimento di cittadini per opporsi alla chiusura di Riso, a Napoli no. Tanto si stanno allungando i tempi, che la morte volutamente annunciata passa per morte naturale. Senza che nessuno si assuma la responsabilità di una decisione. Senza voltare pagina, se lo si ritiene veramente necessario.
Quello che ferisce di una realtà come questa è l’indifferenza, il fare e il non fare. Come se non si trattasse di beni comuni, pagati dai cittadini, ma di pedine da muovere svogliatamente, per ripicche o faide interne, sulla scacchiera.
Non è che al nord le cose vadano tanto meglio. Nonostante le lodi alle mostre realizzate, della Galleria Civica di Trento, diventata fondazione nel 2009 perché avesse vita più autonoma e più solida, ora si vorrebbe farne un PS1 in versione trentina (ma intorno non c’è New York, ma appunto il Trentino), mettendolo sotto tutela del Mart, il mega museo di Rovereto affidato recentemente a Cristiana Collu, la cui capacità non è in discussione – soldi a parte, la creazione del MAN di Nuoro dal nulla è un fatto – ma il cui non ricco curriculum ha riacceso polemiche sulle procedure di nomine ai vertici dei musei.
Qui si tocca un altro nervo scoperto: le procedure di nomina delle direzioni. In Italia il pubblico concorso su progetto, come si usa fare all’estero nei musei veramente prestigiosi, continua ad essere un tabù, che al massimo strappa qualche benevolo sorriso di compassione: “ma di che ci si lamenta, suvvia!”. Le nomine le fanno gli assessori, quando i musei sono comunali o legati comunque a un ente locale. Mai che ci sia una commissione di esperti, e possibilmente super partes, a giudicare. Il risultato è che se cambia l’assessore, cambia anche il direttore. Programmi e progetti vanno a gambe all’aria, impedendo per esempio ai nostri musei di prendere impegni all’estero con i corrispettivi internazionali, che invece possono contare su una programmazione spesso triennale. E quando cambia il direttore, cambia anche lo staff, che magari ha lavorato bene. Si ricomincia da capo: nuovi incarichi, nuovi stipendi, nuova programmazione. Instabilità, un’altra malattia italiana, e altri sprechi. Perché il museo è, e deve rimanere, espressione della politica. È accaduto al MADRE, al Macro, al Castello di Rivoli. Ma qui c’è dell’altro. Una delle ragioni della sua crisi, oltre che nei tagli operati dalla giunta Cota, da molti è individuata nella nomina di Giovanni Minoli alla presidenza del museo, voluta a tutti i costi dall’allora assessore Gianni Oliva. Coincidenza curiosa: prima di fare l’assessore, Oliva scriveva libri, era preside scolastico ed ex insegnante di storia e, al tempo dell’affaire Rivoli, prossimo a tornare in cattedra (nessuno giurava sulla sua rielezione, anche in caso di conferma della giunta Bresso). E che cosa fa Minoli? programmi di storia in tv. Poi la cosa non è andata avanti, ma l’idea che ci fosse una captatio benevolentiae è stata forte.
Magari i direttori di nomina politica sono bravissimi – in Italia e nella nostra pubblica amministrazione non prevalgono i comandanti Schettino – ma quanto sono autonomi? Quanto possono smarcarsi dalle cordate di riferimento e dai loro amici? Perché anche in questo campo, al quale la politica non sembrerebbe particolarmente interessata altrimenti non interpreterebbe la parte di “Mani di forbice”, l’Italia deve continuare a non essere un “paese normale”, minimo sindacale richiesto in democrazia? Probabilmente tutti ne trarrebbero giovamento, tutti avrebbero più credibilità.
Non penso siano ingenuità da “anime belle”, ma richieste di maggiore trasparenza ed efficienza. Che vanno pure nella direzione di quello che cerca di fare Monti con le liberalizzazioni, che però guarda caso incontrano ostacoli in virtù del vecchio adagio “nimby”: not in my back yard, non a casa mia. Perché noi “non siamo capaci di fare sistema”, afferma Anna Mattirolo, direttore di MAXXI Arte. Vero. Ma il nostro continuare ad essere immaturi campanilisti si traduce ormai nel non saper fare i nostri interessi. Mentre il mondo cambia.
Anche la gestione dei musei e l’amministrazione della cultura, settori marginali rispetto ad emergenze più gravi, non possono sottrarsi all’aggiornamento del calendario. Niente è uguale a come era prima. Pochi soldi richiedono più coraggio, più impegno, non solo per trasformare i musei in centri culturali, con dibattiti e incontri low budget rispetto alle mostre. E richiedono capacità di agire e fare sistema sotto regole più trasparenti.
Il tempo è poco. Sebbene apparentemente vuoto, spalancato com’è dal crollo dello scenario precedente. Un vuoto che va riempito di idee. In politica, come nella cultura. Perché dal crollo non rimangano solo rovine, occorre abbandonare vecchie abitudini mentali ormai inservibili, pensare anche i musei come qualcosa di necessariamente diverso da quello che erano fino a pochi anni fa. E pensare in modo diverso anche noi stessi.
A.P.