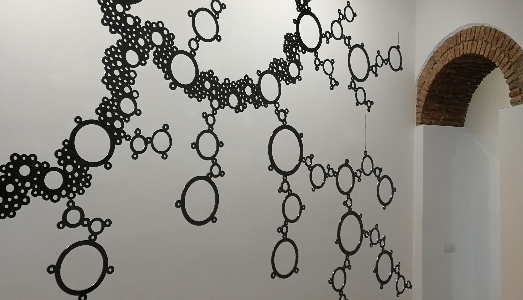Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
23
aprile 2016
La grande sorella
altrecittà
Video arte come mutazione genetica del reality show. La personale di Johanna Billing che si è aperta a Villa Croce ci ha convinti. Vi spieghiamo perché
Per fortuna Ilaria Bonacossa è direttore artistico di un museo italiano, e fan dichiarata della video arte. Si perché la svedese Johanna Billing (Jönkoping, 1973) non era mai stata protagonista di una personale nel nostro Paese, pur avendo esposto un po’ dappertutto ed essendosi giustamente fatta il giro delle biennali sparse per il globo, da Singapore a Venezia, passando per Istanbul. E a perderci, più che il solo curriculum dell’artista, era l’Italia stessa, che alla Svezia chiede per prima cosa mobili coi nomi impronunciabili. Con una mostra curata dal suo direttore artistico, è Villa Croce la prima istituzione nostrana ad ospitare i lavori della Billing con “Keeping time” (fino al 12 giugno), mini antologica che mette in luce le capacità di un’artista amante della musica (tempi addietro è stata giornalista musicale e possedeva un’etichetta discografica) e passata per lo studio della danza, know how centrifugato e fatto confluire nei suoi progetti video-performativi.
Per Keeping time si è operata una selezione di quattro lavori dall’ultimo quindicennio d’attività, quattro video in cui «il tempo è un elemento importante», quanto il modo di rapportarsi alla pratica filmica con un senso che sempre la stessa curatrice descrive come «pittorico», dove «immagini e musica hanno lo stesso identico valore». Definizione da sottolineare, poiché un editing pedissequamente tarato sulla corrispondenza di crescendo/diminuendo audio e video non è solo pignoleria, ma il passo decisivo per la creazione di un’empatia totale, concetto chiave di un’emotività fruibile, vera. Che rende – e qui mettiamo volutamente le mani avanti – anche piuttosto difficile riportare a livello piatto-testuale lavori pensati per avere una propria rotondità. Poi che la Billing sia pure parecchio pignola è evidente, e s’intuisce anche prima di sentir parlare Bonacossa dei suoi «tempi molto lunghi, per produrre un video può metterci anche due anni», come di scoprire che per la sua personale genovese si è addirittura prodigata nello scegliere i rivestimenti in moquette con cui sono stati ricoperti i pavimenti di tutte le sale. «C’è stata due mesi per scegliere le tonalità giuste» continua la curatrice, e ne è valsa la pena aggiungiamo noi.

“Keeping time” infatti si presenta con un buonissimo allestimento, che non ti piazza davanti a dei video e finita lì. Pretende piuttosto d’essere una mostra d’ambientazione, dove tutto sembra pensato in modo da prevenire la (facile) banalizzazione della proiezione: pavimento, ma anche schermi di dimensioni ad hoc che riempiono fisicamente lo spazio e diffusione audio avvolgente, con tanti decibel, che tuttavia avrebbero meritato un lavoro d’insonorizzazione sala per sala non conciliante con le finanze del museo genovese.
Soluzione papabile ai problemi d’inquinamento acustico è l’audio in cuffia di I’m gonna live anyhow until i die, anno 2012, creazione post soggiorno romano della Billing. La trama prevede un manipolo di bambinetti come fil rouge di un dichiarato omaggio a Pasolini (al cui interno la ragazzina che sfoglia il vangelo sembra un messaggio subliminale) e alla romanità che passa per i luoghi del regista-scrittore, tra una mangiata di cozze e vongole, il traffico rumoroso di Via Ostiense, il rione Testaccio e il degrado sul mare di Ostia. C’è una punta di ruffianeria quando, parlando di selezione dei lavori da esporre, la curatrice confessa d’averlo scelto anche perché «c’è Roma»; poi figuriamoci, c’è anche Battiato arrangiato ad archi (violino e contrabbasso). Spiazza però l’uso delle cuffie, che se da un lato ha i suoi pregi, dall’altro mina la condivisione collettiva dell’opera. Può sembrare una considerazione frivola in un luogo dove la ciarla è cosa assai poco gradita. Ma la svedese è troppo attratta dall’uomo, dalla sua libera complessità individuale e sociale, per immaginarla a suo agio nel costringerne le attitudini comportamentali. A prescindere che, in quanto artista, si comporti da “registratore” o “regista” nei confronti dei suoi simili.

“Registratore” o “regista”, questo il dilemma. I lavori della Billing si distinguono sempre per il loro dosaggio libero di sceneggiatura e improvvisazione, personaggi e persone. Si tratta di una pratica maturata proporzionalmente ai credits che accompagnano ogni lavoro. Da Where she is at a Pulheim jam session, rispettivamente del 2001 e del 2015, l’evoluzione in fatto di produzione va di pari passo col sistema narrativo-emozionale. Resta immutata un’azione di montaggio che cerca sempre di appuntare la narrazione al luogo e, come fa notare Bonacossa, una «assenza di dialoghi, che rende l’opera di Johanna Billing assolutamente universale».
Però la centralità su cui si basa il primo – dove la ragazza (performer) sul trampolino è tanto una specie di parafulmine d’angoscia universale quanto unità a sé, che s’intreccia “distintamente” col circostante mondo dei bagnanti (gente vera, non performer) – esplode nella coralità del secondo, in cui la fittizia creazione di un blocco stradale tra ai campi si trasforma in un bestiario comportamentale in crescendo, con chi si dedica alle parole crociate, chi mangia o semplicemente riposa. Dominante è l’eterogeneità del parco auto, la stessa pianista si serve delle quattro ruote per andare a sua volta ad improvvisare al pianoforte, in un capannone che non ha una vera ragion d’essere. Non c’è netta distinzione tra pianificazione e improvvisazione, tra le inquadrature ai ragazzi del backstage ed ai protagonisti, tutto rientra nel prodotto-video. Tutti sono ben coscienti di “cosa” andranno a fare, ma non “come” lo andranno a fare.

Sulla carta è un minestrone, nella realtà dei fatti non si trova una sbavatura a pagarla oro, con la scelta del loop senza soluzione di continuità (costante per tutti e quattro i lavori) che spezza il circuito temporale producendo uno story telling infinito, dove inizio e fine sono dati imprevedibili, non certi e non forniti di default dall’artista.
Con l’ultimo video in scaletta, I’m lost without your rhythm, vi sfidiamo a non sciogliervi battendo il tempo con piedi e mani, trascinati dall’andamento delle percussioni. O piuttosto è Johanna Billing in persona che vi sfida a non essere voi stessi, a comportarvi da spettatori ingessati. Del resto il museo non è un sacrario, e la videocamera districata tra ragazzi intenti a prove di danza in stile Amici propone vita, mentre si calpesta una moquette che riprende quella dove si compiono le movenze loro e dell’addetta alle pulizie col suo rumoroso aspirapolvere. “Keeping time” è al massimo dei giri, quando guardare e sentire trasmutano la struttura empatica in una performance totale, in un esigente “esser presenti”. Peccato solo per quella manciata di sedie (peraltro scomode) in mezzo alla sala, che si presentano come un ostacolo (fisico) o un ossimoro (logico). Comprendiamo l’esigenza, ma anche che bastava osare un’eliminazione (o sistemazione meno invasiva) perché il museo auto-censurasse in toto il trattamento museale dell’opera. Obiettivo di per sé particolarmente interessante.
Andrea Rossetti