Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
18
marzo 2013
Ritratto del curatore da giovane
rubrica curatori
La parola ad Alessandro Rabottini ex Capo Curatore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Abruzzese di origine, da due anni si è trasferito a Londra, diventando testimone delle realtà artistiche italiana e inglese
di Manuela Valentini
di Manuela Valentini
Alessandro, di dove sei e quanti anni hai?
«Sono nato a Chieti, in Abruzzo, nel 1976. Dopo aver vissuto dieci anni a Milano mi sono trasferito un paio di anni fa a Londra, dove attualmente vivo».
Cosa hai studiato all’università?
«Ho studiato Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea all’Università di Chieti, dove mi sono laureato con una tesi sull’interpretazione di genere – nello specifico omosessuale – di Minimalismo, Arte Concettuale e Anti Form nel lavoro di Felix Gonzalez-Torres, Tom Burr e Henrik Olesen. In realtà ho iniziato da subito a frequentare il mondo delle mostre (a 22 anni il mio primo lavoro è stato il tuttofare volontario per un’edizione di Fuori Uso a Pescara) e a 24 anni ho iniziato a lavorare come assistente curatore presso la GAMeC di Bergamo. Penso che la mia formazione – che mi auguro non terminerà mai – sia stata fatta per lo più di frequentazioni con gli artisti, critici, galleristi e collezionisti; è stata ed è una formazione sul campo, quotidiana».
Come è proseguito il tuo rapporto alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo? E verso cosa hai indirizzato la tua ricerca?
«Sono stato Capo Curatore della GAMeC dal 2006 al 2011 (prima sono stato rispettivamente Project Manager e, in seguito, Curatore) e, dal 2011, sono Curatore Esterno. Ho lavorato quasi esclusivamente sul formato della mostra personale, invitando artisti emergenti, sia italiani che stranieri, a sviluppare un progetto di mostra inedito e pensato ad hoc. In un certo senso credo che questa mia preferenza verso il formato della mostra personale dipenda dal fatto che considero un privilegio (un dovere), come curatore, quello di poter dedicare un tempo lungo e un’attenzione approfondita al lavoro di un artista. Ho sempre cercato di portare per la prima volta in un’istituzione pubblica italiana artisti che stavano avendo – o stavano per avere – un’affermazione internazionale (come Mircea Cantor, Aaron Curry, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Johannes Kahrs, Victor Man, Kris Martin, Pratchaya Phinthong, Sterling Ruby, Mungo Thomson, Tris Vonna-Michell e Jordan Wolfson) e di portare, all’interno di questo contesto internazionale, artisti italiani o attivi in Italia come Meris Angioletti, Marcello Maloberti, Pietro Roccasalva, Matteo Rubbi, Ian Tweedy e, come nel caso della mostra attualmente in corso alla GAMeC, Giuseppe Gabellone. Più raramente mi sono occupato di artisti con una lunga carriera alla spalle, ma che credo avessero diritto a essere in un certo senso riscoperti o ricontestualizzati, come nel caso di Tim Rollins & K.O.S (Kids of Survival) o addirittura deceduti, come nel caso della mostra di Robert Overby, in programma alla GAMeC per la primavera del 2014. La maggior parte di queste mostre sono state accompagnate dalla prima monografia mai dedicata all’artista, o dalla monografia più esaustiva fino ad allora realizzata. Non so dirti se ho avuto degli obiettivi o se ci sia uno specifico che lega questi artisti tra loro, perché non credo che un curatore debba avere un’agenda che pre-esista all’incontro con una ricerca artista che lo colpisce. A volte ho cercato di portare esperienze che unissero una preoccupazione sociale e politica a una ricerca estetica e formale, altre volte ho desiderato mostrare sensibilità che facessero vedere come l’arte sia un territorio assolutamente individuale, una forma di resistenza agli eventi. Al lavoro sugli artisti si è unito quello sui curatori emergenti, attraverso il mio coordinamento di due progetti a loro dedicati: il Premio Lorenzo Bonaldi e il Simposio per Giovani Curatori».
A cosa ti sei dedicato prima di ricoprire questo ruolo a Bergamo?
Ai miei studi, dato che ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare per la GAMeC quando ero molto giovane, in un’età nella quale spesso noi italiani siamo ancora all’Università, mentre all’estero ci sono consuetudini diverse e un differente approccio all’idea di “giovane professionista”. In un Paese come l’Italia quella di giovane artista o di giovane curatore è un’etichetta che ti porti dietro fino a cinquant’anni, il che è francamente assurdo. Io stesso, a dire il vero, non mi ci sono mai considerato. Il pensarmi al di fuori di questa categoria mi ha sempre dato un’enorme spinta a lavorare di più e, spero, in meglio».
E adesso di cosa ti stai occupando?
«Di tanti progetti, per fortuna. Sto seguendo – insieme con Fionn Maede – il ciclo di incontri e conferenze per la prossima edizione di miart (5 – 7 Aprile 2013) e a fine aprile inaugurerò una mostra personale dell’artista svizzero John Armleder per The Dairy, un nuovo spazio espositivo a Londra nato dall’iniziativa di due collezionisti privati, Frank Cohen e Nicolai Frahm. A fine giugno inaugurerò presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici una personale dell’artista rumeno Victor Man, che chiude un ciclo di mostre che ha visto partecipare nei mesi scorsi Patrizio Di Massimo e Danh Vo. A settembre, invece, porterò alla GAMeC di Bergamo una mostra personale di David Maljkovic, una co-produzione tra la GAMeC, il Van Abbemuseum di Eindhoven e il BALTIC – Centre for Contemporary Art di Gateshead, che in Italia co-curerò con Andrea Viliani. Sempre a settembre curerò per il PAC di Milano, insieme a Paola Nicolin, la tappa italiana della mostra di Adrian Paci che si è appena aperta allo Jeu de Paume di Parigi».
Puoi delineare sinteticamente un quadro dell’attuale scenario artistico londinese? In che stato si trova l’arte contemporanea a Londra? Cos’ha di più o di meno rispetto all’Italia, anche in relazione alla promozione di giovani talenti?
«Londra è uno dei principali centri al mondo per l’arte contemporanea, sia per quanto riguarda la salute delle istituzioni pubbliche che per quanto concerne il dinamismo del mercato. E questo ovviamente si riflette sul modo in cui gli artisti, anche all’inizio della loro carriera, sono sostenuti e promossi. Non è semplice stabilire in poche battute un parallelo con l’Italia che non suoni semplicistico. La scena dell’arte italiana, ad esempio, è fatta di eccellenze – artisti, gallerie private, istituzioni pubbliche, riviste, collezionismo e progetti no profit – che però, spesso, lavorano “in solitudine”, isolate le une dalle altre, mentre in Inghilterra si assiste a un maggiore coordinamento tra le diverse realtà. Inoltre in Italia spesso assistiamo a un’ingerenza della sfera politica nell’ambito della cultura, che non assicura stabilità e continuità al lavoro delle istituzioni pubbliche, rendendo difficile una lunga pianificazione delle attività. In Inghilterra, invece, hai la sensazione che la politica sostenga la cultura cercando di capirne le dinamiche, e non il contrario. Non è mai salutare – né realistico – vedere tutto il positivo da una parte e il negativo da un’altra, e credo che la generazione a cui appartengo stia dimostrando la nostra capacità di lavorare su un piano internazionale, se solo pensiamo a quanti curatori italiani siano a capo di prestigiose istituzioni all’estero: Andrea Bellini a Ginevra, Francesco Manacorda a Liverpool, Chiara Parisi a Parigi, Lorenzo Benedetti a Middelburg (Olanda) e ora anche al Padiglione olandese per la prossima Biennale di Venezia, Luigi Fassi a Graz solo per citarne alcuni. Sono tutti esempi di un lavoro di qualità che deve servirci come esempio per un atteggiamento costruttivo e per ripensare le categorie con le quali di solito concepiamo l’idea di “giovane” professionista. In Italia, infatti, questa categoria è una gabbia piuttosto che un trampolino di lancio».
Attualmente scrivi per alcune riviste d’arte. Quanto peso credi possa avere quest’attività nella carriera di un curatore?
«Credo che ne abbia molto. Le riviste sono spazi in cui un curatore può sperimentare formati che non siano quelli della mostra o del saggio in catalogo, oltre a potersi confrontare con l’attualità. Inoltre amo molto il confronto con le redazioni, mi piace essere spinto a vedere le cose da un altro punto di vista. Spesso questa dimensione di dialogo manca quando lavori ad un catalogo, mentre quello che mi auguro sempre è proprio di poter mettere in discussione le mie convinzioni».









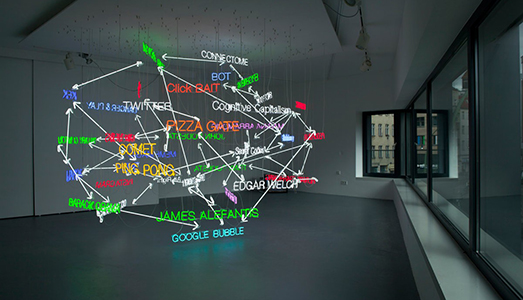

























Rabottini é bravo . Però giocare a fare l’ internazionale , quando il primo incarico nel museo l’ ha trovato con ‘ metodo all’ italiana ‘ ?