Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
17
gennaio 2016
Un gruppo organizzato di turisti è appena sceso dal pullman che li ha portati a circa cento chilometri da Las Vegas. Pantaloncini corti e capelli ben pettinati, borsa per il pranzo sottobraccio, prendono posto su comode poltroncine, file ordinate disposte nella polvere del deserto del Nevada. Tutti indossano grandi occhiali dalle spesse lenti scure, che in quegli anni ’50 dovevano sembrare ottimisticamente futuristici, per osservare, estasiati, le caratteristiche evoluzioni aeriformi del grandioso fungo atomico, stagliato come un corpo irrazionale sullo sfondo desertico. È uno show da applausi, un’attrazione imperdibile, tra una puntata sfortunata al baccarà e le luci intermittenti della Strip della città del peccato. «Viene prima un’ondata di caldo, poi la scossa, abbastanza forte per buttare a terra un uomo impreparato», scriveva un giornalista entusiasta che, l’11 gennaio del 1951, poté assistere all’inaugurazione del Nevada Test Site, 3mila chilometri quadrati di suolo americano dedicati allo spettacolo pubblico dei megatoni.
La notizia è di pochi giorni fa, la Corea del Nord continua a sfidare imperterrita il resto del mondo e afferma di aver sperimentato, con successo e per la prima volta, un ordigno termonucleare all’idrogeno, provocando un terremoto di magnitudo 5.1 nella zona del test, l’euforia degli annunciatori televisivi di Pyongyang e le reazioni sdegnate e rabbiose degli occidentali. La guerra non cambia mai e nel potere, nelle sue manifestazioni, c’è qualcosa che rimane sempre simile, una rappresentazione circolare che si esprime in modo esplicito in determinati momenti, sotto i totalitarismi e le dittature.
Francesco Jodice (Napoli, 1967) ha dedicato la sua sperimentazione al tentativo di definizione di quei meccanismi narrativi che si impongono nei processi storici penetrando ogni aspetto del sociale e del virtuale, enunciando ciò che è possibile e ciò che deve essere interdetto, fino a diventare esperienza identificativa del mondo, del sé. Le sue “Cronache”, in mostra alla Galleria Umberto Di Marino di Napoli, raccontano questa mitologia che, oscura e splendente al contempo, include la volontà del dominio e il desiderio di protezione in un margine ambiguo. Per la personale napoletana, Jodice espone un corpus di lavori estratto dalla ricerca degli ultimi anni, riportando una personale linea di analisi che incrocia linguaggi diversi, dal cinema al videogame, per evidenziare i gradi di separatezza tra le macro aree della geopolitica e gli angoli, sempre più angusti, ritagliati dagli individui.
Così, il percorso espositivo diventa un modello in scala dello sterminato palazzo dell’imperatore descritto nel racconto di Kafka, dove i corridoi portano ad altri corridoi, le stanze si moltiplicano e tutto è architettato unicamente per riverberare e celebrare la diramazione iperestesa del potere. Un conglomerato primordiale e distopico, decadente e magnifico, che riesce a raggiungere un alto grado di resilienza, assorbendo le asperità dell’indagine antropologica in un’estetica ragionata della processualità. Le immagini si susseguono negli ambienti, scandite come le misure variabili di un’installazione in atto, apparenze instabili che decretano un rapporto problematico con il fruitore e gli spazi. In questa sezione di entomologia applicata, sono rappresentate e catalogate alcune ramificazioni, più o meno comunicabili, che plasmano il concetto contemporaneo del dominio.
Nella serie The Diefenbach Chronicles, il ricordo dell’Ottocento tardoromantico e dei paesaggi capresi sublima il crollo disastroso degli imponenti sistemi imperiali e concettuali da Fin de siècle. Le crettature frammentano i faraglioni e uno strato di condensa ricopre la natura selvaggia, omologandola nella oleografia. Karl Wilhelm Diefenbach professava ideali teosofici di riforma sociale, rifiutava la monogamia, non mangiava carne, girava nudo per le strade di Capri. Qui trascorse gran parte della sua vita, in esilio volontario dalle capitali europee, come molti artisti suoi contemporanei, osservando con consapevolezza e speranza i tempestosi cambiamenti che avrebbero devastato gli assetti mondiali. Morì pochi mesi prima dell’attentato a Francesco Ferdinando, la scintilla della Grande Guerra.
Nella stanza successiva, come in uno studio abbandonato per un evento improvviso, è allestito un tavolo sul quale si trova una copia aperta del libro American Recordings, in cui Jodice racconta il sogno americano che ha formato l’immaginario collettivo occidentale. Sull’ampio ripiano è stampata una grande immagine di Miss Atomic Bomb Nevada 1953, una bionda pin up americana vestita solo della nuvola fungiforme, artificiosa nella posa e ammiccante alla sua replica verticale, fissata a parete. Uno schermo trasmette una sequenza di esplosioni atomiche accompagnate dal boato delle grandiose deflagrazioni. Quattro fotografie della serie Sunset Boulevard mostrano la spettacolarizzazione, che oggi appare tragicamente forzata, dei test nucleari del Nevada. URSS e Stati Uniti compattavano i ranghi e a Las Vegas i grandi alberghi organizzavano visite guidate per frotte di turisti curiosi di ammirare la potenza delle armi del futuro. Intere famiglie campeggiavano sulle colline per guardare “il sole a mezzanotte” attraverso gli occhiali affumicati. Dal 1951 al 1963, quando Kennedy firmò la messa al bando degli esperimenti atmosferici, 104 bombe all’idrogeno detonarono nella grande regione compresa tra l’Arizona, lo Utah e il Nevada. La popolazione che viveva nelle vicinanze dell’ex poligono atomico, negli anni falcidiata da tumori e leucemie, viene chiamata downwinders, i sottovento.
Nello stesso ambiente, sono esposte le serie dedicate alle riprese satellitari di città e paesaggi coinvolti nella scacchiera della geopolitica, immagini zenitali dell’altopiano dell’Afghanistan, del cimitero degli aeroplani militari di Tucson, del quartiere di una città giapponese, accomunate da una luminosità superficiale e geometrica.
Teatralità e finzione ritornano in At the end of the world, fotografia di un capodoglio che lotta contro un calamaro gigante. La metafora evidente del combattimento da kolossal cinematografico esprime della contrapposizione tra sistemi, da una parte la modalità tentacolare del pensiero contemporaneo, dall’altra la pesantezza della farraginosa concezione dei blocchi politici. La parte scura, che riempie un’area del campo visivo, satura la foto di una dignità maestosa, un caricaturale Marat morente.
Un romanzo non scritto copre l’arco di tre secoli brevi, collegando un capo e l’altro del globo con la stessa trama. Eppure, l’Impero non si identifica con un nome specifico, Capitalismo, Corsa agli Armamenti, Occidente, Stati Uniti, Guerra Fredda, sono pseudonimi di comodo. I suoi confini si estendono in un’area dilatata dal tutto al nulla, dove un’esplosione atomica riuscirebbe a sollevare un solo granello di sabbia. Per sopravvivere al tempo e alla storia, l’Impero disperde i propri codici e la propria esistenza. Le sue tracce si diramano tra immagini, dati, narrazioni, riferimenti, citazioni, studi, relazioni, delineando una rappresentazione permeabile e totalizzante che, nei secoli, ha assunto molte forme e infinite altre ancora ne modellerà.
Mario Francesco Simeone











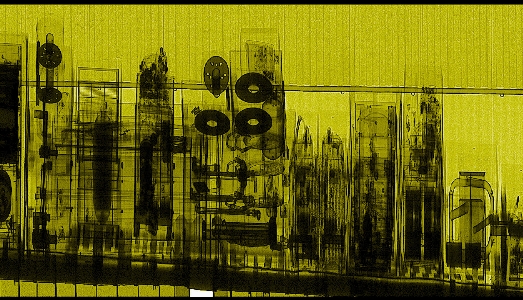



.jpg)




















