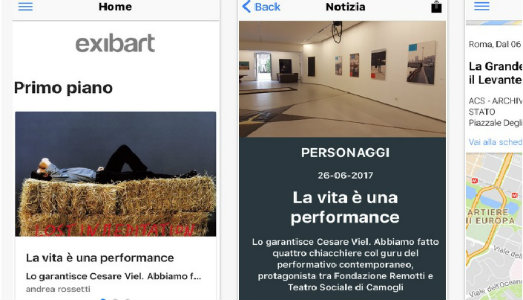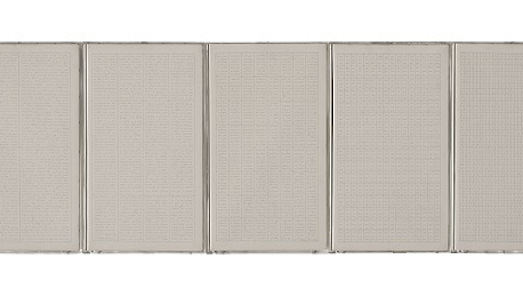Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Di solito, sono loro a mordere. Almeno così abbiamo sempre visto nei film e sui libri. Ma questa volta, no. Questa volta sarà il dinosauro a prendersi un bel morso, proprio come se fosse un tenero biscotto, altro che Jurassic Park. In effetti, il temibile animale preistorico è ancora vivo e gode di splendida salute ma non è relegato in un’isola distante, perché la sua molte mastodontica e opprimente, attuale e anticontemporanea al tempo stesso, grava soprattutto su certe energie emergenti. Come reagire? Mordendo, appunto, ma in senso buono, più come cenno di reciproca conoscenza che come minaccia. Questa è la tecnica di bitethesaurus, progetto curatoriale ed espositivo ma non solo, il cui primo assaggio sarà offerto venerdì, 26 gennaio, negli spazi di Riot Studio, a Palazzo Marigliano, Napoli, in occasione di “The other, other, familiar other”, mostra di Luca Staccioli. I curatori Dalia Maini ed Enzo Di Marino ci spiegano il metodo.
Bitethesaurus è nato dal vostro incontro e dall’osservazione di un contesto. Ma ancora prima di questo, cosa c’è? Quali sono i percorsi di vita, di studio e di lavoro, insomma, le esperienze che vi hanno portato alla necessità di esprimere questo progetto?
«Ci siamo conosciuti a Milano, grazie ad un artista, comune amico. A prima vista forse ci siamo stati antipatici, ma poi la nostra napoletanità ci ha unito. Le nostre esperienze di vita sono molto diverse, Enzo è radicato sin dall’infanzia nel mondo dell’arte Dalia invece è considerabile un elemento outsider che si è approcciato alla sua passione in età più tarda. Dal contatto tra queste storie così diverse è nata la nostra necessità di creare un ibrido tra il sistema dell’arte e il pensiero indipendente. Entrambi proveniamo da studi in Curatela dagli approcci complementari, abbiamo pensato di metterli in pratica su di un territorio fertile come Napoli».
Chi, cosa, come sono i dinosauri?
«Definire le istituzioni come musei o gallerie “dinosauri” non vuole essere dispregiativo. Da osservatori interni ci rendiamo conto che le problematiche spesso sono legate a fattori economici e burocratici, le menti che le gestiscono molte volte sono fossilizzate in pratiche che non si adattano più alla necessità di dare spazio alle micronarrazioni di cui si costituisce il panorama artistico contemporaneo. Ci poniamo quindi come portatori di un approccio genuino. Milano in questo ci ha aiutato moltissimo, perché a diversi livelli la proposta culturale “altra” è in continuo fermento».
Bitethesaurus fa riferimento a un approccio orizzontale e dialogico tra artista e curatore. Con i ritmi imposti dal contemporaneo, è ancora possibile condividere certi momenti del processo creativo, cioè lavorare “gomito a gomito”?
«Sicuramente, il processo è molto più lungo, si basa su di una comprensione profonda del lavoro, ma anche sentimentale. Ci piace conoscere l’artista con cui abbiamo a che fare, stringerci un rapporto umano in primis, scontrarci se necessario e a volte ci confrontiamo con delle diversità che possono non rientrare nel nostro campo di conoscenza, ma che quindi è stimolante approfondire. Poi il nostro “gomito a gomito” si trasla anche nella virtualità. Siamo dislocati in diverse parti dell’Italia e non solo, quindi il nostro ufficio e scrivania è un drive, le nostre conversazioni sono Skype, il nostro scambio di materiali è per mail o per messaggi. Siamo romantici, ma cerchiamo di ottimizzare ogni momento. Non ci interessa essere al passo con i tempi, ma interpretare il Tempo che più ci distingue, quello dell’approfondimento».
Sembra di capire che la base del vostro metodo sia strettamente collegata alla specificità dell’ambiente di riferimento, quello del tessuto artistico di Napoli. Come si media questo rapporto local con l’esigenza di scoprire “l’altro”, il distante?
«Napoli è una città che si è sempre aperta alle diversità, è nella sua storia e nella sua posizione geografica, d’altra parte ha la capacità di inglobare l’altro, manipolarlo e farlo proprio in modo unico. Moltissimi artisti di spessore internazionale vi sono passati, grazie alla lungimiranza di personalità che hanno capito quanto Napoli potesse segnare una carriera artistica e al contempo scavare negli animi sensibili. Ci interessa sfruttare questa dinamica, per tale motivo ci poniamo come innesto, protesi organica che ha tempi di assorbimento lunghi per non essere rigettata. Il limite per noi è un vero e proprio spazio di movimento e sperimentazione, poiché consente una visione ampliata di più realtà, per noi è un caleidoscopio. Vorremmo, in futuro, posizionarci in tutte le realtà che hanno questa caratteristica, Napoli è solo il punto di partenza, nonché luogo delle nostre origini. Come noi lontani e poi vicini lungo l’Italia, avendo avuto esperienza della distanza da questa città, ci piacerebbe avvicinare chi non ha ancora avuto un rapporto di prossimità con essa e soprattutto, offrire un’ottica di distanziamento creativo a chi invece la vive nel quotidiano, artisti autoctoni e pubblico».
Primo incontro al Riot Studio, a Palazzo Marigliano, uno dei angoli più significativi di Napoli, con un intervento di Luca Staccioli, un giovane artista che, nella sua ricerca, ha affrontato il tema del luogo e del viaggio. Com’è andato a finire questo dialogo?
«Siamo grati al Riot Studio di averci ospitato, è proprio dai suoi spazi che abbiamo ideato la mostra di Luca Staccioli. Siamo partiti dall’opera video Was it me? Screen Memory (2017) e abbiamo provato ad aprirla in senso teatrale mettendola in relazione con opere realizzate in precedenza, come la serie Inhabiting Atlas (2015- in divenire) frutto degli spostamenti dell’artista, ha già visto molti luoghi, ne ha assorbito le storie. L’unico lavoro prodotto appositamente per questa mostra è il manifesto dello “spettacolo teatrale” da cui prende il titolo la mostra: The other other, familiar other. Ci interessava creare un dialogo diretto tra lavori non site-specific che però assumono un nuovo significato a seconda del luogo in cui vengono posizionate. Le opere di Luca, disposte all’interno del Riot, metteranno in scena una geografia di possibilità personali e collettive che passano attraverso il concetto di altrerità e che inevitabilmente la interrogano».
Cosa vedremo nei prossimi appuntamenti?
«Ci piace pensare che il concetto di lontananza sia molto sfumato, infatti potremmo descrive il nostro approccio come telescopico. Individueremo giovani artisti e realtà geograficamente lontani da Napoli, ma estremamente interessati al suo fermento, arrivando poi al suo cuore artistico. Non vogliamo fare anticipazioni, speriamo che la curiosità e la fiducia siano ciò che smuove il pubblico». (mfs)
In alto: Luca Staccioli, Souvenirs: creole #2, 2016