Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1


«Amava il giallo, mentre io preferivo il rosso. Nello studio c’era un muro giallo, dove aveva scritto in violetto, Io sono lo Spirito Santo, io sono Santo in Spirito». Julian Schnabel chiude in questo modo il suo ritratto di Vincent Van Gogh, lasciando parlare Paul Gauguin. Con l’unica animazione di tutto il film, dopo i titoli di coda, che segue i tratti inclinati della sua scrittura in corsivo, che appare di solito inframezzata da disegni nelle sue famose lettere. Restituisce così valore alla loro amicizia, testimoniando la propria verso entrambi.
Il film non è una biografia filologica della vita di Van Gogh, è piuttosto un manifesto della pittura secondo Julian Schabel, oltre a un omaggio e a un’adesione completa verso colui che, evidentemente, ritiene un vero maestro, a differenza degli impressionisti, dei divisionisti, dei veristi. Cui, tra l’altro, in parte, Van Gogh si ispirava, forse neanche tanto consapevole della propria grandezza rispetto a loro.
Attraverso Vincent apprendiamo che la pittura secondo Schnabel è scultura più che stesura di superfici, rivelazione dello Spirito del Mondo, Verità soggettiva. Nulla che non sappiamo già e, forse, questo del manifesto è il meno riuscito degli aspetti di At eternity’s gate. Se si può fare una critica è che se vuoi fare un manifesto sul tuo lavoro scrivi un bel libro, fai un bel saggio ma lascia in pace Van Gogh.
Il film è pensato per essere molto facile, fruibile e naif e ha una qualità che a tratti è anche il suo peggiore difetto. Non entra mai nel merito del discorso sulla follia dell’artista, nel discorso all’Artaud, presentando la follia come una forma acuta della visione, utilizzando uno sguardo spesso in soggettiva, osando entrare dietro la sua retina. Anche se, in qualche modo, aderisce alle parole di Antonin Artaud nel fatto stesso di girare un film su Van Gogh che scampi lo sguardo da letture psicoanalitiche, saggi di sociologia dell’arte, compianti sull’artista morto. In apertura del suo saggio, Van Gogh, il suicidato della società, Artaud aveva scritto: «Chiunque può parlare della salute mentale di Van Gogh – che in tutta la sua vita non ha fatto null’altro di male se non tagliarsi un orecchio e cucinarsi una mano – in un mondo in cui ogni giorno si mangiano vagine in salsa verde e paté di sesso di neonato, proprio come nasce appena espulso dal sesso di sua madre».
Senza entrare, dunque, nell’infinita letteratura psicoanalitica sull’arte – e di questo lo ringraziamo – Schnabel risolve per vie brevi la vicenda, con la trama del film. Semplicemente mostra l’omicidio di Van Gogh a opera di due ragazzini che volevano solo prenderlo in giro e rubargli i quadri, nel momento esatto in cui iniziava a diventare un artista quotato. Se sia vero o no, in fondo non è interessante, la verità è la posizione di Schnabel, che rifiuta di attribuire a Van Gogh una volontà di morte, descrivendo la sua follia semmai come un amore senza limiti per la luce del vivere in totale innocenza e adesione alle cose.
Fra le inquadrature più riuscite, van Gogh che volge le spalle al Romanico di Arles e dipinge la luce che filtra fra le foglie gialle degli alberi di Castagno, cosa che Monet non avrebbe fatto mai, semmai avrebbe incluso il colore delle foglie con il violetto delle ombre e ne avrebbe fatta una serie, che si vende oltretutto molto meglio, sembra dirci Schnabel, fra le immagini. Altro momento di manifesto, Gauguin e Van Gogh che di spalle pisciano in un campo di grano appena seminato, mentre Paul dichiara l’assoluta nullità artistica di Seurat e Monet, smentito da Vincent.
Altro fatto, legato alla sensibilità americana e soggettiva di Schnabel: la sua è una interpretazione alla Whitman, sembra quasi di sentire risuonare il barbarico Yoop dell’artista. L’accento è posto sull’attività di ritrarre la natura, molta meno enfasi è data all’aspetto dei ritratti, che pure lo pone fra i più grandi maestri della fisiognomica mai esistiti. Di conseguenza, il lavoro sulla soggettività, che è costato a Van Gogh l’esclusione dal mondo dei ricchi e dalla società, è chiusa con facilità in un linguaggio cinematografico da video-clip e non è una critica perché lo rende potente, non fosse per delle musiche completamente banali e fallacemente contestuali. Insieme al liquidare tutta la sotterranea religiosità di Vincent in un dialogo con un prete, al quale Schnabel fa assumere i panni dell’artista concettuale, facendogli girare il quadro. Questa è in ogni caso un’altra delle scene più riuscite del film. Molti artisti concettuali sono in effetti i confessori e gli esorcisti dell’arte.
Letta all’interno del linguaggio dell’arte e senza uscirne, la storia diventa più interessante e non è lecito forse fare altro. Forse, in questa scelta di privilegiare il rapporto con la natura gioca anche l’esperienza del mercato di Schnabel che è anche artista e collezionista, dato che l’opera più famosa di Van Gogh negli stati uniti è Iris, battuta in asta nel 1987 per quasi sessanta milioni di dollari.
Proporrei dunque di leggerlo come una scommessa su Van Gogh e come un atto d’amore. E di accogliere il suo invito a tenere d’occhio i disegni, che forse sono ancora quello che il mercato ha di più accessibile e che sono destinati solo a salire nelle quotazioni.
Voi che potete, comprate tutto e comprate bene. Le quotazioni sono in crescita e, in fondo, a Vincent non sono mai importati tanto, ve li regalerebbe anche oggi, i suoi disegni. (Irene Guida)




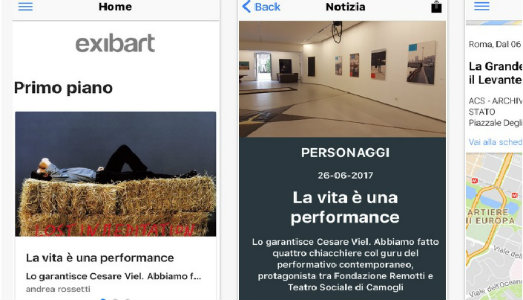




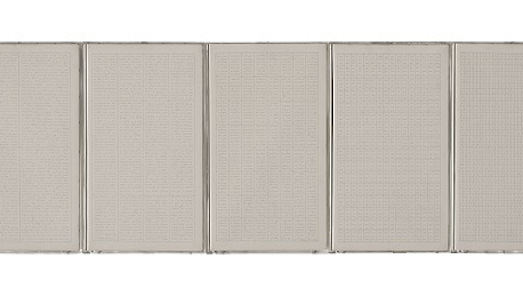
.jpg)




















