Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
24
novembre 2018
Lichtenstein, non tutto pop
altrecittà
Dallo sguardo agli “antichi Maestri” al rapporto con John Cage, il grande artista americano sotto un’altra lente. Un po’ meno “retinica”
di Luigi Abbate
Seascape (1964) e Kinetic Seascape 8 (1966) – il secondo fra l’altro rimanda, per via della presenza di un motore elettrico che ne attiva la movimentazione, alle esperienze europee, coeve o di poco precedenti, dell’arte cinetica – non sono il Roy Lichtenstein più noto, quello immancabilmente Pop. L’uso del Rowlux, plastica in policarbonato e vinile, crea semplici effetti illusionistici che si sommano alla fredda asetticità del bianco/nero trattato con la tecnica del puntinato Ben day che ha reso Roy Lichtenstein uno degli artisti più popolari del secondo Novecento. Queste due composizioni rimandano al notissimo lavoro di John Cage, In a Landscape (1948), non lontano dai citati di Lichtenstein anche nella titolazione. E allo stesso modo che in In a Landscape di Cage per l’ascolto, anche in Lichtenstein l’occhio vede ma non osserva, o non osserva solo, ciò che vede. Riceve stimoli di natura complessa, carichi di segnali che a loro volta rimandano ad altro. Un’ “allotropia”, qua visiva, là uditiva, comunque percettiva, che trasforma il modo stesso di accostarsi all’opera d’arte. Proprio come in In a Landscape, anche in Lichtenstein l’asetticità dell’immagine (riprodotta, rappresentata, interpretata, scegliete voi, comunque proiettata a sua volta nel nostro immaginario interpretativo) si fa correlato oggettivo di un vissuto individuale, una sorta di piccolo teatro della memoria personale, una “miccia emotiva” ed esperienziale che può trascendere del tutto da natura e possibili finalità/significati dell’immagine/argomento trattato dall’artista.

Roy Lichtenstein, Sweet Dreams, Baby!, 1965, serigrafia su carta, 95,6 x 70,1 cm Collezione Angela e Mimmo Jodice
Queste ed altre considerazioni possono venire in mente incontrando Seascape (1964) e Kinetic Seascape 8 alla mostra “Lichtenstein e la Pop Art Americana” allestita alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo fino al prossimo 9 dicembre. L’hanno curata a quatto mani Stefano Roffi e Walter Guadagnini. Il primo è Direttore della stessa fondazione parmense, il secondo della torinese Camera – Centro Italiano per la Fotografia, che proprio sotto la sua curatela ha in corso fino al prossimo 13 gennaio “Camera Pop – La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano e Co”. I due sono riusciti a presentare in una quarantina di opere un ritratto a tutto tondo del grande artista statunitense. Accanto ad esse lavori di altri autori legati alla stagione Pop stars-and-stripes, a cominciare dall’alter ego Andy Warhol, una Marylin del quale è elegantemente collocata ancor prima di entrare nello spazio tradizionalmente destinato alle mostre temporanee. Gli altri “compagni di strada” (in realtà anche distanti da Lichtenstein e fra loro) sono Robert Indiana, Allan D’Arcangelo, Mel Ramos, James Rosenquist, Tom Wesselmann, Dorothy Grebenak.
Non un contorno le belle fotografie di Ugo Mulas e Aurelio Amendola che ritraggono Lichtenstein al lavoro. Infine, a destra dopo l’ingresso della villa, val la pena assistere alla visione di un film sulla figura dell’artista.
Significativi prestiti dalla Fondazione Beyeler, come Ball of Twine, lavoro del 1963, la cui importanza sta anzitutto nell’uso combinato di retino e tratto continuo, tecnica praticata nei successivi Brushstrokes, due dei quali, del 1965 e del 1967, presenti in mostra, in prestito dalla Sonnabend Gallery. La galleria newyorkese ha dato una parte significativa delle opere in mostra, tra cui il citato Seascape, il delizioso Little Aloha o la piccola ma intensa litografia Crying Girl del 1963 utilizzata anche per il manifesto e la copertina del catalogo, mentre dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Saint Etienne viene l’altrettanto significativo, sia per composizione della testura che per dimensioni (quasi tre metri di lunghezza), Entablature del ’75.

James Rosenquist, “1947 – 1948 – 1950”, 1960, olio su masonite, 76,2 x 222,3 cm Collezione privata
Lichtenstein è artista ben più complesso di quanto non risulti dall’appiattita immagine popolare, diremmo quasi una “vulgata”, a sua volta legata al marchio di fabbrica dello smisurato ingrandimento dell’icona fumettistica e pubblicitaria. Certo, il successo di quest’immagine è dovuto alla straordinaria coincidenza fra intento poetico, segno espressivo e tecniche usate per rendere tale gesto. Coincidenza che in ogni tempo e in ogni disciplina artistica rende l’autore unico, originale e inimitabile (se non dai suoi epigoni). Tuttavia la stagione creativa legata alla cosiddetta Pixel Art, considerata non senza qualche ragione una sorta di implementazione del puntinismo di Seurat attraverso la cosiddetta tecnica Ben Day risalente all’inizio Anni Sessanta e ben descritta da Stefano Bucci in catalogo: “…Quel falso “retino” tipografico (che tecnicamente si ottiene applicando il colore attraverso griglie traforate) quell’escamotage che dà l’impressione che ogni sua immagine sia l’ingrandimento fotografico di un’immagine stampata”, è, ripeto, solo uno degli aspetti del suo lavoro, e comunque è il risultato di una ricca convergenza di esperienze, fatte di riflessioni poetiche e filosofiche, e impegni professionali ben differenziati. L’attività accademica per esempio avvicina Lichtenstein allo studio dei grandi maestri, permettendogli di scoprire affinità, fra gli altri, con Monet o Picasso, e possibilità di elaborarne le tensioni in funzione del suo stile personale.
Gli aspetti percettivi e ricettivi dell’accostamento alla sua opera si mischiano con i segnali multipli dati dalla riproduzione a volte caricata d’ironia, o perlomeno d’understatement, delle parole da comics (Knock-Knock del 1975, da un disegno del 61), a loro volta intrecciati con un gesto capace di creare cortocircuiti fra freddezza – dei soggetti, dei materiali utilizzati, come la vernice Magna, o il Rowlux su acciaio – e suggestione emotiva, anzitutto nelle opere figurative citate in precedenza. In Lichtenstein nulla è lasciato al caso: la lacrima/metonimia corporale (con il ciuffo del capello biondo) di Girl with Tear III, olio e vernice Magna su tela del 1977 – sempre in prestito dalla Beyeler -, rimanda agli occhi-lacrima della madre in Guernica, e il taglio della colonna greca ci proietta in un déplacement spazio-temporale, una specie di buco nero fra percezione e interpretazione che inghiotte anche la metafisica dechirichiana. Un antipasto di tale prospettiva anche in Temple, serigrafia del ’64, anch’esso in mostra.

Tom Wesselmann, Smoker, 1971, vinile colorato su pannello, 144 x 160 cm Courtesy Flora Bigai Arte Contemporanea
Tornando al rapporto Cage-Lichtenstein, proprio il curatore Guadagnini mi indicava Allan Kaprow come possibile figura di contatto, e certamente un contatto vi è stato all’inizio degli Anni Sessanta, epoca in cui i due erano colleghi alla Rutgers University, a New Brunswick, non lontano da South Brunswick (siamo sempre nel New Jersey), dove George Segal portava avanti l’esperienza della Chicken’s Farm, frequentata da esponenti del movimento Fluxus, ma anche da Cage e perfino da Karlheinz Stockhausen. L’impressione è che piuttosto che dall’aspetto performativo Lichtenstein sia stato attratto (e in questo attragga a sua volta seduttivamente chi guarda la sua opera) dall’attitudine, diremmo, “contemplativa”. In a landscape, così come 4’33”, altra celebre composizione cageana, “fatta di silenzio”, non è frutto di un atteggiamento post-dadaista, ma integra strutturalmente la categoria-silenzio, la considera come elemento costruttivo del comporre. Un punto di vista che certo appare più vicino alle White Paintings di Bob Rauschenberg (del 1951, un anno prima della “silenziosa” pagina cageana) che a Lichtenstein, ma che a sua volta a quest’ultimo si avvicina proprio perché argomento e materiale dei lavori di Lichtenstein sembrano aspirare a un cupio dissolvi – tagliente, quasi beffardo – dell’interazione con l’opera, della pulsione verso di essa. Si potrebbe dire in conclusione che la possibile matrice in grado di accomunare questo importante dato poetico di Cage e Lichtenstein vada rintracciata nel Duchamp mondato dell’elemento dadaista. Lettura forse un po’ ellittica di questa bella mostra parmense, ma per nulla scontata.
Nel catalogo, edito da Silvana, ricchi contributi di Guadagnini, d’Argenzio, Bucci, e un utile profilo biografico di Avis Berman. In apertura Stefano Roffi ci ricorda l’idiosincrasia di Giulio Carlo Argan per la Pop Art, idiosincrasia viceversa estranea a Luigi Magnani, collezionista e padrone di casa della futura fondazione, per il quale, a parere di Roffi, è possibile vedere una qualche adiacenza nientemeno che con la pittura di Monet, ad esempio nella serialità del racconto pittorico in momenti differenti della cattedrale di Rouen dove il maestro francese «… riuscì a disincarnare gli oggetti dei suoi dipinti, incorporandovi i modi della percezione elaborati dai suoi occhi. »: un po’ quel che si diceva prima proprio per il pittore statunitense.
La mostra di Mamiano si aggiunge a buon diritto al già ricco curriculum espositivo italiano di Roy Lichtenstein. Alcuni precedenti, a memoria: Chiostro del Bramante a Roma a cavallo di millennio, Gam di Torino nel 2014, soprattutto Triennale di Milano nel 2010.
Luigi Abbate









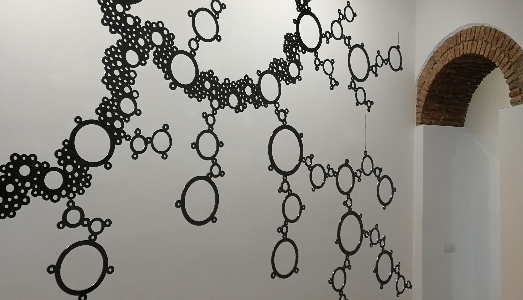


.jpg)


















