-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
THOMAS OLTRE LA SUPERFICIE
Personaggi
Strategie espositive, storia della fotografia, rapporti con la critica, rivoluzione digitale, universo delle immagini e altro ancora. Se n’è parlato con Thomas Ruff in occasione della sua mostra a Prato, curata da Pier Luigi Tazzi. E se parla in questa intervista...
lavori in contesti non propriamente artistici, sia a Prato-città che in alcuni
luoghi della provincia? Hai già fatto un’esperienza simile, un paio d’anni fa,
in Germania. Cosa ti interessa di questa strategia curatoriale?
Non so sinceramente… [ride]
È una scelta particolare, confrontata con le mostre che
abitualmente fai in gallerie, musei e fondazioni prestigiose…
Sì, credo sia semplicemente una questione di
divertimento: mostrare i lavori non all’interno del white cube, dove normalmente vengono fruiti, ma all’interno di
contesti alternativi, sebbene questi siano talvolta problematici. Il white cube è una sorta di luogo
sacrale, protetto, lo spettatore non ha distrazioni. Qui i lavori sono esposti
in uffici governativi, in biblioteche; mi interessa cosa pensano le persone che
lavorano lì o che visitano il posto.
Quindi ti interessa anche cosa ne pensano persone che non
sono normalmente coinvolte nell’arte contemporanea…
Sì. Un paio d’anni fa fui invitato dalla Deutsch Bank,
in Germania, che posizionò alcuni dei miei ritratti nella hall, alla destra
degli sportelli. Una volta incontrai un impiegato che mi disse: “Signor Ruff, abbiamo un sacco di problemi
coi nostri clienti, perché ogni volta, invece di tirare fuori i quattrini,
rimangono a fissare i suoi ritratti”. [ride]
Erano distratti dalle fotografie?!
Già…
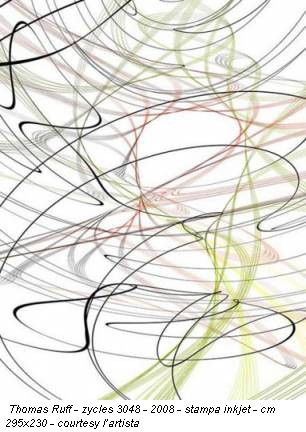 Parlando dei ritratti, trovo interessante la serie Andere
Parlando dei ritratti, trovo interessante la serie Andere
Porträts, in cui vediamo visi in bianco e nero sovrapposti a mo’ di
identikit. Molto spesso nella tua fotografia troviamo una sorta di dialettica
tra passato e presente, tra vecchie e nuove immagini. Per questo lavoro hai
usato la Minolta Montage Unit, un dispositivo analogico utilizzato dalla
polizia proprio per creare identikit, che di fatto però aggiornava, in chiave
tecnologica, la strategia sviluppata da Francis Galton intorno al 1880, la
cosiddetta “fotografia composita”. Forse possiamo trovare una connessione
simile con il passato anche nel più recente Zycles, lavoro in cui si
vedono curve digitali realizzate con il software Cinema 4D, curve che richiamano però da vicino le rappresentazioni
di Maxwell dei campi elettro-magnetici. Qual è il tuo interesse per questo
rapporto col passato e con la storia della fotografia?
Per prima cosa devo dire che tutta la mia fotografia è
estremamente autobiografica…
Cioè?
Deriva direttamente dalla mia vita, dalla mia
esperienza, da cose che ho visto e che mi hanno colpito, fatto arrabbiare o
altro. Reagisco a queste esperienze attraverso le immagini. Con Andere Porträts
volevo creare dei volti artificiali. L’idea venne nel 1994, Photoshop era già abbastanza avanzato,
ma non volevo realizzare queste immagini al computer poiché sarebbero risultate
troppo perfette. Mi interessava ottenere un’estetica un po’ démodé, probabilmente perché uno dei
temi su cui sto lavorando è anche la storia della fotografia, lo sviluppo delle
immagini e dell’immaginario in fotografia, quindi cerco sempre di riflettere
anche sulla storia delle immagini. Questa era la base di Andere Porträts:
realizzare doppi ritratti attraverso un unico scatto, che già di per sé è
abbastanza assurda come cosa. Così ho scoperto questa Minolta Montage Unit, lo
strumento perfetto per questo tipo di lavoro.
Come ne sei entrato in possesso?
Sono venuto a sapere che quest’apparecchiatura era
utilizzata dalla polizia, così ho scritto a diversi dipartimenti centrali. A Düsseldorf
ne possedevano una, e anche a Berlino, dove però l’avevano appena donata al
Museo della Polizia, così ho scritto al museo e ho domandato se potevano
prestarmela per un paio di mesi. Loro sono stati molto disponibili, ma alla
fine del lavoro l’ho dovuta restituire. Quindi ora è di nuovo al museo.
 È un po’ strano pensare che la tua fotografia sia fortemente
È un po’ strano pensare che la tua fotografia sia fortemente
autobiografica, dal momento che, soprattutto nella prima parte della tua carriera,
hai prediletto uno stile estremamente freddo e distaccato…
No, vedi, uno dei problemi è che la gente iniziò a
scrivere più sulla teoria e sull’aspetto concettuale delle mie fotografie
piuttosto che guardare le immagini. Così si pensò sempre che stessi lavorando
sulla superficie, e in tal modo quello che c’era dentro la fotografia
non era importante. Ma c’è qualcosa nella fotografia! Ci sono i
ritratti, in cui sono presenti i miei amici, gli interni, che descrivono gli
ambienti in cui sono cresciuto e vivevo, ci sono gli edifici che mi
circondavano, le fotografie dei quotidiani che sfogliavo ogni giorno…
Tutto quello che faceva parte della tua vita ordinaria…
Esatto. Poi, con Sterne [1989-92], dissero di nuovo:
“È un lavoro sulla superficie,
sull’immagine fotografica”. Ma la verità è che sono un grande appassionato
di cosmologia! La gente ha sempre scritto sulla superficie senza mai guardare
il contenuto delle immagini.
Senza guardare ciò che c’è oltre la superficie…
Bravo.
L’anno scorso è stato pubblicato il libro La scuola di Düsseldorf,
di Stefan Gronert. Per la prima volta si analizza questo famigerato movimento,
così spesso citato e chiamato in causa. Immagino che tu abbia lavorato assieme
a Gronert nella stesura dei testi e nella scelta delle immagini, quindi vorrei
sapere cosa ne pensi di questa scuola: esiste, è possibile parlare di una
scuola? Perché in alcuni casi questo movimento è quasi trattato alla stregua di
un genere fotografico…
Sì, infatti. Dunque, l’idea è venuta dall’editore,
Lothar Schirmer. Io subito gli dissi che mi sembrava un’idea stupida. Certo,
abbiamo tutti studiato a Düsseldorf, abbiamo tutti le nostre radici nella
cattedra di Bernd Becher, ma trovavo inutile fare ancora una mostra o un libro
su questa cosa. Lui sosteneva che questo era un libro funzionale al mercato
americano, perché un’etichetta semplifica le cose, tutti sono in grado di
contestualizzarti e quindi di seguirti.
Anche perché l’etichetta in questione venne proprio dagli
Stati Uniti, no?
In realtà mi pare che la prima a usare l’espressione “Scuola dei Becher” fu Isabelle Graw. Da
lì gli artisti furono tutti, ehm… schedati.
 Beh, non c’è dubbio abbia funzionato come definizione…
Beh, non c’è dubbio abbia funzionato come definizione…
Sì, certo. Le cose sono molto più semplici se hai
un’etichetta.
Lungo questi trent’anni di carriera ti sei progressivamente
spostato da uno stile freddo e distaccato, estremamente nitido (se vogliamo, proprio
lo stereotipo della Scuola di Düsseldorf), a un tipo di immagine più grezza,
incerta e a tratti disturbante. Seguendo quest’evoluzione, ti sei confrontato
in maniera massiccia con le tecniche digitali. Come consideri il digitale?
Alcuni sostengono che si tratti di una vera e propria rivoluzione, che cambierà
il corso della fotografia, altri invece credono sia semplicemente un mezzo
tramite il quale ottenere in maniera più semplice gli stessi risultati che una
volta si ottenevano in camera oscura…
Inizialmente pensavo che il digitale in fotografia
fosse solo un nuovo strumento, come un nuovo obiettivo o una nuova pellicola.
Questo era quello che pensavo nel 1996, quando realizzai al computer la serie Plakate,
visto che all’epoca quello era il modo più semplice per costruire fotomontaggi.
Oggi, nel 2010, posso dire che dal 1977, quando iniziai con la fotografia, c’è
stato un enorme sviluppo delle tecnologie fotografiche, non solo per quel che
riguarda il medium in sé, ma soprattutto per quel che concerne l’uso che si fa
delle immagini.
Il contesto in cui si fruiscono, anche…
Certo, anche il contesto. Questi cambiamenti così
radicali, pensavo dovessero influenzare il mio lavoro e diventarne parte. In
tal senso, jpeg [2004] non è solo un lavoro sull’aspetto formale che
hanno oggi le immagini, ma anche sulla loro distribuzione tramite internet, su
come le persone oggi guardano le fotografie: sempre più sul monitor del
computer, piuttosto che sulla parete. Probabilmente tutto è iniziato con Nudes
[1999], quando mi sono reso conto del tasso di voyeurismo e
contemporaneamente di esibizionismo presente in internet, dove il marito
fotografa la moglie e la mostra a tutto il mondo attraverso un sito.
La pornografia, tema centrale di Nudes, rappresenta
forse una sorta di paradigma in grado di riflettere su una condizione più
generale…
Sì, in un certo senso sì.
![Thomas Ruff - Porträt [A. Siekmann] - 1987 - stampa cromo genica - cm 210x165 - courtesy l’artista](https://www.exibart.com/foto/77707.jpg) In effetti, hai lavorato molto con immagini preesistenti,
In effetti, hai lavorato molto con immagini preesistenti,
quasi sempre non appartenenti alla sfera artistica: immagini scientifiche,
pornografiche, tratte da quotidiani, da fumetti, scaricate da internet ecc. Ci
sono alcune teorie secondo le quali, nella cultura occidentale, le immagini
fungerebbero da schermi protettivi, barriere che filtrano la realtà esterna
creando un surrogato di esperienza, al riparo da traumi. Kevin Robins, ad
esempio, pubblicò in proposito un testo interessante nel 1996, intitolato Oltre
l’immagine. In fondo sono questioni sollevate già negli anni ‘70 da Susan
Sontag e, prima di lei, da Italo Calvino e Walter Benjamin. Che opinione hai in
merito?
Penso che tutto dipenda da chi guarda le immagini e
dallo spirito con cui le guarda. Ognuno di noi ha uno sguardo differente, una
vita e un bagaglio di esperienze diverse, e reagisce alle immagini solo a
partire da questo background soggettivo. È qualcosa di molto personale, e
indubbiamente di culturale. Certo, esiste una sorta di “modo occidentale” di
intendere e utilizzare le immagini – come descrivono queste teorie – che
indubbiamente sta dominando e ha dominato. Ma credo che tale modalità finirà
presto.
In che senso?
Voglio dire, l’Occidente in sé è vicino al collasso. E
con esso il suo imperialismo e il suo immaginario. Non credo che il modello
occidentale sia il migliore o vada bene per tutti, com’è evidente da quanto sta
accadendo. Tantomeno lo si può imporre. Qualunque cosa, come anche la cultura e
l’arte, dev’essere una scelta: devo essere libero di dire “sì”, oppure “no,
grazie”.
La
recensione della mostra
La videorecensione della mostra
a cura di gabriele naia
dal 16 ottobre all’undici dicembre 2010
Thomas Ruff – Prato 16.10-11.12/2010
a cura di Pier Luigi Tazzi
Sedi varie – 59100 Prato
Ingresso libero
Info: tel. +39 0574604939; info@dryphoto.it; www.dryphoto.it
[exibart]




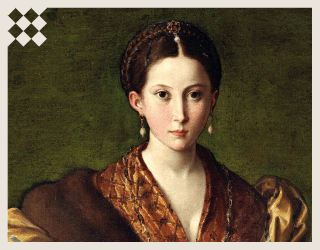























foto inappropriata per un portale d’arte
gentile pusco,
quella non è una foto ma un lavoro di thomas ruff, peraltro appartenente a una serie piuttosto nota. e mi pare che il signor ruff faccia ben parte del mondo dell’arte.
ma quale arte… troppo facile, è una sconcezzza!
oh mon dieu, chiamate il confessore, mi si è arrossita anche la veletta!
Concordo con il lettore precedente riguardo la non adeguatezza dell’immagine precendente per una larga diffusione. Anche noi alla Gamec abbiamo incontrato problematiche simili.
“l’origine du monde” di courbet è del 1866.
Alla vista della vulva anche il diavolo scappa…
Concordo con m.e.g. e francesco sala. E riguardo la larga diffusione, la vagina appartiene al 50% dell’umanità, più diffusa di così.
roba ridicola e scontata, atta a scandalizzare giusto qualche suorina, il lavoro sull’11 settembre è di una retorica devastante, poi l’accostamento antico-contemporaneo è una forzatura altrettanto più scontata…e non è che uno critica perchè su exbart si critica per criticare, questa operazione è veramente brutta, non è la solitata tiritera.
Si continua all’infinito a proporre immagini e forme, ampiamente superate e veicolate già dai media. Non hanno nessuna resa sulle coscienze, perchè si presentano decontestualizzate e alienate nel luogo comune del potere.
Una mostra sull’ovvietà. Immagini banali, finte e ritoccate, in una mimesi di una realtà artificiale, sconosciuta, in cui il volto multiplo e mostruoso del potere, non viene affatto fuori, in tutta la sua anonima irrazionalità. Semplicemente, foto digitali ritoccate. Non sono neanche scandalose, ma mimesi dell’ovvietà ddella cronaca quotidiana. Mostra brutta. Meglio le immagini in movimento del cinema e della TV.
Il mondo è pieno di vulve, che ci voleva Ruff per farcela vedere. Un artista dedito alle banalità quotidiane che non ha niente da raccontarci. Mi meraviglio di critici e curatori che gli stanno dietro. Inconsapevolmente giustificano un linguaggio costituito di luoghi comuni.
Oltre la superficie… una mattonata di immagini patinate.
It is difficult but I have no other option.
a me Ruff piace
la mostra è stupefacente come l’ignoranza dei commenti che mi precedono, scritti senza aver visto la mostra, evidentemente da gente che l’arte la fruisce così, al computer.