-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
L’intervista/Maïmouna Patrizia Guerresi La fotografia dello Spirito
Personaggi
Prima si chiamava solo Patrizia Guerresi. Dopo la conversione all'Islam, Maïmouna Patrizia Guerresi. Autrice di scatti molto elaborati, ma anche di sculture e installazioni che tentano di unire "la bellezza formale e cosmica all'etica della religione islamica". Tracciando un percorso dove la vita personale si fonde a quella professionale. Ora, questa fotografa sui generis, è a New York e sta per intraprendere un lungo tour indiano
Monteforte d’Alpone (Verona), 21 luglio 2012. Tra le colline morbide della terra di Soave, appena fuori dal centro storico di Monteforte d’Alpone, c’è la casa di Maïmouna Patrizia Guerresi (Pove del Grappa, Vicenza 1951). Una solida villetta su due piani degli anni ’60, in cui il lungo corridoio separa gli ambienti notturni da quelli diurni. Il lavoro entra in maniera preponderante nella sfera privata di Patrizia Guerresi, che dal 1991 – dopo la conversione all’Islam – ha adottato il nome di Maïmouna. Le sue giornate cominciano con le abluzioni di rito e le preghiere, all’insegna del motto “ora et labora” dei frati benedettini, che è anche alla radice del muridismo. “Lavora come se non dovessi vivere sempre” – diceva lo Cheick Ahmadou Bamba, fondatore nel 1883 della confraternita sufi dei Muridi (e quattro anni dopo della città santa di Touba in Senegal) – “e prega come se dovessi morire domani”.
Forse è anche per questo che l’intera abitazione è adibita a studio. Il deposito è al piano terra, con le “Kunta” di terracotta, i tessuti “wax printed”, i cappelli-minareto usati nel video Zuhd 53 (2010). Al primo piano, abbattuti i tramezzi della sala da pranzo/salotto, è sorta la sala posa con i due fondali pronti per l’uso – uno bianco e l’altro nero – le luci e il cavalletto per la macchina fotografica. Anche il muro esterno, di fronte al capannone, ora dipinto di verde, bianco e rosso (ma è casuale il riferimento alla bandiera italiana) è un altro elemento fondamentale dei suoi set fotografici. Lei stessa torna a dipingerlo e a scrivere le parole in arabo, che fanno spesso parte dei suoi lavori, presenti anche nei titoli delle opere e delle mostre: ahwal (stati dell’animo), gallaya (bollitore), haqiqat (illuminazioni)…
Unica artista italiana ai Rencontres de Bamako 2009, Maïmouna Patrizia Guerresi fonda la sua poetica intorno al corpo umano, inteso come corpo religioso e mistico, che inserisce in una ricerca che aspira al superamento dei confini delle diversità.
In corso la collettiva Piping Down the Valleys Wild alla Stux Gallery di New York (fino all’8 settembre), mentre l’impegnativo tour indiano della personale Inner Space, organizzata da Tasveer, partirà da Aquarium – National Institute of Design di Ahmedabad (10-19 agosto), per proseguire al Centro Culturale Italiano di New Delhi (18-28 ottobre), alla Tasveer Gallery at Sua House di Bangalore (4-25 gennaio 2013), alla Seagull Foundation for the Arts di Calcutta (15-26 marzo 2013) e concludersi a Mumbai nell’aprile 2013. Ecco quello che ci dice.
Eri già un’artista apprezzata, di matrice concettuale fortemente legata alla Body Art (partecipazioni alla Biennale di Venezia, Documenta e altre rassegne internazionali) quando, tra il 1989 e il 1991, avviene una svolta decisiva nel tuo percorso personale e professionale. Cosa ti ha portato in Africa?
«Intanto bisogna spiegare qualcosa del mio percorso precedente. Ero presente nel contesto della Body Art già dalla fine degli anni Settanta, ma quello che cercavo erano soprattutto le radici storiche dello sviluppo del corpo e delle simbologie. Ero attrice-protagonista e, nello stesso tempo, opera. Cercavo di avere un contatto cosmico con l’universo. Nelle mie performance mi presentavo come un albero che faceva da medium tra cielo e terra. Quindi una Body Art che non era intesa come sofferenza, come invece era rappresentata in quel momento. In altri lavori mi sono identificata soprattutto con Dafne, sviluppando l’idea della metamorfosi, che è continuata nei lavori successivi. Anzi, è stata determinante in quelli che avevano tematiche religiose o mitologiche. Quanto all’Africa, prima di avere questa conoscenza speciale, facevo già delle opere con figure africane e avevo anche una certa familiarità con questo Continente. Da parte di madre, infatti, provengo da una famiglia cattolica molto religiosa, addirittura bigotta, con uno zio missionario che ha trascorso la vita in Burundi e Rwanda e una zia suora. Per cui, fin da piccola, ero circondata da personaggi africani che frequentavano la grande casa che avevamo a Bassano. In qualche modo era naturale questo mio incontro con l’Africa religiosa, anche se da artista e ribelle non mi sono mai assoggettata ai vari comandi della famiglia. Inoltre, avrei sempre voluto andare in Zaire, e poi nel Burundi, a trovare mio zio, senza però essere mai riuscita a partire. Il destino ha voluto che conoscessi un’Africa musulmana incontrando, in Italia, Sherif Assane Dieye che mi ha introdotta all’Islam e, successivamente, è diventato mio marito e il padre di mia figlia Adji. Una conoscenza che ho approfondito con i frequenti viaggi in Senegal, recandomi ogni volta nella città Santa di Touba».
Cosa ti ha affascinato del muridismo della comunità di Baifall, confraternita sufi, tanto da farti convertire all’Islam?
«La fede islamica mi ha affascinato per la sua straordinaria forza interiore. Una fede che mi ha aiutata, e mi aiuta tuttora, a comprendere tanti perché. In Italia ho fatto il rito della Shahadah, che è la professione del rito islamico e ho ricevuto il nome di Maïmouna, che è sia quello della madre di mio marito – un nome comune in famiglia – sia quello della mia madre spirituale, che è molto famosa in Senegal ed è venerata anche da molti uomini. Quello che mi è sempre piaciuto in questa parte di Islam, che è quella sufi, e in generale dell’Africa, è che la donna è forte, non è sottomessa. Comunque, la mia decisione ha prodotto un cambiamento di vita e di prospettiva del lavoro. Una jihad, uno sforzo per far capire agli altri come sono. Concettualmente, quello che mi interessa, è poter rappresentare la bellezza formale con l’etica della religione islamica, cercando di esaltare le similitudini tra le culture, piuttosto che le differenze».
L’uomo come punto di partenza per guardare al divino, soprattutto quando sono presenti “i giganti”: corpi femminili e maschili raffigurati nella loro tensione ascensionale come architetture gotiche, ma allo stesso tempo “alleggeriti”, svuotati di una parte della materia. È in atto la dualità platonico/cristiana corpo/anima o ci sono altre implicazioni?
«I Giants o “giganti” nascono come ricerca sul corpo mistico, inteso come metafisico e sovrannaturale, che è rappresentato da un manto che copre i miei personaggi, segnando le forme e lasciando scoprire i volti, i piedi, le mani, come nelle icone cristiane. Mi rifaccio chiaramente ad artisti come Piero della Francesca e Antonello da Messina. Il corpo, però, è vuoto. È come un universo, qualcosa di buio, una grotta. Un vuoto che è misterioso e, allo stesso tempo, evoca la paura del diverso. Qualcosa che spaventa perché non si conosce. L’idea è quella di attirare lo sguardo dell’osservatore creando questo tipo di tensione. Ma i volti dei personaggi sono rassicuranti».
Parlavi di mantello che, nell’iconografia cristiana, evoca l’immagine della Madonna della Misericordia. Nella tua trasposizione in chiave africana, questo indumento diventa non solo protettivo e regale, ma segno di appartenenza e identità…
«Sì, certamente il riferimento della mia cultura è classico-canoviana, con questa matrice di purezza e sintesi. Di Piero della Francesca, ad esempio, mi ha sempre colpito la parte metafisica, che è importante anche nell’Islam e nel mio modo di esprimermi. È una linea che continua. Tra l’altro la prima figura nera che ho realizzato, riprendendo la rappresentazione del mantello, è quella di Fatima con un grande manto vuoto. Fatima appartiene a due culture, è una figura santa contesa da due religioni, i musulmani sciiti e i cristiani. Una rappresentazione della pietas che rimanda, ancora una volta, al vuoto e a qualcosa di sconosciuto».
Simbolo e metafora sono elementi fondamentali per esplorare le complesse implicazioni del termine “diversità” in ambito sociale, politico, culturale, psicologico. Qual è, secondo te, la forza di questi strumenti che utilizzi non tanto per provocare quanto per stimolare la riflessione?
«Ai personaggi che fotografo impongo segni prevalentemente bianchi, quelli neri li ho usati solo per un video. Il bianco è un elemento di purificazione, che indica personaggi di luce. Realizzo una specie di impasto con latte e colore e traccio una riga bianca sul volto, sulle mani e, a volte, sui piedi, ovvero sulle parti visibili del corpo. Questa linea diventa come una bisettrice – una frontiera – che taglia in due la parte conosciuta e quella sconosciuta. Un segno particolare che mi è venuto in mente partendo proprio dall’idea del latte, usato in diverse culture, asiatiche e africane, come simbolo di purificazione, ma anche del primo sacrificio. Il “sacrificio bianco” è quello del dare il latte materno. Il manto è l’altro segno ripetuto spessissimo nei miei lavori, insieme al velo, perché mi interessa indagare la spiritualità, soprattutto femminile. Un anno fa, a Bologna, ho intitolato una mia mostra il “Poema del Mantello”, ispirandomi alla poesia di carattere taumaturgico del poeta sufi al-Busiri che, come molte poesie religiose della letteratura islamica, è stata scritta in onore del profeta Mohammed. La sua caratteristica è che, se ripetuta, porta alla guarigione. Nei miei lavori la ripetizione continua del manto e del velo è, per me, come un mantra, una formula di incantamento, una preghiera taumaturgica, un dhikr. Credo che il richiamo al pudore, alla bellezza e al mistero divino sia come un manto interiore che esprime la bellezza cosmica».
Nel tuo lavoro la sfera privata confluisce spesso in quella artistica. A cominciare dalle tue modelle, le tue figlie Adji e Marlene. Trovi che sia complicato riuscire a conciliare questi aspetti?
«Non credo. The Sisters è una serie fotografica che ho realizzato tra il 2001-2004, che nasce proprio da una mia esigenza personale. Intanto, perché le protagoniste sono le mie due figlie, avute da mariti diversi, appartenenti a religioni e nazioni differenti. Il lavoro è un incontro, una metafora di due mondi diversi che entrano in contatto e cercano di dialogare in un ambiente familiare. Ho rappresentato le mie figlie in un momento intimo della loro vita. Una è velata, l’altra indossa un manto. Dietro queste figure c’è la Grande Madre, che in questo caso sono io, oppure la figura metaforica che unisce, con la misericordia, i due mondi rappresentati – appunto – dalle religioni differenti».
Da sempre utilizzi materiali e tecniche diverse, dalle sculture di terracotta, resina, bronzo alla fotografia e al video. Spesso si tratta di installazioni in cui c’è un dialogo serrato tra le immagini fotografiche (stampate in grande formato) e gli oggetti del quotidiano – babouche, spazzolini da denti, tappeti da preghiera, filoni di pane – che trovano l’immortalità attraverso il medium dell’arte. C’è, tuttavia, un linguaggio che senti appartenerti più degli altri?
«Ho cominciato con la fotografia, quando lavoravo nell’ambito della Body Art e, successivamente, ho provato la scultura. Per un certo periodo della mia vita ho curato molto anche la modellazione, perché mi piaceva il rapporto diretto con la materia. In seguito ho portato avanti sempre l’idea del calco scultoreo che, come nella fotografia, è l’attimo in cui si prende qualcosa di reale e lo si trasforma nella memoria di quello che era. Un oggetto che è la mimesis del reale. Nelle mie babouche, ad esempio, non c’è nulla di reale. Non le prendo così come sono e le dipingo. Mi sentivo stretta nella definizione di scultrice, infatti lavoravo anche – e lo faccio tuttora – con la fotografia e il video. Il mio desiderio è sempre stato quello di creare un linguaggio più circolare interagendo con le diverse tecniche».
L’uso di determinati programmi informatici ti permette di manipolare il soggetto. Ma questa non è che una delle fasi del lavoro, preceduta dalla costruzione del set e dalla messinscena in cui realizzi personalmente dai costumi agli scenari. Il fondale è affidato al disegno o alla pittura che stendi sempre sullo stesso muro. È evidente il collegamento alla tradizionale ritrattistica di studio africana – da Malick Sidibé a Samuel Fosso – ma nella tua narrazione c’è un azzeramento degli elementi accessori. In questo processo come si colloca il momento dello scatto?
«In quest’ultimo periodo lavoro molto con il digitale, ma prima ho sempre fotografato su pellicola. Preparo da me tutti i fondali, cambiandoli continuamente. Poi la postura, la posizione della mano, del volto e dello sguardo, sono le caratteristiche principali che determinano lo scatto fotografico. Senza dubbio il mio lavoro si differenzia da quello di Malick Sidibé e Samuel Fosso, che ho avuto il piacere di conoscere e con i quali ho anche partecipato a mostre collettive. In comune c’è, forse, l’utilizzo del fondale, che per me però diventa un momento pittorico, quasi materico, in cui impiego materiali particolari – lucidi o opachi – che sono evidenti nelle fotografie. Ci sono anche le scritte e, alcune volte, intervengo disegnando delle architetture, come nella serie ispirata a Giotto. Faccio tanti scatti, finché non mi convincono».
Il tuo approccio all’arte è molto istintivo, ma c’è anche una metodicità nella realizzazione dei progetti?
«Ho disegni e appunti sparsi dappertutto, ma quando ho un’idea ho fretta di realizzarla. Preparo magari il bozzetto e procedo realizzando i costumi e tutto il resto. Però, mi può capitare di dover rifare un costume per tre volte, finché finalmente funziona!»




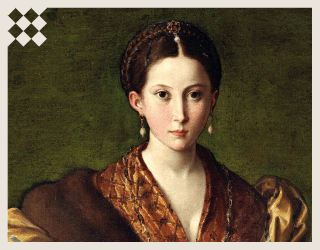























per avere la newsletter