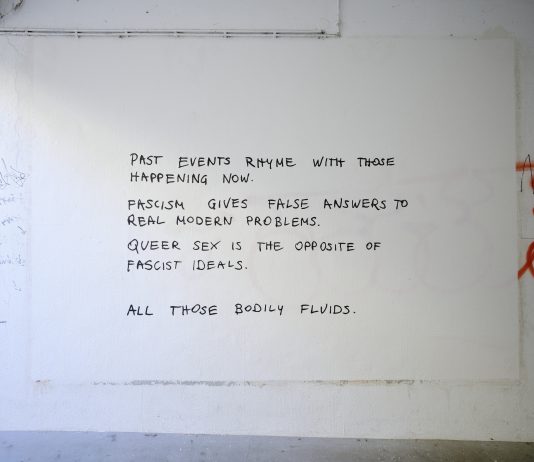-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
Stranieri sempre, per riappropriarsi di se stessi: intervista all’artista Francis Offman
Arte contemporanea
In occasione della sue mostra al Secession di Vienna, intitolata Weaving Stories e visitabile fino al 31 agosto 2025, Francis Offman racconta la sua pratica artistica, specchio della sua esistenza “in between”, tra un’identità ibrida di straniero in patria e le conseguenze di un passato coloniale nella società contemporanea. Le opere sono storie intessute grazie a materiali epifanici, come i fondi di caffè o le garze di cotone, che hanno l’abilità di svelare la memoria che l’artista amalgama tra due Paesi: il Ruanda e l’Italia.

Nella mostra Weaving Stories presso la Secession di Vienna presenti opere (tutte untitled) su tela non intelata, realizzate con fondi di caffè, garze in cotone e gesso bolognese. Cosa rappresentano metaforicamente questi tre materiali, così inconsueti ma centrali nel tuo linguaggio visivo?
«I materiali che uso non sono mai neutri: sono memorie, tensioni, gesti. Il caffè è un ponte. L’ho cominciato a usare dopo aver aperto l’ultimo pacco che mia madre mi aveva portato dal Ruanda. Da lì è diventato pigmento, voce, traccia. È intimo ma anche storico: parla di affetti, di viaggio, di economie post-coloniali. Un tempo, in Rwanda si coltivava solo per l’esportazione, oggi invece si è tornati a berlo, a farne cultura quotidiana. Questo passaggio mi interessa: è una forma di riappropriazione.
Le garze in cotone sono arrivate in studio durante la pandemia. Recuperate da kit medici scaduti, sono materiali fragili, pensati per curare. Portano con sé la memoria della ferita, ma anche del gesto che prova a riparare. Ogni frammento è un ricordo cucito.
Il gesso bolognese mi lega alla tradizione italiana, alla storia della pittura fatta a mano, lentamente. Prepararlo da sé è un modo per tornare a un tempo umano, artigiano, e per sottrarsi alla logica dell’efficienza. È il mio modo di stare, anche silenziosamente, dentro la pittura.
Insieme, questi materiali costruiscono un linguaggio che stratifica biografia, geografia, economia e intimità. Studiarne le origini e i contesti è anche un modo per educarmi, per comprendere da dove arrivano e cosa portano con sé. Non rappresentano: evocano. Come la pittura, dicono senza spiegare. Restano aperti».


Quanto ha influito lo studio in Accademia a Bologna nell’apprendimento delle tecniche degli antichi maestri del Cinquecento e nella sua messa a punto? La tradizione appresa in Italia va di pari passo con quella africana che ricerchi?
«Lo studio all’Accademia di Bologna è stato per me un passaggio fondamentale: lì ho affinato una grammatica pittorica solida, grazie soprattutto al confronto diretto con le tecniche dei maestri del Cinquecento. Ma non ho mai vissuto quella tradizione come un modello da replicare. Al contrario, l’ho sempre considerata una base da interrogare, mettere in discussione, contaminare con il presente. Già prima dell’Accademia passavo ore a studiare, quasi ossessivamente, i condition report dell’arte antica. Volevo capire come si comportano i materiali nel tempo: come invecchiano, si alterano, resistono o cedono. Una volta acquisita quella consapevolezza, ogni tecnica e ogni superficie diventano elementi da decostruire e ricomporre secondo le necessità del gesto, della visione, del tempo.
La mia ricerca nasce da una tensione profonda: l’Italia mi ha dato gli strumenti, il Ruanda le domande. La pittura è per me un luogo di stratificazione, dove gesso e cemento convivono con il caffè usato come pigmento; dove i materiali non sono semplici mezzi, ma portatori di genealogie, memorie, frizioni. Le tradizioni europee e africane non si fondono mai del tutto: si sfiorano, si disturbano, si interrogano a vicenda. È in quello spazio di attrito o forse di sospensione che prende forma il mio lavoro».

Tu sei nato a Butare (Ruanda) e sei immigrato in Italia a causa del genocidio negli anni ‘90. Hai deciso di non richiedere la cittadinanza italiana, sebbene tu ci abbia vissuto ormai quasi 30 anni. Hai deciso di rimanere straniero volontariamente, anche come forma di rivendicazione e testimonianza. Quanto incide questa condizione nella tua ricerca artistica?
«La mia scelta di rimanere straniero in Italia incide profondamente sulla mia ricerca artistica. È una posizione che mi permette di osservare e raccontare la realtà da un punto di vista sempre “altro”, mai del tutto integrato. Questo stato di sospensione, di non appartenenza piena, diventa una lente attraverso cui esploro temi come l’identità, la memoria e il dialogo tra culture. Non prendere la cittadinanza è anche un modo per testimoniare la complessità dell’essere migrante, trasformando la mia esperienza personale in un atto politico e poetico che si riflette nelle mie opere.
La mia vera casa e dentro di me li resto e un susseguirsi costrutti sociali con conseguenze inimmaginabili sulla gran parte della popolazione. La migrazione ha profondamente segnato il mio senso di identità e appartenenza. Mi ha insegnato che l’identità non è qualcosa di fisso, ma un percorso in continua evoluzione. All’inizio mi sentivo sospeso tra due mondi: da una parte le radici, la cultura e i valori della mia famiglia; dall’altra, la necessità di adattarmi a un nuovo contesto, con nuove regole e abitudini.
Con il tempo, ho imparato a vedere questa doppia appartenenza come una ricchezza, non come una mancanza. Ho capito che posso essere fedele alle mie origini senza rinunciare a crescere e a integrarmi. Oggi sento di appartenere a più luoghi e culture, e questa complessità è diventata la mia forza e la mia unicità. La mia dimora è interiore. Là abito, mentre il mondo esterno è teatro di costrutti sociali che, come onde, travolgono inconsapevolmente la maggioranza».


Nell’intervista con Carolyn Christov-Bakargiev dici che l’arte per te “It’s anything that makes you wonder, and for a moment, you stop thinking about yourself”. Sottolinei così una forma di individualismo generalizzata ma soprattutto che l’arte incita a porci delle domande. Quali sono le questioni (anche a livello macro) che vorresti fossero problematizzate dal pubblico?
«Quando dico che l’arte è “anything that makes you wonder, and for a moment, you stop thinking about yourself”, intendo proprio questo: un’interruzione. Un piccolo blackout dell’ego, che apre spazio a domande più grandi. Vorrei che il pubblico si interrogasse su ciò che normalmente non guarda: da dove vengono le cose? Chi le ha toccate, prodotte, scartate? Cosa lasciamo dietro nel nostro passaggio?
Uso materiali umili: fondi di caffè, garze, gesso perché portano con sé geografie, economie, traumi. Parlano di consumo, memoria, disuguaglianza. Ma non illustrano nulla: pongono. Restano aperti. Non offro risposte. Il mio desiderio è che l’opera attivi uno sguardo più ampio, che ci faccia sentire parte di qualcosa di condiviso. L’arte non risolve, ma può spostare: anche solo di un millimetro. E a volte, basta quello».

Oltre alle tele hai esposto un’installazione consistente in una tela di grandi dimensioni e dei libri sospesi a pochi centimetri dal suolo con una sorta di pinze che nel passato venivano usate per misurare le parti del corpo in Ruanda per la categorizzazione delle persone in una razza. Potresti raccontarci la genealogia del lavoro?
«La genealogia di questo lavoro nasce da una riflessione profonda sulla storia personale e collettiva del Ruanda, intrecciata con la mia esperienza di migrazione e di incontro con altre culture. L’installazione a cui ti riferisci mette in dialogo una tela di grandi dimensioni con una serie di libri sospesi, ciascuno sorretto da calibri: strumenti che, nel passato coloniale ruandese, venivano utilizzati per misurare parti del corpo e classificare le persone secondo categorie razziali arbitrarie e violente. Questi calibri sono diventati, per me, simboli di una misurazione del valore umano che ha segnato tragicamente la storia del mio paese.
I libri, le cui copertine sono celate da uno strato di caffè, rappresentano sia la trasmissione della conoscenza che la sua possibile occultazione o manipolazione. Il caffè, materiale ricorrente nel mio lavoro, è scelto non solo per il suo legame con la mia terra d’origine – il Ruanda, grande produttore di caffè – ma anche per la sua storia di merce coloniale, attraversata da rotte di sfruttamento e scambio. L’utilizzo dei fondi di caffè, raccolti e lavorati artigianalmente, è un modo per riattivare la memoria di queste rotte e per riflettere sulle stratificazioni culturali e materiali che attraversano ogni oggetto, ogni materia che impiego.
La scelta di materiali recuperati o donati – carta, cemento, gesso, fondi di caffè – nasce da un’etica del riuso, del dono, della cura: ogni elemento porta con sé una storia, spesso fatta di relazioni, scambi, talvolta anche di violenza o privazione. L’installazione, quindi, si costruisce come mappa di viaggi e attraversamenti, tra Africa ed Europa, tra passato coloniale e presente migrante, tra memoria individuale e memoria collettiva.
Il gesto di sospendere i libri a pochi centimetri dal suolo, trattenuti da strumenti di misurazione, vuole evocare una tensione irrisolta: tra il desiderio di conoscenza e la sua repressione, tra la leggerezza della sospensione e il peso della storia. La genealogia di questo lavoro è dunque un intreccio di biografia, storia coloniale, pratiche di riuso e riflessione critica sugli strumenti materiali e simbolici che definiscono il valore delle persone e delle cose. In questo modo, la mia pratica cerca di trasformare materiali e simboli di esclusione in occasioni di dialogo, memoria e apertura, restituendo dignità a ciò che era stato scartato o dimenticato».

Pensi che in futuro resterai più vicino alla tela o spazierai di più nell’utilizzo dell’installazione ed altri media?
«Credo che la mia pratica rimarrà sempre vicina alla pittura, ma non nel senso di una fedeltà esclusiva alla tela tradizionale. Per me la pittura è un linguaggio aperto, capace di assorbire materiali, storie e incontri: lavoro spesso con elementi che mi vengono donati, che hanno vissuto altre vite prima di arrivare nello studio, e che portano con sé relazioni e narrazioni.
Negli ultimi anni ho sperimentato molto, integrando materiali come il cemento o il caffè, e questi gesti sono già una forma di espansione del quadro, una sorta di installazione intima e condivisa. Tuttavia, non sento il bisogno di forzare il passaggio verso altri media solo per aderire a una tendenza. Piuttosto, mi interessa imparare tecniche nuove che mi permettano di andare un passo oltre, senza ideologie, ma con una curiosità pratica e una forte attenzione al contesto e al dialogo con le persone e i luoghi che incontro.
Se il lavoro mi porterà verso l’installazione o altri media, sarà perché il percorso lo richiederà in modo naturale, non per una scelta di campo. La mia ambizione è che il mio linguaggio rimanga poroso e permeabile, capace di accogliere ciò che arriva, ma sempre con la pittura come centro di gravità, anche quando questa si apre e si trasforma».