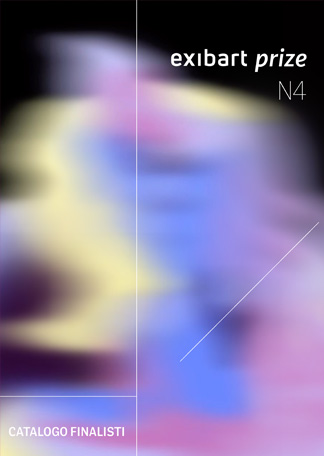-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
Il racconto della Biennale di Dakar: la quindicesima edizione è un invito collettivo al risveglio
Arte contemporanea
Infine è arrivata la Biennale di Dakar, dopo essere stata rimandata all’ultimo momento in maggio. In corso fino al 7 dicembre, prende il titolo di The wake. L’éveil, le sillage, xàll wi e si riferisce al risveglio delle coscienze, all’autodeterminazione, al recupero identitario o meglio alla presentazione forte, sicura, disinvolta della propria identità di fronte al mondo. Curata da Salimata Diop presenta 58 artisti africani e della diaspora nel Vecchio Palazzo di Giustizia. E proprio nella metamorfosi del luogo sta la novità di questa Biennale rispetto alle due precedenti. L’enorme palazzo costruito dai francesi nel 1957 e lasciato in stato di abbandono dal 1992, è stato il teatro di processi che fanno parte della memoria collettiva del popolo senegalese. Già utilizzato per festival ed esposizioni a partire dal 1966, è diventato il luogo principale della Biennale a partire dal 2016. Ma mai come in quest’ultima edizione, il luogo era stato sfruttato nella sua tentacolare struttura. Sono state aperte delle nuove ali, recuperati giardini che sono stati utilizzati per ampliare e articolare l’idea di Biennale.

Il piano terra e il primo piano che corrono attorno al cortile principale accolgono la mostra di Diop con i 58 artisti, che a loro volta presentano tre punte di diamante che animano il percorso. Nella sala di giustizia principale si distingue la grande testimone della Biennale, Wangechi Mutu e il suo Palais en morceaux, che iscrive con la terra sul pavimento estratti dalla poesia Prière pour la Paix del primo presidente del Senegal e poeta Léopold Sédar Senghor, mentre sui luoghi dei banchi laterali della corte, macabri vassoi sono popolati da piccole mani mozzati in riferimento alla guerra del Congo, l’installazione è accompagnata da due video con il tema del riscatto femminile.

Gli altri due saloni di punta sono occupati dall’opera video di Hicham Berrada e dalla videoinstallazione provocatoria di Majida Khattari. Dal cortile principale si dipartono due corridoi che portano alle nuove stanze e giardini recuperati per questa Biennale: in quello di sinistra vi è l’omaggio all’artista storica e pioniera della pittura su vetro Anta Germaine Gaye, mentre lungo l’altro corridoio ci si inoltra nella sezione della mostra On s’arrêtera quand la Terre rugira co-curata da Cindy Olohou, Marynet J., Kara Blackmore che incorpora opere con tematiche ecologiche, d’impatto è la ragnatela di fili di cotone, con evidente rimando allo sfruttamento degli schiavi di Leïla Adjovi, già gran premio della Biennale del 2018. Dal cortile si diparte un terzo corridoio che porta ad una sezione di arti applicate africane suddivisa interior design, tessuti e moda. La Biennale così presenta in modo comprensivo un po’ come una vetrina la produzione del design.

Tutta la presentazione delle opere in generale è stata concepita con una scenografia coerente con il progetto di Clémence Farrell che ha lavorato di concerto con Diop. La mostra infatti è suddivisa in quattro capitoli: Nuotare nella veglia, Immergersi nella foresta, Volare tra le nuvole, Bruciare e ciascuna sezione ha un colore e degli effetti particolari che ne sottolineano il tema e accompagnano lo spettatore in un viaggio immersivo. Sono stati creati anche dei momenti di accoglienza per lo spettatore, soprattutto il bar del cortile principale che funziona come luogo di relazione, mentre c’è anche un bookshop in embrione più che altro per la vendita del catalogo (lussuoso e costoso) e di alcuni libri di riferimento.

Nel Musée des civilizations noires si sviluppano tre padiglioni: quello dell’Isola di Capoverde, degli Stati Uniti e del Senegal dove si trova uno dei premiati di quest’anno con una specie di grande arazzo di materiale di riciclo, Manel Ndoye. Il Gran Premio è stato dato all’artista della Martinica Agnès Brézephin per la sua commovente opera con riferimenti autobiografici dolorosi composto da un corpo trasparente in filo di ferro e gesso contenente i rocchetti dei fili di seta, che conservano il senso della processualità della memoria e della cura che conduce alla guarigione. Gli altri premi sono stati ottenuti da Sonia Barret per la sua doppia opera, una riguardante una cartografia immaginaria negoziata attraverso il gesto partecipativo di costruire grandi trecce tentacolari sospese tra le colonne, mentre l’altra riconfigura le nuvole attraverso l’uso dei capelli crespi. La riconfigurazione dell’idea del ritratto a partire da elementi distribuiti su piani diversi caratterizzano un ulteriore premio dato Dior Thiam, mentre scontato appare l’ultimo premio dato all’installazione con i passaporti di Ronald Odur. Un’ulteriore sala al primo piano è dedicata ad opere del collezionismo africano.
Anche da questo breve excursus credo si possa riconoscere l’ampiezza, la professionalità, la godibilità per il pubblico del display e delle opere in esso contenute. Il risultato è una Biennale elegante, finanche chic, che dedica molto spazio alla contemplazione, al mostrare, alla presentazione della produzione artistica intesa in senso amplio. Mancano momenti di incontro, scambio, riflessione e approfondimento. Le occasioni di incontro sono lasciate agli spazi OFF, più di 400 spazi, che con le loro inaugurazioni ed occasioni conviviali e musicali costruiscono le possibilità per gradevoli incontri.