-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
QUANDO SI SCHERZA BISOGNA ESSERE SERI
Personaggi
L’aforisma del Marchese del Grillo ben riassume la carriera e il pensiero di un maestro crudele. Che parlava degli italiani agli italiani. Un ricordo per il regista Mario Monicelli. Mentre il “suo” Paese non ha perso l’occasione per tacere in occasione del suo suicidio...
sguardo. Feroce ironia. Mai un compiacimento. Mai una furberia o una sequenza
ricattatoria. Eppure era un intellettuale che parlava a tutti, Mario Monicelli (Viareggio, Lucca, 1915
– Roma, 2010), ultimo testimone di una stagione di maestri che coniugavano
impegno sociale e leggerezza popolare al contempo, creatori di immagini iconiche
scolpite nella memoria collettiva del Paese. Un artista nazional-popolare,
nella sua più alta e gramsciana accezione.
Sembravano film leggeri o solo autoironici, i suoi. In realtà,
valgono più di qualsiasi trattato di sociologia. Perché Monicelli è riuscito a
cogliere meglio di chiunque altro la vera anima degli italiani, sin dai tempi neorealisti,
quando affrontava con la commedia, in coppia con Steno e con una maschera come quella di Totò, diversi temi sociali come
la crisi degli alloggi (Totò cerca casa,
1949), gli stenti e i sotterfugi nella Roma del dopoguerra (Guardie e ladri, 1951), i problemi della
burocrazia e la prepotenza al lavoro (Totò
e i sette re di Roma, 1952), le tensioni sociali e politiche di metà anni ‘50
(Totò e Carolina, 1955).
In seguito, il grande Mario non ha fatto altro che mostrare
l’homo italicus nei suoi più bassi
istinti, denunciandone e deridendone usi e costumi, dal boom economico alle
soglie del nuovo millennio. Il bisogno di trasgredire la norma e le regole,
come chi cerca maldestramente di rubare pur di non lavorare (I soliti ignoti, 1958). La patologica
ricerca di scorciatoie, come quella di chi arriva persino a chiedere aiuto ai
poteri occulti e alla massoneria pur di trovare “il posto” al proprio figlio (Un borghese piccolo piccolo, 1977). L’arretratezza
morale di costumi dei proletari meridionali (La ragazza con la pistola, 1969) e la ristrettezza mentale della
classe operaia settentrionale (Romanzo
popolare, 1974). La disperata voglia di divertimento a tutti i costi, di
chi vuole sfuggire alla solitudine (Risate
di gioia, 1960), e all’amarezza della propria inettitudine (Amici miei, 1975). L’ipocrisia delle
famiglie italiane, che si riuniscono a Natale solo per rispettare le tradizioni
(Parenti serpenti, 1992) o che sono in
perenne conflitto (Panni sporchi,
1999).

A ben guardare, questa tipologia di italiota affonda le radici nel passato, era cioè già presente prima
ancora che l’Italia venisse unita, prima di divenire tratto dominante e
caratterizzante della stessa nazione italiana. Basti pensare alla scalcinata e
buffa compagnia di freak medievali de L’Armata
Brancaleone (1966) o a quello che è l’antesignano dell’italiano moderno, Il Marchese Del Grillo (1981), il nobile
papalino di inizio Ottocento, campione di burle, che si divide tra il palazzo
di famiglia e le bettole, tra un’udienza pontificia e le frequentazioni con gli
atei “franzosi”, tra una guardia a Castel Sant’Angelo e le belle popolane.
Rompendo con disinteresse una poltrona del Seicento per bruciarla nel camino,
afferma con menefreghismo: “Io se potessi
sfascerei tutto! Vaffanculo il Cinquecento, il Seicento, il Settecento! Come
dite voi francesi? Merde a tout le monde!”.
Questa strafottenza del vivere è forse per Monicelli la
peculiarità che più caratterizza gli italiani e ha la sua massima espressione
nelle descrizioni del Capodanno, il momento per eccellenza dello svago a tutti
i costi. Come quello di Risate di gioia,
in cui le due vecchie comparse del cinema Antonio (Totò) e Tortorella (Anna
Magnani) si ritrovano soli e disperati, mentre tutta la città è in preda ai
folli festeggiamenti a cui nessuno intende rinunciare. Trent’anni dopo non vi
rinunceranno neanche quei terribili figli della provincia ipocrita e perbenista
di Parenti serpenti, che mangiano e
ballano spensierati in una balera kitsch mentre i genitori muoiono da soli in casa
per loro volere. I personaggi monicelliani sono dunque non-eroi, cialtroni sconfitti
dalla vita, persone comuni che non intendono rassegnarsi a un’esistenza grama.
Persino quando ritrovano la dignità in uno scatto d’orgoglio, decidendo di
sacrificare la propria vita, vengono beffardamente ritenuti dei vigliacchi da
coloro i quali devono a loro la salvezza (La
Grande Guerra, 1959). Forse soltanto le donne, sembra dire il maestro, se unite,
possono riscattare gli sbagli e le incapacità degli uomini (Speriamo che sia femmina, 1986).

Celebre è l’alterco in una ormai storica trasmissione
televisiva del 1977 con un giovane regista, reduce dal sorprendente successo
della sua opera prima girata in Super8, Io
sono un autarchico, che, in maniera molto arrogante e irrispettosa, gli rinfaccia
di rappresentare il sistema degli studios e di essere l’esponente di punta di
quella commedia all’italiana razzista e diretta solo allo stomaco dello
spettatore. Il grande regista ribatte serafico al giovane di essere nient’altro
che un proprio epigono, e di fotografare la società contemporanea al pari di
come aveva fatto lui negli anni precedenti. La storia, come spesso capitava,
gli ha dato ragione: Nanni Moretti
ha raccontato l’Italia e gli italiani degli ultimi trent’anni in maniera non
dissimile da come aveva fatto il maestro viareggino.
Anche negli ultimi tempi, intervistato, Monicelli continuava
a ripetere quanto fosse schifato dalla volgarità dell’Italia contemporanea,
quanto vuoto trovasse nella società e nel cinema di oggi. Riteneva stupidi gli
italiani perché continuano a votare Berlusconi invece di prenderlo a calci nel
sedere. E lo diceva senza peli sulla lingua, senza giri di parole. Seguitava cioè
a fare a voce quel che aveva fatto in 75 anni di carriera (!) con la macchina
da presa. Fino all’ultimo. La battaglia più recente è stata contro i tagli alla
cultura e al mondo del cinema da parte del governo. Malato, ricoverato in ospedale,
ha scelto da solo il momento di accomiatarsi dalla vita. Diceva: “La vita non è sempre degna di essere
vissuta, se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena”. Al
contrario di molti suoi personaggi, Mario Monicelli è stato coerente fino all’ultimo.
Chapeau!
Monicelli
fumettaro
La
Commedia all’italiana a Vienna
giulio
brevetti
[exibart]





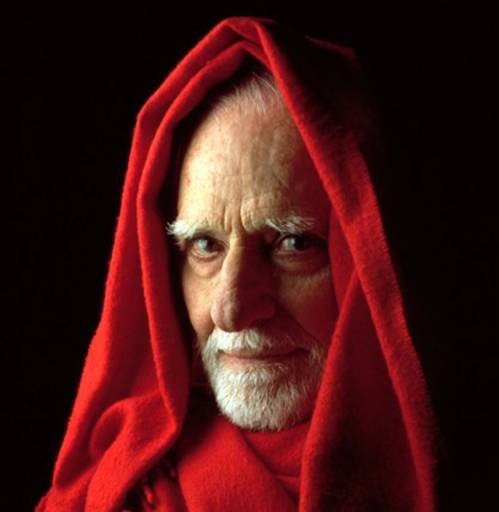






.jpg)





















-“La vita non è sempre degna di essere vissuta, se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena”.-
beh in effetti passare la vita incazzati a filmare le pochezze del cosiddetto ‘uomo comune’ non deve essere stato proprio il massimo, d’altra parte la dignità è un concetto molto labile e ognuno ha la non vita che si merita.
In italia siamo bravissimi a incensare i grandi maestri che hanno più di 80 anni e che sono così saggi da non non voler neanche essere incensati.