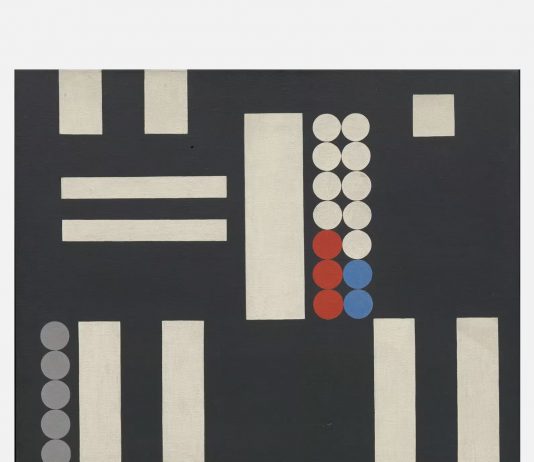-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
A Milano i video di 21 artisti internazionali raccontano la diaspora e l’apartheid in Palestina
Arte contemporanea

Qual è la prima cosa che viene in mente quando pensiamo ai prefissi telefonici? Un prefisso telefonico è una sequenza di numeri pensata per indirizzare la chiamata alla località desiderata, permettendo la connessione tra vari paesi, le relazioni umane e la trasmissione di informazioni. Sembra una cosa banale, ma una linea attiva di comunicazione indica il riconoscimento globale nei confronti di una determinata nazione.

Il prefisso internazionale della Palestina è composto da cinque cifre. Questo codice 00970 è una linea di accesso, una stringa di numeri che ufficializza la sua presenza. La sequenza racchiude tutto il passato e il presente: voci, immagini, vite, lotte. Questa è la premessa della mostra collettiva in corso da Ordet che apre una riflessione corale stratificata sulla perdita e sulla memoria ma soprattutto sulla colpa, attraverso le immagini in movimento di ventuno artiste e artisti della diaspora palestinese. 00970, a cura di Edoardo Bonaspetti, diventa uno spazio legittimo per una contro-narrazione, o meglio per una narrazione interrotta, frammentata e spesso ignorata. All’interno di quell’ex garage prende luogo un devastante silenzio sintomo dell’incomunicabilità e dell’indifferenza tra la nostra esistenza e questa soglia.
Non si tratta di una mostra “sulla” Palestina, ma “dalla” Palestina e più nello specifico attraverso la diaspora e la resilienza. Mediante le opere – video, film, materiale audio-visivo – sono evocati i fantasmi e le rovine di un territorio. Le immagini in movimento si rincorrono e la sensazione è quella di una realtà che chiede di essere vista, di un’eco che chiede di essere ascoltato.

Gaza sta bruciando così come i suoi abitanti, ma qual è il rapporto dell’occidente con le immagini che quotidianamente vengono diffuse sui network e sui social? L’artista Ali Cherri (Beirut, 1976) pone come quesito centrale, in My Pain is Real (2010), il nostro rapporto con la sofferenza altrui e le atrocità – soprattutto se percepite come distanti in un mondo sovrastimolato. L’opera sviluppa una ricerca sul divario tra empatia individuale e apatia collettiva con lucido senso critico. Con la stessa metodologia, le opere di Inas Halabi (Gerusalemme, 1988), Jumana Manna (Princeton, NJ, 1987) e Noor Abuarafeh (Gerusalemme, 1986) approfondiscono una critica-autoriale nel rivolgere domande all’osservatore previste di risposte sottintese, le quali insinuano così spiragli nella narrazione dominante.

In aggiunta, alcuni artisti amalgamano l’intimo e il pubblico, immaginazione e documentazione come: Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme (Nicosia, 1983 & Boston, 1983), Oraib Toukan (Boston, 1977), Mazen Kerbaj (Beirut, 1975) e Emily Jacir (Betlemme, 1970). L’archivio personale del singolo diventa politico; elementi privati e sbiaditi del passato si trasformano in allegorie del tempo stesso e della comunità a cui sono legate. Invece, da altri autori quali Basma al-Sharif (Kuwait City, 1983), Francisca Khamis Giacoman (Cile, 1988) e Razan AlSalah (Beirut, 1987) viene intrapresa una ricerca a partire da un presupposto spazio geografico; la distanza è metafora sia della memoria sia della violenza subita. Pur avendo un luogo specifico e delle coordinate a cui attenersi, il distacco è irriducibile e spietato, al punto che le immagini stesse non uniscono ma separano e cancellano. Ancora, Marwa Arsanios (Washington, DC, 1978), Huda Takriti (Damasco, 1990) e Akram Zaatari (Saida, Libano, 1966) restituiscono fatti e episodi di alcune icone della lotta operando una riscrittura della visibilità, che racchiude un potenziale rottura del sistema informativo dominante.
La scelta di privilegiare opere audio-visive non è banale, all’opposto questo medium permette di articolare narrazioni e temporalità complesse – sovrapponendo presente e passato, sogno e realtà – rendendo giustizia alle ricerche, alle vicende, alle voci e ai propositi intrapresi. Molti dei lavori in mostra adottano una struttura frammentata e sospesa, aspetto che rispecchia la verità della diaspora e dell’esilio forzato. Inoltre, l’allestimento amplifica l’impatto delle opere stesse reclamando attenzione, tempo e sospensione. Il montaggio non è solo cinematografico ma curatoriale: si entra e ci si perde da un display all’altro, le immagini e le opere si susseguono. I blocchi di cemento creano delle “isole dell’esilio”, dove si approda per ascoltare ogni voce, ogni video, ogni frammento dei racconti riuniti.

In 00970 non c’è vittimismo o nostalgia, ma una moltitudine di tentativi di comprendere cosa resta e conservare esistenze ad oggi continuamente negate, distrutte e annientate. Rifiuta la spettacolarizzazione del dolore, si tratta invece di una dura prova della nostra indifferenza e delle sue conseguenze. La Palestina emerge nei frammenti quasi come un concetto totale e pervasivo, al pari di uno spettro resistente o di un’idea simbolica che raduna corpi, voci, vite. L’esposizione assembla un attuale lessico dell’invisibilizzazione e invita a condividere un percorso estetico-artistico di attenzione e di cura.
Ha ragione chi scrive che dovremmo ringraziare Ordet – oltre che per questa mostra – per gli anni di tenace lavoro e costante ricerca che hanno costruito lo spazio atipico, emancipato e resiliente che vediamo oggi. Non solo uno spazio espositivo, ma un luogo di pensiero plurale. La mostra 00970 segna un punto di notevole valore nella programmazione, dimostrando come sia possibile e necessario congiungere: disciplina curatoriale, attenzione politica e critica, qualità artistica.