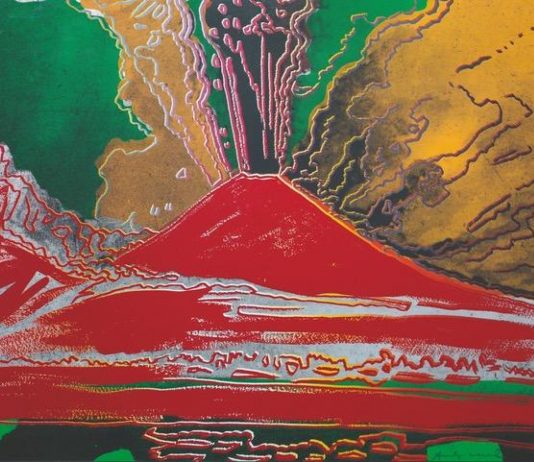-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
Bellezza, mito, voyeurismo, dramma esistenziale: Sam Samore
Mostre
Thomas Brambilla, Sam Samore l’ha letteralmente cercato: «ero a New York l’anno scorso, da Bryan Hunt, e l’ho cercato, pioniere della fotografia concettuale, sicuramente uno dei più grandi degli anni Novanta, quando la sua ricerca ha trovato pieno riconoscimento ed è stato consacrato come figura iconica della scena contemporanea». Il primo incontro, dunque, non è stato casuale ma voluto, spinto dalla vocazione di Brambilla, che è molto bravo a riportare sulla scena i grandi che trascuriamo, e dal suo sguardo critico sul presente: «Sam Samore – ci dice – è il mio statement intellettuale contro una mediocrità che ha preso il sopravvento. Con Samore invece niente è scontato come quello che continuiamo a vedere, in lui – grande intellettuale oltre che artista – ho trovato la versione migliore della fotografia, attenta, maniacale, feticista».

Schizophrenic Beauty (Continued) trasforma la galleria Thomas Brambilla un mix di surreale e reale, in un trionfo di occhi e labbra che si ripetono sulle pareti, uno dopo l’altro, in tutta la loro infinita varietà di mondi sensuali, feticisti, fantastici. Dal bianco e nero di Bangkok Triptych al blu di The Blue Tower o di Blu Pia, fino alle sfumature di Noot Two Times, o il viola di Mauve Patricia e il rosa acceso di Nan e Schizophrenic Beauty (Continued) le opere di Samore – una ventina quelle esposte – ci catturano in una dimensione misteriosa, quasi sacrale, ultraterrena. Sono fotografie? Sì. Sembrano dipinti? Sì. I rimandi alla storia della pittura sono in effetti tanti, Samore li conosce bene, e con rispetto e abilità li fa suoi: i colori si ispirano alla tavolozza Fauvista, che abbandona la resa realistica a favore di una visione espressiva, la grana marcata della pellicola fotografica che usa distorce l’immagine da vicino richiamando una sensualità vicina all’Espressionismo, le immagini sfuocate funzionano come rallentamenti visivi per il nostro occhio.

Perché sta proprio al nostro occhio abbattere la distanza, squartare il velo di Maya e scoprire che ciò che sembra dipinto è un effetto pixelato che testimonia la straordinarietà dell’artista non solo in termini formali, ma anche nel creare l’intervallo per l’osservatore, lo spazio in cui rivelarsi: «Per me – racconta Samore – queste immagini incoraggiano l’idiosincrasia e l’imprevedibilità del soggetto che le osserva. Aprono uno spazio in cui l’immaginario può vagare senza confini. Le grandi fotografie, delle stesse dimensioni dei nostri corpi, hanno una presenza fisica, ma sono grandi e vuote, come il cinema buio, e assorbono la proiezione dei nostri desideri, delle nostre paure». La scelta di questi due soggetti, che sono ricorrenti, affonda le radici nel vissuto personale di Samore, nelle sue passioni o, come lui stesso le definisce, nelle sue «quasi ossessioni». E noi?
Noi guardando questi primi piani che trasformano il dettaglio in simbolo, guardando lo sguardo e la bocca diventare strumenti di un linguaggio visivo, non possiamo fare altro che immaginare, e immaginando, identificarci con l’altro, attraverso il suo sguardo. E, ancora, identificandoci possiamo fare qualcosa che le nostre menti complesse non sono più abituate a fare: guardare le cose, guardare qualcosa – anche noi – in maniera semplice.