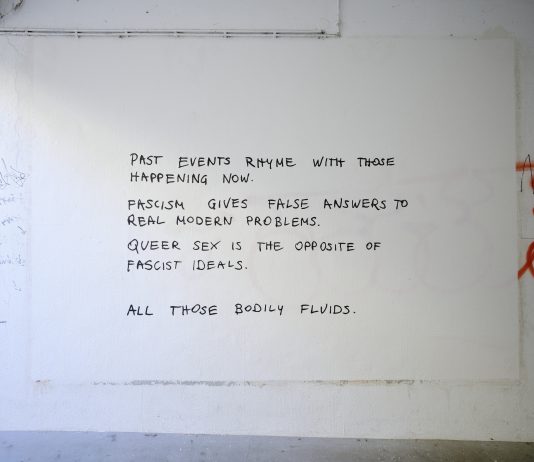-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
La meraviglia dell’inquietudine: l’arte di James Stewart
Arte contemporanea
La pittura di James Stewart abita un territorio ambiguo e necessario: un luogo in cui la realtà non viene mai superata dal sogno, ma lentamente corrosa da esso. Dapprima lucente, poi quasi preoccupante. È per questo che definirla semplicemente «realista» sarebbe riduttivo e chiamarla «magica» rischierebbe di assolverla – sebbene sia al «Realismo magico» che, sbrigativamente, ma errando, la si potrebbe ricondurre. Stewart, in realtà, sta altrove. Sta in una terra di mezzo che potremmo chiamare e battezzare «Realismo inquieto»: una cronaca visiva in cui la bellezza non consola e l’eleganza non salva, ma anzi diventa il travestimento più raffinato dell’angoscia che racconta storie bellissime e terribili.

Nei suoi dipinti, infatti, l’umanità è sempre presente in gran numero, eppure irrimediabilmente sola. «Nella solitudine, il solo divora se stesso; nella moltitudine, lo divorano gli altri: ora scegliete!», sosteneva Nietzsche. È una solitudine affollata, una condizione che ci distrugge l’animo con una dolcezza crudele, non casualmente, quella che Stewart ci costringe ad osservare, coinvolgendoci, fino a sentirci soli tra i soliti: uomini e donne distratti dal viandare – seppur all’apparenza lucenti e intrappolati in smoking, abiti da sera, papillon o gesti educati. Tutti impegnati a recitare, senza pausa né scampo, la commedia umana fatta di carillon sempre in funzione, di nastrini sociali che non smettono mai di girare e di vita che non smette mai di deludere. Nei caffè, nei teatri, nelle sale da ballo, ai tavoli eleganti del gioco e dell’azzardo: ogni luogo è un’impalcatura sociale da cui non si può più evadere ma a cui si può solo partecipare o, paradossalmente, ambire a farne parte – pur di “appartenere” a qualcosa. A qualsiasi cosa. E ci siamo dentro tutti, fino al collo – sembra volerci ricordare l’artista.

I tagli di città di James Stewart non sono semplici scenari ma dispositivi morali (pur senza morale). Dalle vetrine alle terrazze, passando per le prospettive oblique fino agli angoli fortemente descrittivi e narrativi dei suoi quadri, si dipanano affari, amori, business meeting, delusioni, piaceri leciti e loschi. Una varietà umana che ha smarrito la verità, diventando lentamente caricatura e parodia di se stessa – senza scampo e, soprattutto, senza scopo. L’essenza della vita – quella fatta di stenti, di verità non negoziabili – sembra sempre risiedere altrove, per James Stewart, in un perpetuo irraggiungibile, che però lui riesce sempre magistralmente a mettere in scena. Emblematico, in questo senso, è il grande dipinto visto dall’alto: come una fotografia rubata da un balcone, esso traccia una linea netta e crudele tra due mondi, che solo sulla carta appartengono allo stesso mondo. A sinistra, l’alta società che dalla terrazza festeggia, illudendosi di possedere il tempo e il senso, esercitando il potere anche attraverso il colore sgargiante e strafottente. A destra, sul marciapiede, la folla che arranca, s’affanna, si accalca per briciole che, alla fine, dall’alto non cadono mai. Delineando i contorni non di una denuncia gridata, ma di qualcosa di assai peggiore: una constatazione silenziosa, definitiva.

L’esercizio del dettaglio, nell’artista, inoltre, è qualcosa che appassiona anche chi non lo conosca per elasticità e contraddizione concettuale. Formalmente, le composizioni di Stewart, infatti, appaiono sempre dinamiche, vibranti, soprattutto se osservate da lontano: apparendo come possedere il ritmo festoso della vitalità, la promessa della gioia, la terra promessa della felicità e della spensieratezza. Ma basta avvicinarsi – come accade per esempio nei dipinti di Bosch, dove il dettaglio tradisce l’insieme – per scoprire l’inganno: le figure diventano quasi statue. Immobili. Inerti. Imbalsamate nella formalità del momento che stanno vivendo e a cui sono inderogabilmente inchiodate. Anche nello sport, persino nel Polo, la libertà è rilasciata come una posa: cavalli e giocatori sembrano in attesa di essere ritratti nel momento di massima perfezione muscolare e compositiva. Non si è liberi nemmeno quando la scompostezza sarebbe la condizione naturale del gesto, ad alcune latitudini sociali.

Ed è qui che affiora un primo, inevitabile, rimando a David Hockney: pur nell’esattezza generale compositiva, Stewart nelle imprecisioni volontarie del tratto, nelle vibrazioni instabili della superficie pittorica, nel tremolio dei contorni, dichiara la precarietà dell’esistenza umana. Nulla è fermo, nulla è davvero solido. E, a differenza di Hockney, questa instabilità non è quasi mai solare (se non in un caso che vedremo successivamente), ma s’impone come una crepa costante, una leggera vertigine, una febbre che non se ne va. Così come con Alberto Sughi, per esempio, Stewart condivide invece una scintilla di follia sommessa, mai teatrale: ombre, fumi e sbiaditure attraversano le sue scene come segni di una mente corrosa dal tempo. Alluvionata da un’angoscia che col tempo è diventata sopportabile – poiché parte integrante di se stessi.

Ma se in Sughi i personaggi sanno di essere osservati e instaurano un dialogo muto con lo spettatore, in Stewart questo non accade mai. I suoi sono scatti rubati alla bella società – che bella non è – a formare diapositive che, a ben guardare, tradiscono miserie, squallori diffusi, piccoli fallimenti vestiti di seta. Alcune sospensioni narrative, poi, lo avvicinano a Jack Vettriano: come nell’artista scozzese, non sappiamo dove vadano i personaggi di Stewart, né da dove vengano. Non sappiamo se si amino, se si tradiscano, se stiano litigando o riconciliandosi. Non sappiamo nulla, eppure sappiamo tutto. Perché come diceva Massimo Troisi a Neruda ne Il postino, meraviglioso film dedicato alla società e all’amore, «la poesia è di chi gli serve». Le tele di Stewart servono a noi, infatti: per immaginare storie mai scritte, vite mai vissute. Strutture compositive rigidissime contengono, al loro interno, il caos: il circo degli uomini che si esibisce senza sosta – e spesso senza senno – pur con compostezza pacata ed elegantissima. Eppure, arriva a più riprese la sensazione che sotto questa eleganza trattenuta, vibri qualcosa di più profondo e terribile: ed è in questa intercapedine che il dialogo con Francis Bacon si fa inevitabile. Stewart non deforma i corpi fino all’urlo, certo, ma li conduce lentamente verso una condizione animale. Quasi trasfigurata, come l’angoscia lieve che li possiede.

I suoi soggetti sono animali umani, o per dirla con Philip Roth «animali morenti»: creature educate, pettinate, vestite con cura, che però portano addosso il peso della fine. Una fine non spettacolare, ma quotidiana. Consumata. Erosa. Al pari di come le deformità armoniche di Otto Dix riaffiorano nei volti: mostruosi e amabili, disturbanti e familiari. Ci riconosciamo in loro, nostro malgrado. E negli scorci urbani, caotici e alienanti, si sente l’eco di George Grosz, filtrata però da una malinconia più composta, più borghese. Infine, come in Edward Hopper, nei quadri di Stewart aleggia un finale e intrascurabile senso di segreto. Di tempo che cade lentamente, visibile solo a chi sa fermarsi. Storie che si accavallano su storie, tutte significative eppure tutte drammaticamente insignificanti. Tutte utili, ma nessuna indispensabile. Come «la vita, con la sua seducente banalità»: per dirla con Thomas Mann.

Non conosco il percorso intenzionale di James Stewart, e forse non è essenziale conoscerlo. Ma sono pronto a scommettere che molti dei suoi dipinti nascano da luoghi mai esistiti davvero: terrazze senza coordinate, caffè mentali, strade pensate più che percorse. Eppure, quel dipinto – quello del giardino, della conversazione intorno a un tavolo immerso in una luce pomeridiana costante, rassicurante e commovente – sembra provenire da un punto diverso. Ovvero, da un ricordo. Un ricordo rimodellato dal tempo, certo, ma inciso nella memoria come una melodia eterna, leggero come una nuvola giovanile. Lì, più che altrove, Stewart tocca una verità partecipata: innanzitutto, la sua.

La mia conoscenza di James Stewart nasce così: da un incontro casuale con un suo dipinto per le strade di New York, imbattendomi in una galleria elegante e sobria in Lexington Avenue («Gallery71») di proprietà di uno stimato gallerista Alfred Ginzalez, che mi ha regalato una visione imprevista che non mi ha più lasciato: scaturendo anni di pensiero silenzioso, di immagini sedimentate. E poi il ritorno, anni dopo da flâneur nella galleria di Alfred: pronto a riaccogliermi e a parlare di ciò che ho amato, ho scoperto e ho amato scoprire: i dipinti meravigliosi e immagini di James Stewart. Tornarci, così, non è risultato come chiudere un cerchio, ma quasi come riaprirlo. Perché il flâneur non cerca: riconosce. Incamera. Non dimentica. Vede e ama. E quando riconosce, capisce che l’ossessione non era nostalgia, ma attesa.

E allora restiamo lì, davanti a queste tele, sospesi. Come i loro personaggi. Con la sensazione che la pittura, quando è vera, non spieghi: trattenga. Trattenga tutte le possibilità che l’immaginazione, stimolata dalla bellezza, può ancora concederci. In questo spazio fragile e luminoso, James Stewart ci invita a guardare – e a guardarci – sapendo che nulla cambierà davvero. Ma tutto, per un istante, sarà stato visto e vissuto. Oltre o dentro la realtà, al di là o immersi nel sogno, ma sempre dentro la vita.