-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Cento volte ready made
Libri ed editoria
Cos’è un ready-made? Come si fa? Perché si fa? A queste domande risponde il libro Teoria e pratica del ready-made, cento voci sul bell’e pronto, da pochi giorni disponibile grazie alle edizioni Postmediabooks. Il libro è “in parte” scritto da Daniele Monarca, dico in parte perché per una buona metà è composto da citazioni estratte da testi di varia natura – filosofia, antropologia, critica d’arte, narrativa ecc.
E c’è da dire che questa buona metà del libro, mi sia consentita l’ironia, è davvero buona, con frammenti presi da Benjamin, Deleuze, Warburg, de Certeau, Bourriaud, Bodei, Jedlowski, Dewey, Sontag e altri autori che certamente fanno già parte della cultura e della biblioteca di tanti lettori informati dei fatti.
L’autore preleva pensieri altrui – bell’e pronti – e quindi li commenta per sostenere qualche argomento, senza però preoccuparsi di capire o spiegare il senso del frammento di testo che utilizza, un approccio che, come afferma Monarca «viene dalla procedura ready-made stessa, in cui gli oggetti (i pensieri, i gesti) sono prelevati e disambientati e utilizzati contro il loro destino funzionale».
Il metodo di lavoro è quindi chiaro e, probabilmente, familiare a ogni lettore, visto che è lo stesso lavorìo che, più o meno consciamente, ognuno compie quando affronta un libro: produrre dei ragionamenti a partire da un testo e senza preoccuparsi dell’effettivo contenuto del testo, ma piuttosto della propria reazione al testo. Così, quello che interessa a Monarca non è il senso dei testi che utilizza, ma «sono gli intrecci, le sovrapposizioni, le aderenze, le semplici assonanze, non gli oggetti insomma, ma lo spazio tra gli oggetti», ovvero quello spazio inedito in cui ogni lettore costruisce la propria originale esperienza intellettuale, quel tipo di creazione che Duchamp conosceva bene: sono gli spettatori a fare il quadro…
Chiarito così qual è il padre nobile di tutta l’operazione si deve definire un altro aspetto e cioè che non si tratta di uno studio dedicato a Duchamp o alla sua opera – di cui per altro si riconosce la capitale importanza: alcune delle 100 voci di cui è composto il libro spiegano che il ready-made è una «pratica ancestrale» e uno dei meriti dello scandaloso orinatoio è appunto quello di aver riportato il discorso dell’arte a dialogare con questa storia profonda e antimoderna.
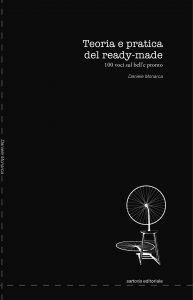
Il libro è composto da 100 voci, disposte in ordine alfabetico: si comincia con A cosa serve, con un frammento rubato a Bataille, e si finisce con Una verità discontinua, con una citazione estratta dal libro che Mòses ha dedicato al senso della storia in Benjamin. Nel mezzo c’è un po’ di tutto (Alberto Sordi e John Cage, Hannah Arendt e Raymond Roussel, Enrique Vila-Matas e Guy Debord) ed è probabilmente questa eterogeneità di materiali – che ricorda da vicino, non a caso, un’istallazione d’arte contemporanea – a rendere la lettura interessante: è l’approccio asistematico, «lo zigzagare curioso», decentrato (decisamente atipico per un libro che dovrebbe essere un saggio, cioè uno studio con cui, grazie a un ragionamento coerente, strutturato e approfondito si intende dimostrare una tesi) a offrire la possibilità al lettore di muoversi, a sua volta in modo asistematico e zigzagante o, in altre parole, libero.
Se, come afferma la quarta di copertina, il libro di Daniele Monarca intende spiegare la teoria del ready-made attraverso la pratica del ready-made al lettore è affidato il compito di dare un senso ai materiali presentati e commentati – deve farsi il quadro insomma – perché il ready-made si fonda proprio sull’idea dirompente e ancora oggi rivoluzionaria che «non c’è un senso prodotto in anticipo che il fruitore deve scoprire; una verità prodotta ex-ante da disvelare; un disegno da ricomporre e di cui far parte, il senso si produce, ogni volta diverso, nel rapporto con l’opera; la verità si manifesta ex-post» e deve essere ogni volta ricreata dallo spettatore, o dal lettore.
È più o meno quanto afferma Walter Benjamin (ecco un altro padre nobile, lo chiamiamo: genitore due) quando nei passages scrive che «il vero metodo per renderci presenti le cose è di rappresentarcele nel nostro spazio (e non di rappresentare noi nel loro)»; questo metodo rifiuta il potere che gli oggetti hanno su di noi, resiste alla forza che il Potere esercita sui di noi attraverso gli oggetti.
Come sappiamo, gli oggetti che la procedura ready-made fa transitare dal mondo all’arte sono oggetti di origine industriale (ah, il capitalismo…), proprio su questo Monarca rileva l’utilità, pratica prima che concettuale, della procedura ready-made perché, scrive «il nostro spazio è sempre più popolato da macchine che fanno cose senza chiedere il permesso, macchine che frenano per noi; macchine che scattano foto per noi; parlano, ascoltano, consigliano, scelgono, comprano, votano per noi; macchine che guardano per noi: ci stiamo dirigendo verso un mondo di ovattata insipienza». Nel nostro presente gli oggetti – semplici cose ma anche macchine, algoritmi, palinsesti, format – invadono sempre più la nostra vita, modificando e in parte sedando il nostro rapporto con il mondo, è cosa nota e ampiamente dibattuta, tuttavia, «uno spazio in cui queste trasformazioni trovano qualche resistenza o per lo meno sono accolte con spirito critico, è quello dell’arte. Qui la strategia prevalente è quella di sottrarre elementi al conosciuto, cambiare la disposizione degli oggetti tra i quali ci muoviamo ormai come sonnambuli, oggetti che sempre più spesso, anticipando i nostri gesti, tendono a inibire la nostra reazione e relazione con l’ambiente. È un modo di approcciare il fatto creativo inaugurato, si sà, un secolo fa dai dadaisti e da Duchamp: attraverso la procedura ready-made l’artista opera spostamenti e risemantizzazioni ristrutturando incessantemente il tessuto del visibile, dell’esperienza, costringendo l’osservatore a quello che Walter Benjamin chiamava un risveglio».

Questo risveglio consente, secondo l’autore, (ma soprattutto secondo Gilles Deleuze: genitore tre!) il costituirsi della soggettività – una soggettività ribelle, imprevedibile, spesso effimera e inconsapevole ma non per questo meno vera –, un costituirsi davvero impervio e necessario visto che nella società 2.0 la nostra soggettività è spensieratamente avviata a diventare un prodotto – un prodotto industriale, proprio come l’orinatoio di Duchamp – da vendere e comprare nelle reti sociali.
Ecco allora che alla domanda a che cosa serve l’arte l’autore risponde: a niente, per fortuna, se non a mettere in discussione qualche idea che diamo come indiscutibile – come, ad esempio, che un orinatoio serva solo a orinare –, una volta chiarita questa semplice questione ci troviamo in uno spazio nuovo in cui è «tutto da rifare. Tutto da capo, ogni volta. Tutto da riformulare, rielaborare, tutto da ridire e rivedere. Tutto da inventare, immaginare di nuovo. Magnifico invito a un perenne cominciamento».























