Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
27
novembre 2007
libri_anteprime Musei e neocolonialismo (franco angeli 2007)
Libri ed editoria
Si intitola This is contemporary!. Il nuovo libro di Adriana Polveroni, edito da Franco Angeli, è una disamina puntuale e talora spietata dell’istituzione “museo” e di cosa c’è oltre. E si conclude con un forum polifonico. Ne pubblichiamo un estratto significativo, mentre questa sera sarà presentato alla libreria Electa-Koenig di Milano...
La disponibilità sul mercato di un’offerta internazionale data dalla circolazione di opere e artisti inimmaginabile prima della globalizzazione, l’invadenza dello stesso mercato, ravvisabile nella continua moltiplicazione delle fiere che, come nota Francesco Bonami, “cercano di replicare il ruolo attivo svolto dalle biennali”, anche perché astutamente inglobano al loro interno momenti di riflessione critica attraverso convegni e confronti tra pubblico e addetti ai lavori, sostituendosi così alla funzione naturale delle Istituzioni che d’altra parte, come è successo per esempio nelle edizioni della Biennale di Venezia 2005 e 2007, non svolgono quella ricerca sulla produzione più recente che dovrebbe essere la loro specifica missione, fa sì che spesso la collezione dei musei oggi sia fatta secondo una falsariga opacamente “colonialista”, con artisti scelti, ma meglio sarebbe dire imposti, da direttori e curatori sia internazionali che di orizzonte più locale, dove questi, vale a dire, agiscono come cassa di risonanza dei primi, spesso sensibili, a loro volta, alle pressioni del mercato. Se le opere a volte variano, nella declinazione dell’idea che l’artista ha sviluppato, i nomi però risultano essere sempre uguali. Ne consegue che, anche a distanza di migliaia di chilometri, si trovano musei-fotocopia, “superluoghi” arricchiti mediaticamente dalla firma di super architetti e di curatori internazionali e popolati da super artisti: i protagonisti del sistema dell’arte. I quali, incarnando una specie di marchio di garanzia internazionale dell’industria museale, diventano irrinunciabili per direttori e finanziatori e quindi imprescindibili in qualsiasi contesto storico-culturale. È il “G8 dell’arte” e la “cooperativa del gusto” di cui parla Achille Bonito Oliva: “Un circuito internazionale promuove l’egemonia di modelli artistici che acquistano valore economico e culturale per la loro capacità di assimilazione e penetrazione” [1].

Un po’ come è accaduto per la forma dell’involucro, che se non è firmato Renzo Piano, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, Tadao Ando o David Chipperfield, probabilmente è di scarso interesse per il sistema mediatico globale. Così il risultato, in uno sconsolante effetto domino, è che non solo i musei si collocano a una certa latitudine del pianeta o in aree che si propongono come le nuove frontiere del mondo e del mercato dell’arte -la Cina anzitutto e poi i vari “subcontinenti” orientali- le quali, per dare messaggi di affidabilità all’Occidente, ne sposano le strategie [2], soprattutto il paesaggio interno si distingue difficilmente l’uno dall’altro. È quanto fanno vedere, con felice sintesi creativa, i due artisti danesi Elmgreen & Dragset, che in un’installazione del 2002 rovesciano a terra una serie di piccoli white box tutti uguali, dei quali un titolo niente affatto generoso rivela la triste realtà: Powerless structures. E dire che da non molto tempo, con la costruzione del Centre Pompidou, “primo museo ad adottare prospettive multiple per i propri contenuti, con un’inversione di rotta rispetto al Museum of Modern Art che, invece, ha sempre rigorosamente privilegiato la narrazione lineare”, ci si era liberati da un modello normativo, legittimando “i musei a differenziarsi in modo sostanziale gli uni dagli altri” [3]. Ma quella che Karsten Schubert definisce una “svolta clamorosa” è durata poco e di nuovo oggi, mostrando una miope tendenza conformistica, i musei si somigliano un po’ tutti. Nonostante, poi, la ricerca artistica contemporanea si orienti in tutt’altra direzione, insistendo nella tendenza a destrutturate l’opera, i meccanismi percettivi e concettuali che la configurano come tale, e a esplorare possibili e diverse letture. Realtà a cui i musei, invece, rispondono attivando una sorta di “pensiero unico”.

Il Museo MADRE di Napoli, progetto ambizioso sostenuto con grinta dal suo direttore Eduardo Cicelyn che è riuscito a realizzarlo in un tempo record per gli standard italiani, tra tante testimonianze preziose delle vicende artistiche internazionali degli ultimi venti, trent’anni, ospita cinque artisti della città. Non pochi in assoluto, ma parliamo di una realtà, quella di Napoli, che nell’Italia degli anni ‘60 e ‘70 ha significato molto quanto a temperie culturale in cui agivano un collezionismo attento e gallerie di ricerca: Dina Caróla, Lucio Amelio, Lia Rumma, lo Studio Morra, per ricordare le più importanti. Certo è che la presenza delle opere internazionali fa bene alla città, nel senso che qualunque museo dovrebbe dare la possibilità al suo pubblico di conoscere le tendenze, i nomi che hanno segnato la storia dell’arte degli ultimi decenni. E, per restare sull’esempio del MADRE, da questo punto di vista, la presenza di opere in collezione nate da iniziative di arte pubblica che hanno investito Napoli (gli interventi durante il periodo di Natale a piazza Plebiscito iniziati nel 1995 con la Montagna di sale di Mimmo Paladino) e che hanno preceduto il museo ne giustifica la scelta, permettendone una riconfigurazione che significa ricostruirne la memoria all’interno del contesto museale. Ma forse sarebbe altrettanto importante che i responsabili dei musei si adoperino per far sì che tali opere interagiscono in un dialogo creativo con altre provenienti da contesti più “locali”, in cui non solo queste siano valorizzate, ma raccontino la genesi del fermento, di un particolare clima, che forse si è sviluppata da un’altra parte del mondo ma che lì ha sollecitato significative germinazioni. In un confronto tra Tom Finkelpearl, Direttore del Queens MoMA, e Rick Lowe, direttore del Project Row Houses di Houston, avvenuto a Parigi in occasione dell’apertura del MAC-VAL [4], Finkelpearl ha spiegato come il loro sforzo sia stato di “diventare locali”, precisando che “essere locali nel Queens, così come a Vitry, significa essere internazionali. Il che non significa mostrare solo artisti locali, ma che provengono dall’India, dalla Corea, da Taiwan perché è la loro arte a risuonare nell’audience locale. Questo significa incidere nella storia del luogo, operazione che nel nostro caso risulta essere internazionale”.

Posizione senz’altro più facile da teorizzare che da mettere in pratica, ma che ci riporta ai criteri di edificazione di una collezione, che non deve essere solo l’esibizione di grandi nomi, ma avere un respiro, come suggerisce Germano Celant: una capacità di “rivalutare la storia del contemporaneo secondo un taglio prospettico, che non è la mera elencazione dei nomi” [5]. Operazione che forse può rilanciare creativamente il paradosso sotteso a un qualunque museo d’arte contemporanea che, per definizione, non maneggia la storia ma il presente, rendendolo permeabile verso la problematicità che può generarsi dal confronto tra realtà e periodi diversi.
Quando ciò non accade il museo si ripropone come luogo autoritario, sia pure nell’elasticità strutturale data dalla varietà delle proposte espositive che è capace di mettere in essere e da una concezione architettonica spesso destrutturata, cui tuttavia continua a essere emendato il compito di mantenere lo statu quo. Che oggi non è più quello dell’affermazione di una soggettività territoriale, ma l’esibizione di un potere internazionale e transculturale. Globale e, proprio per questo, capillarmente distribuito. Dove agiscono diversi soggetti, ciascuno con un ruolo preciso. Il mondo dell’arte non è un circuito globalizzato solo in virtù di chi lo frequenta (il pubblico degli infaticabili pellegrini-consumatori), di chi lo agisce (i direttori e i curatori) e di chi lo promuove (non solo sponsor, ma ormai i grandi brand museali, come il Guggenheim, il Louvre e l’Ermitage per l’arte del passato, che si comportano come imprese a tutti gli effetti) ma anche per i suoi attori principali: gli artisti. Che per spalmare la loro presenza nei vari punti caldi del mondo, spesso risolvono lo svantaggio (commerciale) dato da una produzione che ha superato la logica del manufatto, quali sono le performance e, in certe forme, l’arte pubblica, escogitando nuove strategie di commercializzazione che ottimizzano le loro prestazioni.
“Lavorando in filiera”, insomma. Artisti come Takashi Murakami, Matthew Barney e Vanessa Beecroft realizzano video, sculture e foto a partire da un unico segno o gesto, dopodiché le loro gallerie collocano nel tal museo il video, nell’altro la still (la foto) ricavata da questo o da una performance e nell’altro ancora l’installazione: specie di feticcio plastico dell’idea realizzata in video. E in tal modo incarnano, soddisfacendo l’esigenza di una commercializzazione crescente propria del mercato, un sistema di globalizzazione colonizzatrice che si avvale di questi e di altri sostegni. Non solo il circuito internazionale delle gallerie più potenti, che non a caso contano varie sedi distribuite nei mercati più sensibili del pianeta, ma anche la classifica, stilata sul magazine britannico Art Review che decide ogni anno la persona più potente nel mondo dell’arte o il sito artfacts.net che aggiorna in tempo reale le quotazioni degli artisti di maggior successo, a volte anche due volte nel corso della stessa giornata come accade in borsa.

In gioco vi è l’arte come super merce, che richiama pubblico, promuove il museo, anche perché gli permette di competere e di avere qualcosa da scambiare sul mercato internazionale, e che soprattutto disegna nuovi scenari politico-economici. A Seattle, città della West Coast americana benedetta dall’essere sede di tre tra le più importanti imprese del Paese: Microsoft, Boeing e Starbucks, il nuovo SAM (Seattle Art Modern), oltre a godere di ingenti donazioni di collezionisti privati tra cui Melinda e Bill Gates e i coniugi White, maggiori azionisti della Boeing, è stato realizzato grazie a un accordo finanziario con la WaMu (Washington Mutual), la prima banca dello stato. Per la prima volta nella storia museale banca e museo condividono lo stesso edificio inaugurato a maggio 2007: un grattacielo a forma di L. Oggi il SAM ne occupa il lato minore: quattro piani, e la banca quello più alto, sedici piani. Tra dieci anni l’accordo tra il museo e WaMu sarà rinegoziato e se la banca vorrà continuare a occupare i suoi piani, dovrà pagare un affitto al SAM.

Un po’ come è accaduto per la forma dell’involucro, che se non è firmato Renzo Piano, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, Tadao Ando o David Chipperfield, probabilmente è di scarso interesse per il sistema mediatico globale. Così il risultato, in uno sconsolante effetto domino, è che non solo i musei si collocano a una certa latitudine del pianeta o in aree che si propongono come le nuove frontiere del mondo e del mercato dell’arte -la Cina anzitutto e poi i vari “subcontinenti” orientali- le quali, per dare messaggi di affidabilità all’Occidente, ne sposano le strategie [2], soprattutto il paesaggio interno si distingue difficilmente l’uno dall’altro. È quanto fanno vedere, con felice sintesi creativa, i due artisti danesi Elmgreen & Dragset, che in un’installazione del 2002 rovesciano a terra una serie di piccoli white box tutti uguali, dei quali un titolo niente affatto generoso rivela la triste realtà: Powerless structures. E dire che da non molto tempo, con la costruzione del Centre Pompidou, “primo museo ad adottare prospettive multiple per i propri contenuti, con un’inversione di rotta rispetto al Museum of Modern Art che, invece, ha sempre rigorosamente privilegiato la narrazione lineare”, ci si era liberati da un modello normativo, legittimando “i musei a differenziarsi in modo sostanziale gli uni dagli altri” [3]. Ma quella che Karsten Schubert definisce una “svolta clamorosa” è durata poco e di nuovo oggi, mostrando una miope tendenza conformistica, i musei si somigliano un po’ tutti. Nonostante, poi, la ricerca artistica contemporanea si orienti in tutt’altra direzione, insistendo nella tendenza a destrutturate l’opera, i meccanismi percettivi e concettuali che la configurano come tale, e a esplorare possibili e diverse letture. Realtà a cui i musei, invece, rispondono attivando una sorta di “pensiero unico”.

Il Museo MADRE di Napoli, progetto ambizioso sostenuto con grinta dal suo direttore Eduardo Cicelyn che è riuscito a realizzarlo in un tempo record per gli standard italiani, tra tante testimonianze preziose delle vicende artistiche internazionali degli ultimi venti, trent’anni, ospita cinque artisti della città. Non pochi in assoluto, ma parliamo di una realtà, quella di Napoli, che nell’Italia degli anni ‘60 e ‘70 ha significato molto quanto a temperie culturale in cui agivano un collezionismo attento e gallerie di ricerca: Dina Caróla, Lucio Amelio, Lia Rumma, lo Studio Morra, per ricordare le più importanti. Certo è che la presenza delle opere internazionali fa bene alla città, nel senso che qualunque museo dovrebbe dare la possibilità al suo pubblico di conoscere le tendenze, i nomi che hanno segnato la storia dell’arte degli ultimi decenni. E, per restare sull’esempio del MADRE, da questo punto di vista, la presenza di opere in collezione nate da iniziative di arte pubblica che hanno investito Napoli (gli interventi durante il periodo di Natale a piazza Plebiscito iniziati nel 1995 con la Montagna di sale di Mimmo Paladino) e che hanno preceduto il museo ne giustifica la scelta, permettendone una riconfigurazione che significa ricostruirne la memoria all’interno del contesto museale. Ma forse sarebbe altrettanto importante che i responsabili dei musei si adoperino per far sì che tali opere interagiscono in un dialogo creativo con altre provenienti da contesti più “locali”, in cui non solo queste siano valorizzate, ma raccontino la genesi del fermento, di un particolare clima, che forse si è sviluppata da un’altra parte del mondo ma che lì ha sollecitato significative germinazioni. In un confronto tra Tom Finkelpearl, Direttore del Queens MoMA, e Rick Lowe, direttore del Project Row Houses di Houston, avvenuto a Parigi in occasione dell’apertura del MAC-VAL [4], Finkelpearl ha spiegato come il loro sforzo sia stato di “diventare locali”, precisando che “essere locali nel Queens, così come a Vitry, significa essere internazionali. Il che non significa mostrare solo artisti locali, ma che provengono dall’India, dalla Corea, da Taiwan perché è la loro arte a risuonare nell’audience locale. Questo significa incidere nella storia del luogo, operazione che nel nostro caso risulta essere internazionale”.

Posizione senz’altro più facile da teorizzare che da mettere in pratica, ma che ci riporta ai criteri di edificazione di una collezione, che non deve essere solo l’esibizione di grandi nomi, ma avere un respiro, come suggerisce Germano Celant: una capacità di “rivalutare la storia del contemporaneo secondo un taglio prospettico, che non è la mera elencazione dei nomi” [5]. Operazione che forse può rilanciare creativamente il paradosso sotteso a un qualunque museo d’arte contemporanea che, per definizione, non maneggia la storia ma il presente, rendendolo permeabile verso la problematicità che può generarsi dal confronto tra realtà e periodi diversi.
Quando ciò non accade il museo si ripropone come luogo autoritario, sia pure nell’elasticità strutturale data dalla varietà delle proposte espositive che è capace di mettere in essere e da una concezione architettonica spesso destrutturata, cui tuttavia continua a essere emendato il compito di mantenere lo statu quo. Che oggi non è più quello dell’affermazione di una soggettività territoriale, ma l’esibizione di un potere internazionale e transculturale. Globale e, proprio per questo, capillarmente distribuito. Dove agiscono diversi soggetti, ciascuno con un ruolo preciso. Il mondo dell’arte non è un circuito globalizzato solo in virtù di chi lo frequenta (il pubblico degli infaticabili pellegrini-consumatori), di chi lo agisce (i direttori e i curatori) e di chi lo promuove (non solo sponsor, ma ormai i grandi brand museali, come il Guggenheim, il Louvre e l’Ermitage per l’arte del passato, che si comportano come imprese a tutti gli effetti) ma anche per i suoi attori principali: gli artisti. Che per spalmare la loro presenza nei vari punti caldi del mondo, spesso risolvono lo svantaggio (commerciale) dato da una produzione che ha superato la logica del manufatto, quali sono le performance e, in certe forme, l’arte pubblica, escogitando nuove strategie di commercializzazione che ottimizzano le loro prestazioni.
“Lavorando in filiera”, insomma. Artisti come Takashi Murakami, Matthew Barney e Vanessa Beecroft realizzano video, sculture e foto a partire da un unico segno o gesto, dopodiché le loro gallerie collocano nel tal museo il video, nell’altro la still (la foto) ricavata da questo o da una performance e nell’altro ancora l’installazione: specie di feticcio plastico dell’idea realizzata in video. E in tal modo incarnano, soddisfacendo l’esigenza di una commercializzazione crescente propria del mercato, un sistema di globalizzazione colonizzatrice che si avvale di questi e di altri sostegni. Non solo il circuito internazionale delle gallerie più potenti, che non a caso contano varie sedi distribuite nei mercati più sensibili del pianeta, ma anche la classifica, stilata sul magazine britannico Art Review che decide ogni anno la persona più potente nel mondo dell’arte o il sito artfacts.net che aggiorna in tempo reale le quotazioni degli artisti di maggior successo, a volte anche due volte nel corso della stessa giornata come accade in borsa.

In gioco vi è l’arte come super merce, che richiama pubblico, promuove il museo, anche perché gli permette di competere e di avere qualcosa da scambiare sul mercato internazionale, e che soprattutto disegna nuovi scenari politico-economici. A Seattle, città della West Coast americana benedetta dall’essere sede di tre tra le più importanti imprese del Paese: Microsoft, Boeing e Starbucks, il nuovo SAM (Seattle Art Modern), oltre a godere di ingenti donazioni di collezionisti privati tra cui Melinda e Bill Gates e i coniugi White, maggiori azionisti della Boeing, è stato realizzato grazie a un accordo finanziario con la WaMu (Washington Mutual), la prima banca dello stato. Per la prima volta nella storia museale banca e museo condividono lo stesso edificio inaugurato a maggio 2007: un grattacielo a forma di L. Oggi il SAM ne occupa il lato minore: quattro piani, e la banca quello più alto, sedici piani. Tra dieci anni l’accordo tra il museo e WaMu sarà rinegoziato e se la banca vorrà continuare a occupare i suoi piani, dovrà pagare un affitto al SAM.
adriana polveroni
[1] Bonito Oliva aggiunge anche che “si assiste a un tour di mostre, veri e propri piani biennali e quinquennali di esposizioni che mettono in circolo quasi sempre gli stessi nomi, a conferma di una cooperativa del gusto non certamente a conduzione familiare, quanto piuttosto su scala planetaria” (A. Bonito Oliva, I luoghi dello sguardo. Musei che reclamano attenzione, Gangemi, Roma 2004).
[2] Per un approfondimento di questo punto si rimanda al contributo di Stefania Suma in P. Ciorra – S. Suma (a cura di), I musei dell’iperconsumo, Atti del convegno internazionale, Accademia nazionale di San Luca e Triennale di Milano, Milano 2002, pp. 16-18. [3] K. Schubert, Museo. Storia di un’idea, Il Saggiatore, Milano 2004, p. 78.
[4] L’acronimo MAC-VAL sta per il Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, sorto nel novembre 2005 nel comune di Vitry-sur-Seine, a sud-est di Parigi.
[5] Contributo di Germano Celant in P. Baldi (a cura di), MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXl secolo, Electa, Milano 2006, p. 148.
[2] Per un approfondimento di questo punto si rimanda al contributo di Stefania Suma in P. Ciorra – S. Suma (a cura di), I musei dell’iperconsumo, Atti del convegno internazionale, Accademia nazionale di San Luca e Triennale di Milano, Milano 2002, pp. 16-18. [3] K. Schubert, Museo. Storia di un’idea, Il Saggiatore, Milano 2004, p. 78.
[4] L’acronimo MAC-VAL sta per il Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, sorto nel novembre 2005 nel comune di Vitry-sur-Seine, a sud-est di Parigi.
[5] Contributo di Germano Celant in P. Baldi (a cura di), MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXl secolo, Electa, Milano 2006, p. 148.
*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 44. Te l’eri perso? Abbonati!
27 novembre 2007 – ore 19
Mondadori Multicenter – ElectaKoenig
Piazza del Duomo, 1 – 20121 Milano
Alla presentazione intervengono, con l’autrice, Alberto Abruzzese, Giacinto di Pietrantonio, Marco Enrico Giacomelli, Lucia Matino. Modera Francesca Pasini
Il libro
Adriana Polveroni – This is contemporary! Come cambiano i musei d’arte contemporanea
Franco Angeli, Milano 2007
Pagg. 200, € 19, ISBN 8846490421
Info: la scheda dell’editore
[exibart]







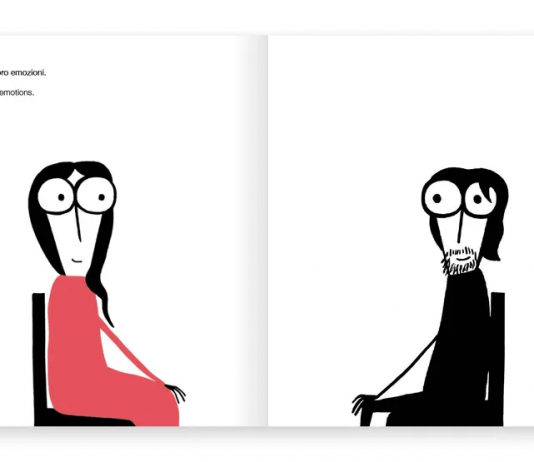



























è curioso che bonami critichi storr perchè non avrebbe esposto l’arte più nuova alla biennale
il lavoro che bonami fa sugli artisti italiani é dare il contentino disordinatamente in giro qua è là nelle occasioni di ammasso e privilegiare invece con oculatezza gli artisti delle sue solite gallerie di riferimento nelle occasioni più selezionate
se c’è un problema internazionale di omologazione ce n’è pure uno nazionale: non ci può essere un unico “collo di bottiglia”
che decida tutto: prima celant, poi bonito oliva e ora bonami
che bonami faccia quel che gli pare ma c’è la necessità urgente che ci siano altre voci
Caro Gorgo, sono d’accordo con te ma guarda che è ancora Celant a decidere tutto, di Bonito Oliva hanno accettato la Transavanguardia mentre Bonami è un prestanome a cui hanno dato grande visibilità e mezzi.