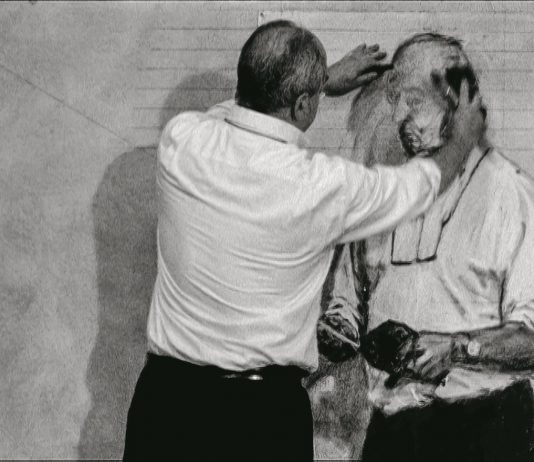-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
La poesia del fingere le onde del mare: intervista a Chiara Dynys
Personaggi
C’è una forma di verità che si rivela solo ed esclusivamente attraverso la finzione. Qualcosa di non detto, che si lascia tuttavia intravedere come una sorta di luce riflessa: è il fondamento stesso del concetto di soglia, di attraversamento, di passaggio necessario che accompagna le opere di Chiara Dynys. Nella sua installazione per la Sala Stirling di Palazzo Citterio, Once Again curata da Anna Bernardini, l’artista ricostruisce una enorme macchina di forme e movimento che mima esplicitamente il moto delle onde. Ad accompagnare la mostra, che sarà visitabile fino al 10 settembre, una pubblicazione edita da Allemandi al cui interno, oltre al testo della curatrice, sono presenti anche interventi di Angelo Crespi e Giorgio Verzotti.

Una scelta immediata e diretta, quella di Dynys, di ricorrere al meccanismo della finzione non per mentire, ma per agevolare la fruizione dell’opera. Ricostruire un mare significa immaginare una forma di architettura del possibile, una sorta di nuova forma di non-luogo. La gigantesca onda è, infatti, un meccanismo quasi rocambolesco che ci trasporta a pochi passi mentali dalla rappresentazione scenica a cui assistiamo: è il cinema metafisico di Fellini – oggi, più o meno, di Sorrentino – in cui domina un’atmosfera perennemente inadeguata e grottesca che non ci lascia intendere un rapporto con il canonico stato di concezione del qui e ora. Un movimento eterno e ancestrale che si ripete e si ripete e si ripete senza sosta evocando l’ossessiva e instancabile forma delle onde del mare – quel qualcosa che cerca di definirsi nello stesso istante in cui si infrange.
Le stesse onde sono quelle che popolano lo spazio ipogeo – la vasca di cemento brutalista come l’ha definita l’artista (senza alcun intento denigratorio, si intende) – senza realmente raffigurare un mare. Questa installazione, infatti, restituisce l’essenza più instabile e profonda del mare stesso: movimento, ipnosi, danza e chi si trova ad osservarla non può che essere trasportato oltre il tempo e oltre lo spazio; un muoversi che è un rituale atavico di fusione tra acqua e cielo.
Altrove, c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove diceva Jep Gambardella ne La Grande Bellezza e, dopotutto, è ciò che Chiara Dynys sceglie esattamente di perseguire nell’illusione diretta e non velata di qualcosa che, in realtà, si rivolge alla sua origine. La stessa indagine dell’origine che si moltiplica e non si risolve se si osservano gli ambienti dell’artista e le opere esposte nel Private Atlas di Building (da Gennaio a Dicembre 2025 a cura di Alessandro Castiglioni). Lo sforzo straordinario compiuto dall’artista risiede nell’aver trovato, in questa soglia, una nuova forma di esperienza visiva che recupera sia il suo intento anarchivistico che la sua emotività sottile. Un eterno ritorno di forme e di strutture che, ogni volta sempre differentemente, si arricchiscono di nuove sottili sfumature linguistiche – parentesi, incisi, assiomi. Ricostruiamo insieme all’artista quelle più dolci e interessanti atmosfere sottese a questo lavoro che nella sua ipertrofia visiva manifesta non solo concetti fondamentali e importanti, ma gioca con la realtà insistendo su riflessioni che, oggi a maggior ragione, appaio ancora più urgenti.
Una domanda sicuramente banale ma che trovo giusta per aprire questa nostra conversazione. Che cosa rappresenta il mare? Dove sta la sua poesia?
«Credo che per me il mare rappresenti quello che in realtà rappresenta per tutti: un insieme di memoria, ricordi, simboli ed evocazioni. Il mare, nella mente delle persone, è variabile, esattamente come è in natura: una volta è ondoso, una volta è calmo, a volte piatto, altre burrascoso. Ogni persona credo trovi nel mare il compendio di tutto ciò che può capitargli nella vita. Dopotutto, il mare è una metafora della vita stessa.»
Nella tua installazione nella Sala Stirling hai esplicitamente fatto riferimento al teatro barocco, che è improntato non solo alla finzione ma, per l’appunto, alla mimesi. Nel teatro barocco le forme erano molto spesso esasperazioni e parodie della realtà stessa a tal punto da diventare quasi caricaturali. In che modo la tua opera esplicita questo nesso con la finzione? Che cosa cerca di imitare?
«Il teatro barocco non imitava ma, appunto, accentuava certi elementi; le onde del mare, per esempio, sono onde che si susseguono come negli antichi motivi decorativi ripetuti, la cosiddetta “greca”. L’idea barocca è quella di mostrare il grande artificio e comunque costringere a crederci. Così come quando si entra a teatro o in una galleria d’arte, la mente e, in generale, l’essere si dispongono a vedere in un altro modo, ad entrare in un altro mondo in cui finzione e realtà sono la stessa cosa. In un certo senso, il mio amore è quindi più mare del mare.»
La finzione è, inoltre e forse, il più potente meccanismo socio-antropologico che accompagna questa nostra contemporaneità. Mi piace spesso ripetere che il nostro presente è, per lo meno a tratti, fatiscente: annaspiamo alla ricerca della verità che si nasconde e muta per non farsi vedere. La tua installazione non solo finge, come abbiamo citato sopra, una rappresentazione che è anche emotiva, ma così facendo distrugge lo stesso meccanismo della finzione. Se nel cinema e nel teatro la rottura della quarta parete svela le illusioni e mostra spesso la natura tremenda della nostra esistenza – penso, banalmente, ai Sei Personaggi pirandelliani – alle volte crea atmosfere trasognate, liminali. È il caso di Fellini, come nel finale di 8 e ½ in cui ci rende partecipi di un sogno malinconico ma sicuramente dolce. Fingere la finzione, alle volte, elimina la perversione della finzione stessa manipolandone i confini. Che cos’è la verità nella tua opera? Dove si trova? Quali sono i suoi confini?
«In realtà la verità della mia opera, in tutti i miei ambienti che troverai riprodotti, corrisponde all’idea di creare un’illusione nello spazio; creare una scatola magica, che è una porta che attraversi, che poi ti porta in un’altra stanza con un’altra porta… un passaggio infinito. La mia verità risiede nella prima ispirazione che ho avuto da ragazza, quando più o meno ho deciso questa fine terribile di fare l’artista: quando ero all’università, ho visitato l’antro della Sibilla di Cuma. C’era un passaggio trapezoidale che ti portava verso un’apparizione – che non avveniva logicamente – della Sibilla. Quando ho visto, ormai anni fa, questo passaggio incredibile, si tratta di un luogo ieratico, non frequentato dal turismo pseudo di massa, era un luogo assolutamente fantastico dove andavano pochissime persone. Non c’era un percorso come c’è adesso a Cuma, ma ognuno seguiva un proprio percorso particolare che ti portava a scoprire luoghi, scoprire quasi nel nulla. Un luogo che attraversavi e questo attraversamento io l’ho ritrovato nel cono ottico infinito (mentalmente infinito) che poteva esistere, e ancora, Once Again, l’idea dell’eterno ritorno nietzschiano. Uno dei primi lavori era una sorta di ambiente con dello zolfo che avevo creato proprio per la fiera di Dusseldorf per la galleria De Crescenzo. Avevo costruito questo passaggio tridimensionale che usciva dalla parete, stretto e cuneiforme, fatto di zolfo in cui si sentiva un odore e si raccoglieva la luce.»

Chiara Dynys, Once Again, 2025, installation view; ph Giulio Buono Studio Blu
Allo stesso modo, il tuo lavoro sembra mostrarsi quasi come una litania. Questo moto ondoso così affascinante quasi da sembrare una danza erotica, ci cattura come fosse un canto delle sirene e ci ipnotizza sospendendo, per un momento, la nostra percezione della realtà. È la famosa sospensione dell’incredulità di Coleridge. Dobbiamo accettare il contesto della situazione per comprendere la stessa situazione ed immergerci al suo interno. Il discorso si può legare, ovviamente, anche alla domanda che ti facevo poco fa sulla quarta parete, perché rompendo la finzione si rompe anche l’atto stesso di credere. Ad esempio, osservando profondamente il tuo lavoro si vedono tutti quei meccanismi che prima ti ho “definito” come finzione della finzione. A che cosa dobbiamo credere quando osserviamo il tuo lavoro?
«Io vorrei che, osservando la mia opera, ci trovassimo all’interno di un quadro. Credo molto e ammiro molto tutto quello che è un certo tipo di lavoro metafisico, per esempio e ovviamente in De Chirico. Vorrei ritrovarci in un luogo che esiste, ma non esiste. Il mare in una stanza di De Chirico è, per l’appunto, un mare in una stanza: un luogo impossibile. Ho costruito questo ambiente perché quando sono entrata nella Sala Stirling, ho visto questa vasca di cemento brutalista dove, per l’appunto, sarebbe stato impossibile raccogliere l’idea del mare. Allora ho deciso di creare un paradosso, come De Chirico, ma anche come Sargentini quando ha allagato l’Attico o Kaprow con The Yard, ma i riferimenti essere molteplici. Una situazione, ancora, molto felliniana ma anche, in fondo, molto da Casa Malaparte: un luogo dove ti si apre qualcosa che non ti aspetti. All’interno di Casa Malaparte, quando si aprono queste finestre sono dei quadri del mare che imitano il mare esterno. Nel salone, vicino al cammino e dentro al cammino, vedi delle tele che sono esattamente la vista del mare che hai dai pertugi e dalle finestre e tu non te l’aspetti. Sono delle situazioni metafisiche, situazioni che ti portano completamente oltre e ti sbilanciano, creando una nuova forma di cortocircuito. Nella mia ricerca, l’attraversamento e il cono ottico sono fondamentali fin dall’inizio, perciò ho scelto di travalicare quel grigiore per superare lo spazio e immaginare.»

Pensando anche alla mostra diffusa nel tempo che hai in corso da Building, Private Atlas, è inevitabile riflettere su quanto, nella tua poetica, il concetto di geografie sia forse fondamentale. La tua mostra da Building è una geografia storica ed emotiva – come l’ha definita Alessandro Castiglioni – in cui intervengono personaggi, relazioni. Si tratta di un’antologia in cui si vede come tu abbia osservato, studiato, riprodotto per poi astrarre il senso delle cose ricercandone l’archetipo. La tua si potrebbe definire una metafisica delle cose del mondo, che è poesia. Cosa sono queste tue geografie?
«Il progetto di Building è un progetto che mi ha appassionato fin dall’inizio. Con Moshe si è prima pensato di fare una mostra nei suoi spazi, ma poi si è preferito allestire 12 vetrine che fossero, praticamente, il racconto temporale ed emotivo di una vita. Non si tratta assolutamente di un racconto cronologico. L’inizio è un lavoro storico degli anni ’90 che ha posto le premesse a diversi miei lavori, l’avevo presentato al Museo di Sant’Etienne, all’interno di Where di Liliana Albertazzi, con Tremlett anche. Io ero giovanissima e in questa mostra avevo portato delle feritoie bianche che riprendevano un po’ l’antro della Sibilla di cui parlavamo prima, anche dal punto di vista concettuale. Ciascuna era concepita con un materiale diverso – marmo, tela, gesso, vetro e ceramica – e Moshe e Alessandro Castiglioni hanno deciso di rimetterle in vetrina. La mostra a Sant’Etienne fu il primo passo per il contratto che ho avuto nel 1992 con la Galerie de France che ha portato ad acquisizioni al Pompidou. Un lavoro che ha certificato anni importanti della mia ricerca e carriera. I lavori poi sono stati esposti con intento assolutamente tematico, l’idea è stata coraggiosa ed efficace perché ha ricostruito quella che è la disseminazione frammentata della memoria che cerco di evocare con i miei passaggi. L’ultimo capitolo, che non è ancora iniziato, Viaggio in Italia riporta questa forma di pensiero dal punto di vista organico. Le vetrine sono state la storia della mia vita, una grandissima operazione che definirei forse più museale che da galleria.»
Spazio, tempo, memoria e identità sono quattro tematiche assolute che sicuramente si ritrovano nel tuo lavoro. Forse sto semplificando – anzi, sicuramente – troppo, ma c’è un’ossessione che trovo così dolce nel tuo lavoro da cui è impossibile non restare colpiti o per lo meno non pensarci. Riesce ad essere sia intimo e biografico che manifesto e assoluto. Ti vorrei chiedere, in ultimissima istanza, di parlarmi di questa forma archivistica – forse, ancora meglio, anarchivistica – che pervade il tuo lavoro.
«I miei archivi non hanno un’ordinazione metodologica precisa ma sono molto più emotivi, molto più istintivi e visuali. Io catalogo senza voler catalogare. Penso all’Atlas di Richter, che è stato uno dei grandi lavori che più mi hanno ispirata quando ho avuto l’occasione di vederlo in Germania. Ho capito che io ero lì perché in realtà l’idea di costruire, nel caso di Citterio, un lavoro completamente diverso formalmente, non denota incoerenza. Conoscendo il mio lavoro e osservando l’allestimento della Sala Stirling, si vede in prima linea questo grande vetro che ha al culmine una pietra, molto simile ai lavori di Villa Panza. Già si riconoscono due anime, quella barocca e quella più minimalista. Ma, al di là di questo, vorrei emergesse che tutto quello che faccio, in forme molto diverse dal punto di vista dei materiali e della costruzione, anche della dialettica, hanno però la forma comune del linguaggio. È un’idea di catalogazione che va procede progressivamente e naturalmente e che mostra un lavoro in conseguenza all’altro. Un’idea e una coerenza che sono, per me, lontane forme, quasi ancestrali, quasi genetiche. Anche nel mio modo di pensare riprendo questo meccanismo quasi ossessivo che continua ad arrotolarsi su sé stesso e che, tuttavia, si espande piano piano nell’ottica di includere tutto il resto.»