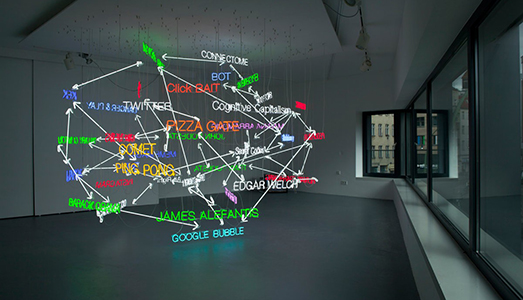-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Ritratto del curatore da giovane
rubrica curatori
di Manuela Valentini
Questa volta passiamo la parola a Lorenzo Bruni, non più giovanissimo, ma apripista di una nuova generazione di curatori
Questa volta passiamo la parola a Lorenzo Bruni, non più giovanissimo, ma apripista di una nuova generazione di curatori
Chi è Lorenzo Bruni? Dove sei nato e dove vivi?
«Una persona curiosa e aperta a raccogliere storie. Sono nato a Firenze e ho studiato tra Siena e Heidelberg. A Siena il mio percorso nell’arte contemporanea, guidato da Enrico Crispolti, è stato condizionato e fortificato dalle lezioni di arte medievale di Luciano Bellosi. In questo momento “sosto” per motivi di lavoro tra Klaipeda (Lituania), Amsterdam e Palermo, sempre con partenza da Firenze».
In che cosa consiste esattamente il tuo percorso formativo?
«Inizia nel 1996, ovvero quando decido di iscrivermi alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Siena. Nello stesso anno ho avviato anche la mia prima collaborazione con Fabio Cavallucci per “Tuscia Electa”, un progetto di arte contemporanea che si svolgeva in luoghi storici della campagna del Chianti, a cui seguirono altre due edizioni in cui ho potuto mettermi alla prova in situazioni progettuali diversificate e a stretto contatto con artisti come Hidetoshi Nagasawa, Mario Merz, Eliseo Mattiacci, Luigi Mainolfi e altri. In questo modo ho avuto la possibilità di calibrare i miei studi teorici con una costante pratica sul campo e un dialogo aperto con gli artisti che mi trovavo a studiare. Inoltre, è stata molto formativa la collaborazione iniziata nel 2000 con Base / progetti per l’arte, spazio no profit fondato da un collettivo di artisti».
Qual è la tua prima esperienza in ambito curatoriale?
«La prima mostra che ho curato e che ancora oggi sento vicina al mio modo di operare è quella con Sisley Xhafa e Adrian Paci dal titolo “Albania”, realizzata a Pelago nel 2001 per la Fondazione Lanfranco Baldi su invito del suo presidente Pier Luigi Tazzi. A quella mostra seguirono altre collaborazioni annuali con la Fondazione che mi costrinsero a ideare progetti site specific non soltanto per il luogo fisico, ma anche in relazione alla specificità della cittadina medievale in cui si trova e del pubblico del festival musicale che per una settimana animava quel contesto».
Il passo successivo qual è stato?
«Sicuramente la necessità di confrontarmi con un ruolo non solo da curatore, ma anche da direttore artistico che ho potuto sperimentare nel 2004 ideando un programma annuale di mostre per la Galleria Civica di Castel San Pietro Terme. La scelta dei temi e della modalità operativa è stata condizionata non solo da riflessioni teoriche su quali potessero essere le ricerche caratteristiche di quel periodo, ma anche dal fatto che la mia attività espositiva in quel luogo doveva dare un forte segnale di riapertura e continuità dopo la recente scomparsa di Mauro Manara. Manara era stato un importante animatore culturale che, tra le altre cose, aveva dato vita alla rassegna “Critica in opera”, con cui realizzò un’importante ricognizione dei curatori attivi in Italia dalla fine anni Ottanta, permettendo ancora oggi di osservare l’evoluzione di questa nuova figura professionale. Le tre collettive furono impostate come manifestazione di tre attitudini con cui il normale cittadino poteva decidere di dialogare e scoprire il mondo: il concetto di sospensione, di aggressività o diffidenza e quello di curiosità incondizionata. Queste tre “attitudini” erano assunte come chiavi di lettura per indagare più attentamente i moventi e le modalità processuali degli artisti coinvolti all’interno delle tre mostre, i cui nomi andavano da Anri Sala a Martin Creed, da David Claerbout a Ian Kiaer, da Aleksandra Mir a Luca Francesconi, da Italo Zuffi a Mark Lewis. In questo caso il tema, croce e delizia del display curatoriale dall’inizio degli anni Novanta, non corrispondeva ad un’iconografia formale o ad un oggetto del reale, ma era sostituito da una chiave di lettura del processo creativo che, per mezzo delle opere, sfociava in un’atmosfera comune in cui il pubblico poteva immergersi. Le opere non erano separate tra loro, ma copresenti al fine di creare un discorso corale e concedere così alla mostra una ragion d’essere ben definita e che evidenziasse forse la vera novità che ha contraddistinto quel decennio: una rinnovata riscoperta della realtà»
Da ottobre dirigi la Fondazione Binnekant21 ad Amsterdam. Di cosa si tratta e di cosa si occupa?
«La Fondazione si trova in un palazzo del Seicento e si propone come luogo propositivo di energie e di scambio di idee all’interno del dibattito artistico internazionale. Questo dovrebbe essere l’intento di ogni istituzione, purtroppo, però, gli strumenti di comunicazione moderni, come per esempio Internet, contribuiscono a farci perdere di vista la relazione particolare con il territorio, rendendo quasi superfluo questo rapporto. I progetti che sto impostando per la Fondazione intendono evidenziare questo rischio in cui possiamo incorrere. Per ora mi limito ad utilizzare solo lo spazio al piano terra, mentre il primo ed il secondo piano verranno inaugurati con progetti specifici a partire dal prossimo anno, dopo che sarà finita la ristrutturazione. Le mostre che stanno già prendendo corpo nel basement sono legate ad una riflessione che possiamo sintetizzare in una semplice questione: cosa rende una comunità tale e cosa le permette di alimentarsi ed esistere? Dal punto di vista critico e teorico, questa domanda mi consente innanzitutto di compiere una ricognizione su quegli artisti che lavorano sul concetto di appartenenza culturale, sulla stimolazione del serbatoio della memoria collettiva e su cosa trasforma un oggetto reale in opera d’arte. Da un punto di vista pratico è un modo per approfondire la ricerca di quegli artisti attualmente attivi sul territorio olandese che si trovano ad affrontare questa particolare situazione. Il ciclo di mostre intitolato “Mi scusi…ma dove mi trovo?”, è stato inaugurato da una collettiva alla quale hanno preso parte Rossella Biscotti, Ahmet Ogut e Andrè Romao».
C’è un movimento o un artista in particolare che ispira la tua attività curatoriale?
«Credo che sia evidente che la generazione di curatori (e di artisti) a cui appartengo abbia trovato dei punti di riferimento forti nelle ricerche artistiche degli anni Sessanta e soprattutto della storia e nelle vicende politiche e culturali di quegli anni. Questa però non è una fuga nel passato, ma un’analisi dei concetti e delle modalità presenti in quegli anni, proprio perché è l’unico momento storico più vicino a noi in cui la rivoluzione della coscienza collettiva era un’ipotesi e una pratica concreta allo stesso tempo. Questa spinta nel mondo dell’arte si traduceva nel tentativo di eliminare la gerarchia tra il ruolo dello spettatore, dell’artista e del luogo deputato. Per questo credo che l’Arte Concettuale, l’esperienza Fluxus e i land artisti di area californiana non siano tanto un modello di ispirazione, quanto un punto di riferimento a cui doversi ricollegare. Questo dialogo – forse da ripensare alla luce della tendenza edonistica nata negli anni Ottanta e ancora in auge che ci porterà necessariamente a nuove soluzioni – credo sia fondamentale per riflettere su cosa intendiamo oggi per concetto di appartenenza culturale ed evoluzione collettiva. Anche perché nel frattempo la divisione tra ideologia capitalista e comunista è venuta meno ed in parte stata sostituita dalla divisione tra mondo cristiano e mondo musulmano, tra vecchia economia e nuova economia».
Hai lavorato con molti artisti stranieri. Cos’hanno in più o in meno rispetto ai nostri connazionali?
«Guardando i miei progetti si può dire che ho lavorato con gli artisti indipendentemente da nazionalità, generazione e genere sessuale. Infatti, dagli ultimi dieci anni, non credo si possano fare più distinzioni tra artisti italiani e stranieri, anche perché il periodo in cui i curatori erano costretti ad essere esterofili è ormai superato. Questo perché l’artista italiano, come quello polacco o di altre nazionalità, può tranquillamente dialogare con il resto del mondo grazie ai moderni mezzi di comunicazione e grazie delle potenzialità degli spostamenti veloci di cui possiamo usufruire oggi. Nel pensare agli artisti da invitare non mi sono mai posto il problema di dover inserire per forza un artista italiano o un’artista donna per essere politically correct, cosa a cui dovevano fare molta attenzione i curatori della generazione precedente».