Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
«Sono un anziano gentiluomo, pacifico, felice, allegro. A eccezione del fatto che mi piace essere polemico». Markus Lüpertz ha una chiara immagine di sé e riesce a definirsi perfettamente, con il giusto sbilanciamento di aggettivi che, pur generici, sfumano nella specificità, scivolando con naturalezza dalla foggia delle sue giacche, dall’angolo preciso della barba candida, dall’inclinazione delle spalle larghe, fortificate dalla prassi di una pittura fisica ma più sofferta che passionale. Uno stile caricato di suggestioni dandistiche mitteleuropee, quell’atteggiamento da viveur tormentato dall’idea dell’esistenza di qualcosa che non si può arrivare a comprendere. Un po’ faticoso ma affascinante. Le ossessioni per l’inconscio, l’archetipo e i simboli nascosti, in quell’area, devono essere avvertite fatalmente più che da altre parti.
Tutta la vita di Lüpertz è stata orientata dal gusto di una provocazione più o meno sottile, l’esperienza giovanile nella Legione Straniera potrebbe ricordare vagamente l’incoscienza di un Louis-Ferdinand Céline, quella del lavoro in miniera il vitalismo di un Ernest Hemingway. Magari più socievole, soprattutto del francese, visto che tra gli anni ’60 e i ’70, strinse buoni rapporti con A.R. Penck, Georg Baselitz, Gerhard Richter, formando quella generazione di artisti tedeschi del dopoguerra in cerca di una nuova vita espressiva, tanto tedesca che internazionale, una mitologia necessaria dopo la barbarie del nazismo. Non figurazione, compromessa da certi stereotipi da esorcizzare, o astrattismo che, nella definizione espressionista allora contemporanea, era calibrato verso una modalità visiva troppo fresca, istintiva, quindi poco europea. La soluzione fu un ottimo compromesso, tra dinamismo ed eleganza, che riuscì anche nell’impresa di mantenere intatto il sacro valore della pittura, medium al quale Lüpertz è rimasto molto legato. A riunire questa generazione, furono gli spazi di Michael Werner che, nei primi anni ’60, dopo aver lavorato alla galleria di Rudolf Springer, ne aprì una sua, a Berlino, dedicata alle nuove sperimentazioni. Verner poi si spostò negli Stati Uniti, sposò Mary Boone e inaugurò una galleria a New York, nella sede che fu di Leo Castelli.
Così, sembra molto naturale che a suggellare la definitiva (forse tardiva?) consacrazione transoceanica di Lüpertz – che nel vecchio continente è considerato già da anni un maestro della pittura (forse l’ultimo?) – sia stata proprio la sua prima galleria. In questo momento, Lüpertz raccoglie i frutti del suo lavoro, arrivando a dominare la scena statunitense con tre mostre, al Museo Hirshhorn, alla Collezione Phillips e alla Werner Gallery. Un’operazione a tutto tondo, con la mostra all’Hirshhorn incentrata sui primissimi lavori risalenti agli anni ’60 e ’70, e quella da Phillips che propone uno sguardo completo sul percorso artistico, dalle giovanili manipolazioni dei luoghi comuni tedeschi alle ultime pitture mitologiche. Per chiudere il cerchio, da Werner sono esposte opere nuove, che continuano sulla scia del mito, questa volta declinato sui temi arcadici. (MFS)
In alto: Markus Lüpertz (b. 1941) nel suo studio vicino Berlino, febbraio 2017. Photo: Thomas Meyer






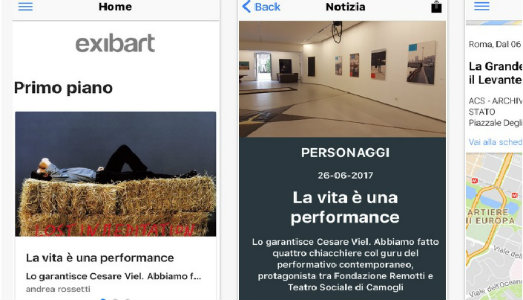




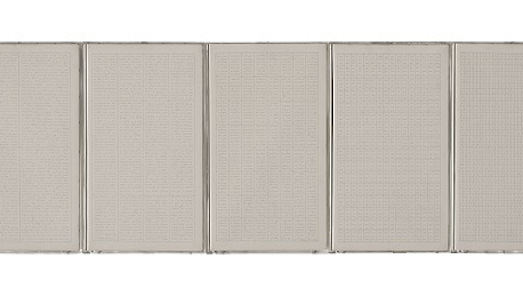
.jpg)




















