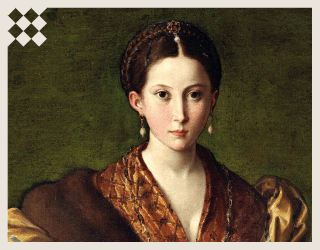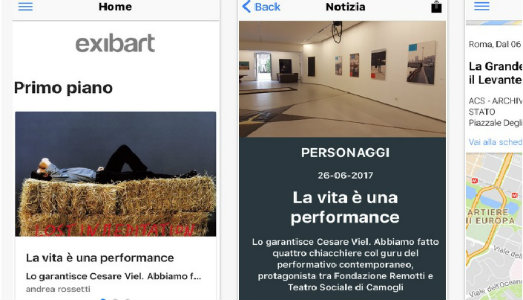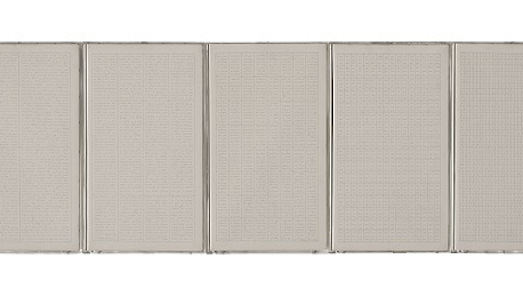Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
L’ascensore in vetro ci porta al secondo piano di un fabbricato in stile sovietico situato alla destra dell’enorme cortile in mattoncini, con l’entrata rivolta alla Potsdamer Strasse. Apro con un mio amico (un musicista) la porta dove c’è scritto Esther Schipper, e ci dirigiamo nel rettangolo aureo dedicato all’installazione di Solo for Ayumi guidato dalla mia curiosità verso la seconda personale di Ari Benjamin Meyers e attratto dalla presenza della violinista Ayumi Paul come parte integrante dell’esposizione.
Ancor prima di chiedermi come potrebbe un essere umano sopravvivere 24h in una galleria d’arte per circa un mese, noto con sorpresa che la sala è vuota. Dodici spartiti appesi alle pareti su cui qualcuno sembra si sia divertito a sovrapporre al pentagramma, già fitto di note, un diario segreto che scoraggia qualsivoglia lettura monografica: narrazione musicale e biografica formano un intreccio indissolubile che si presenta nella sua irrisolvibilità, così come probabilmente si presenterebbero nella vita reale. Mi cimento in una lettura epistolare silenziosa che sgorga sempre dal Dear Ari iniziale, e ripercorro le tappe fondamentali della vita della musicista; inizio a empatizzare con lei quando leggo del suo primo amore, della morte di suo padre, e poi l’adolescenza a Berlino, la depressione, il viaggio in India. Ogni pagina mi avvicina alla sua presenza con una qualità immateriale, grazie anche all’ efficacia filologica con cui mi viene proposta. Accanto a queste pagine infatti c’è sempre un oggetto relativo alla storia che mi aiuta a fissare meglio, in maniera esperienziale e cronologica, le tappe della vita di Ayumi dal primo all’ultimo riquadro, posto specularmente rispetto al punto dove la storia ha avuto inizio: una scarpetta da bambina e una pistola giocattolo formano le quinte di questo micromondo.
Chi conosce Ari Benjamin Meyers, sa bene che questi sono alcuni tra i concetti chiave del suo lavoro: già in VEXATIONS II il visitatore si muoveva in una sala arredata con 840 spartiti basati sulle impercettibili variazioni di un brano di Eric Satie (che in quel caso non si ascoltava dal vivo) così da essere fisicamente circondati dalla musica. Senza sapere perché, prima di andarmene sento il bisogno di toccare la consistenza del tappeto nero sintetico che delimita la sezione aurea del nostro ipotetico rettangolo, che ci rifiutiamo istintivamente di calpestare. Al centro c’è un vaso con un bel fiore – sembra un giglio regale – e nell’angolo a nord ovest una pila di spartiti che riposa all’ombra di una brocca d’acqua. Sembra che qualcuno abbia abitato lì, sembra (e forse lo è) un vuoto distensivo che sublima e mitiga le sensazioni accumulate dalla storia di poco fa, quando come spettatore formavo l’ipotetica base di un triangolo equilatero formato da Ayumi e Ari.
A questo punto la nostra visita sembrerebbe conclusa; guardo il mio amico, poi l’uscita – siamo tutto sommato soddisfatti ed è tempo di andare, ma ecco d’un tratto la seconda sorpresa: Ayumi Paul, la persona di cui ho così impunemente curiosato nell’infanzia e che posso dire di conoscere, entra nella sala e si posiziona sul tappeto nero da cui ci eravamo tenuti in qualche modo alla larga e, come fosse la cosa più naturale del mondo – e lo è – inizia a suonare; ci invita a sederci sul tappeto, a esplorare quello spazio magnetico repulsivo che prima sembrava riservato e in un certo senso lo è, era riservato al nostro incontro. Prima di entrare mi levo le scarpe, non so perché.
Tutto ciò che promana dal suo suonare e dal suo esserci, è come fosse frutto e compimento della lunga e paziente lettura spazio-temporale che eravamo stati invitati a provare singolarmente, è come se dentro di me conoscessi già quella melodia, anche se non l’ho mai ascoltata. A quel punto anche noi siamo diventati, in modo naturale, parte cosciente e attori della performance. I visitatori che iniziano a entrare ci trovano perfettamente inseriti in questa situazione, e noi pensiamo lo stesso di loro ma dal nostro punto di vista. Senza volerlo siamo stati “diretti” dal Meyers-compositore a prendere posto in una coreografia architettonica che premetteva e anticipava quella musicale, rispetto alla quale abbiamo inter-reagito sia socialmente che spazialmente (mi viene in mente all’improvviso che gli intervalli in musica sono la distanza tra le note). Come succedeva in Symphony X, dove gli elementi fisici tra performer/audience come palco, luci, leggii e sedie venivano gradualmente trascinati fuori dalla sala fino a eliminare ogni barriera tra musicista e spettatore. Una operazione di sottrazione, Miles Davis docet.
“Il mio lavoro è trasformare la musica in silenzio”, afferma Meyers in un’intervista. E noi, chiamati in causa come audience ma sopratutto come esseri umani, dobbiamo sciogliere quel silenzio – se vogliamo; noi ne siamo l’ottava sospesa, una variante corporea, cassa di risonanza senziente e vitale dello sconfinato universo. Guardo ancora il mio amico. Ayumi ha smesso di suonare e prende un po’ d’acqua dalla brocca, si siede a gambe incrociate sul tappeto sintetico con la schiena poggiata al muro, sembra che si ascolti. Ci concede l’occasione propizia per lasciarla sola ma voglio farlo concedendomi un ultimo, effimero desiderio: uscendo per ultimo la ringrazio con un cenno muto del capo, chiudo il sipario nero, e immagino di essere stato proprio io ad aver messo fine alla musica e al suo diario. (Luigi De Cicco)