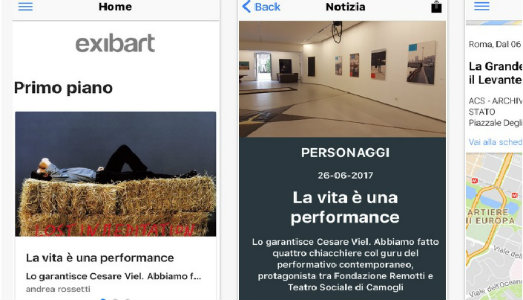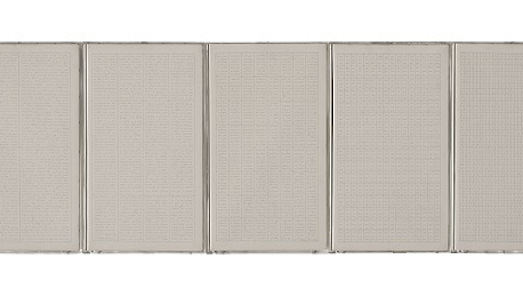Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- Servizi
- Sezioni
- container colonna1
All’opening del padiglione danese alla 56 Biennale d’arte di Venezia sono presenti Dahn Vo, l’artista di origini vietnamite ma naturalizzato danese, e suo padre, Phung Vo (la famiglia Vo è fuggita dal Vietnam negli anni ’70 per approdare in Danimarca). Ma perché un artista grande e grosso come Dahn dovrebbe portarsi dietro il padre? Una forte insicurezza? Bisogno di affetti familiari? No, semplicemente Dahn considera l’intervento del padre una componente fondamentale del suo lavoro: avendo il papà grande difficoltà a scrivere altre lingue oltre il vietnamita, l’artista gli ha delegato tutte le operazioni che richiedono l’uso della scrittura e della calligrafia (la mostra è anche un’occasione per vedere la famosa lettera di un missionario al padre, poco prima di essere decapitato in Vietnam nel XIX secolo, riscritta a mano dal padre di Dahn) non come dispetto, ma proprio per sottolineare questo handicap causato dalle sovrapposizioni culturali.
Il padiglione, pulito e concettualmente solido, considerato tra i migliori dei Giardini, si gioca infatti tutto sulle coordinate del colonialismo e della ricerca delle radici, da sempre punti forti del suo lavoro.
Alcune opere nascono dall’innesto e manipolazione di manufatti trovati e acquistati – a volte vere sculture antiche – da Dahn, che si riferiscono al rapporto tra cultura colonizzante e cultura colonizzata. Cosí, divanetti di design danese degli anni ’50 possono convivere con antichi piatti di ceramica cinese lungamente incrostati dal mare; oppure un tavolo di design, insieme ad alcuni rami (o radici) provenienti dal Messico, e innestati di putti dorati barocchi – Messico, altro luogo inquinato pesantemente dal colonialismo – può evocare la storia di Giuda, complici una bottiglia di tequila e trenta denari (incastonati nel tavolo). Eh già, perché ovviamente la religione ha e ha sempre avuto un ruolo fondamentale nei processi di colonizzazione: e i parenti di Dahn si sono convertiti al Cristianesimo quando sono arrivati in Europa. I riferimenti sono ovunque, come il crocifisso fiammingo del 15 secolo, o la madonna della scuola di Nino Pisano innestata su un pezzo di sarcofago romano imperiale.
Confermano l’importanza del tema sacro i titoli delle opere, presi dai dialoghi volgari e blasfemi di Regan MacNeil, l’indemoniata de L’esorcista, citata anche nelle scritte gotiche sul vetro del padiglione, che appaiono come ombre a terra, con una certa luce solare. Colonialismo come possessione? Chissà.
P.s. Non perdete l’altra mostra di Dahn Vo a Punta della Dogana, “Slip of the tongue”, stavolta in veste di curatore. (Mario Finazzi)