-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Graffitismo, Writing e Street Art: intervista a Vittorio Parisi
Street Art
Pubblichiamo la prima parte dell’intervista a Vittorio Parisi, direttore degli studi e della ricerca dell’École nationale supérieure d’art et centro d’arte contemporanea Villa Arson a Nizza. Dottore di ricerca in estetica presso l’Université Panthéon-Sorbonne di Parigi, dove ha insegnato dal 2015 al 2019, i suoi studi indagano il rapporto tra il graffiti writing, la street art e i non-luoghi urbani. Nel 2013-14 è stato visiting scholar presso il dipartimento di filosofia della Columbia University a New York e curatorial intern alla Dia Art Foundation.
Graffiti, writing, graffiti writing, street art, muralismo, arte urbana. Facciamo un po’ di chiarezza?
«Proverei a fare un primo distinguo tra i due termini forse più vicini a quello di cui stiamo parlando: da un lato writing, che è abbastanza semplice da definire, dall’altro street art, e che invece dà qualche problema in più. Il primo indica tutto ciò che ha a che fare con la tag e le sue variazioni grafiche. La tag è lo pseudonimo utilizzato dal writer, iscritto per lo più illegalmente su una qualsiasi superficie urbana, solitamente per mezzo di una bomboletta spray o di un pennarello. Si tratta quindi di una vera e propria forma di calligrafia urbana che segue delle sue regole morfologiche e performative precise, e le cui origini risalgono alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, tra Philadelphia e New York. Come è noto, è in quest’ultima e sui suoi treni che il writing ha conosciuto la sua epoca d’oro.
Dico writing e non graffiti, perché gli adolescenti che abitavano i quartieri a nord di Manhattan e il South Bronx, e che hanno letteralmente inventato un nuovo genere artistico – Goffredo Parise, inviato dal Corriere della Sera a New York nel 1975, facendone la scoperta parlava addirittura di “prima cultura nazional-popolare americana” – tra loro erano soliti chiamarsi writers. Se oggi diciamo graffiti writing o semplicemente graffiti, è perché quando le autorità e i media dell’epoca si trovarono di fronte alla necessità di dare un nome al fenomeno, venne in loro aiuto questa parola, che nel linguaggio comune ha finito per indicare qualsiasi tipo di scritta ottenuta a mano su una superficie murale.

In origine era stata coniata da un archeologo gesuita italiano, Raffaele Garrucci: nel 1856 quest’ultimo pubblicò a Parigi uno studio sulle iscrizioni incise a mano sui muri di Pompei, e decise di chiamarle “graffiti”, poiché per ottenerle il muro veniva letteralmente graffiato per mezzo dello stiletto in ferro o in osso che i romani utilizzavano per scrivere sulle tavole cerate.
Veniamo a street art. Il termine è comparso più o meno nello stesso periodo in cui il writing si è sviluppato. Lo troviamo pubblicato per la prima volta nel 1975, come titolo di un libro di uno psicologo americano, Robert Sommer. Qui “street art” viene utilizzato per indicare i community murals: una nuova forma di muralismo che, prendendo spunto dal muralismo per antonomasia (quello messicano dei Rivera, dei Siqueiros e degli Orozco), si era sviluppata in varie città degli Stati Uniti, specialmente in California, e che vedeva gli artisti realizzare grandi pitture murali urbane al fianco delle comunità locali. Dieci anni dopo, nel 1985, street art fu riutilizzato per intitolare un altro libro, curato da Allan Schwartzman, nel quale si parla di una nuova scena artistica, essenzialmente newyorchese, caratterizzata da giovani artisti (tra cui Keith Haring e Richard Hambleton) che, influenzati dall’esempio dei writers, avevano iniziato a intervenire nello spazio urbano.

Da qui probabilmente il termine si avvia a correre parallelamente a writing e graffiti, o quanto meno a tutto ciò che è derivato o è stato influenzato da quest’ultimo (si pensi anche all’uso del termine “post-graffiti”). Tuttavia, street art può voler dire tante cose, e spesso contraddittorie: è una sorta di ombrello che usiamo per comodità e sotto il quale mettiamo, per esempio, lo sticker, la pittura murale di grandi dimensioni e la wall painted animation; la murata sgangherata fatta furtivamente tra amici in un edificio abbandonato e l’intervento a tutto muro con tanto di gru a cestello durante un festival pluri-sponsorizzato.
Arte urbana non è un termine da meno: l’uso ricorrente in Italia e in Francia denota forse più il bisogno di emanciparsi dagli anglicismi che ci sono giunti in eredità dall’altro lato dell’oceano. Una cosa è certa: nessuno dei pionieri e protagonisti di quella che chiamiamo street art – e cioè gli artisti che, sul finire degli anni Novanta, furono protagonisti della transizione dal writing a nuove forme di pittura murale urbana – chiamava se stesso “street artist”. Anche in questo caso, è più un’invenzione penetrata dall’esterno, dagli studiosi o dagli appassionati come Sommer e Schwartzman, e naturalmente dai media».
Dove vedi le maggiori differenze con la mentalità che muoveva i writer o gli street artist di anni fa? Il tema dell’illegalità?
«L’illegalità gioca senz’altro un ruolo importante, ma il tutto non si esaurisce in essa. Fino a prova contraria il Banksy di oggi realizza la maggior parte dei suoi progetti illegalmente, eppure sento di poter dire che il suo approccio sia diverso da quello del Banksy degli anni di Bristol. Non ridurrei, però, neanche il tutto a una mera questione di fama: Blu è un artista conosciuto in tutto il mondo, eppure il suo approccio è rimasto lo stesso di sempre, nonostante la notorietà, le evidenti evoluzioni tecniche e formali delle sue opere, e le dimensioni monumentali delle stesse.
Quello che chiamiamo street art è ormai da tempo parte integrante dell’industria culturale, e in quanto tale per sopravvivere è chiamato a rinunciare a parte dell’ethos che ne caratterizzava le origini, e che la street art ha in comune con il writing. Gran parte della street art di oggi è prodotta per “abbellire” e, quindi, è perfettamente affine alla tutela della proprietà, intesa nella sua doppia accezione: da un lato come bene o patrimonio, pubblico o privato che sia; dall’altro come decoro, pulizia, gradevolezza.

La street art prodotta nella maggior parte dei festival, per esempio, è sempre “appropriata” e quasi mai “fuori luogo”, al punto che spesso prendiamo in prestito dal linguaggio dell’arte contemporanea una formula abusata come site-specificity per sottolineare quanto sia appropriato intervenire su un edificio in particolare, o in una strada, un quartiere, una città. Il writing è rimasto più libero e fedele alle sue origini perché, in linea di massima, della proprietà e di tutte le sue possibili accezioni continua a infischiarsene bellamente, anzi la sua forza e la sua specificità estetica risiedono precisamente nell’essere ostinatamente fuori luogo. Questa, forse, è una delle principali differenze tra l’approccio di ieri e quello di oggi: il principio e il concetto della site-specificity sembra aver quasi del tutto rimpiazzato quello della – come potremmo chiamarla? – out-of-placeness? che ne caratterizzava le origini».
Da movimento culturale e artistico dal basso, dalla forte carica dissacrante, l’esperienza estetica della street art è diventata, quindi, strumento di coesione sociale, di partecipazione e di riqualificazione urbana sempre più di frequente utilizzata dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti privati per esprimere messaggi encomiastici o celebrativi. Ci spieghi questa evoluzione?
«Forse la risposta a questa domanda è già in parte contenuta nella risposta precedente: l’evoluzione, o meglio la trasformazione, si ha da un’arte nata “dal basso”, e cioè marginale, spontanea e dissacrante, a un’arte “amministrata”, e quindi centrale, burocratica, riqualificativa. Mi attarderei tuttavia su alcuni aspetti. Mi chiederei per esempio cosa intendiamo quando diciamo che la street art delle origini fosse una pratica dalla forte carica dissacrante. Se ci riferiamo ai contenuti delle opere realizzate, abbiamo effettivamente tanti esempi illustri: Blu, Bastardilla, Banksy, Shepard Fairey, JR, Ericailcane, Escif, ecc. Tuttavia non credo che sia solo la vocazione satirica o di denuncia di certa street art a fare di quest’ultima un’arte dissacrante.

Da un lato mi chiedo, per esempio, cosa rimanga di effettivamente dissacrante (e non, piuttosto, caricaturale) nelle opere di artisti come Shepard Fairey o Banksy; dall’altro, sin da subito tanti altri artisti hanno intrapreso la strada dell’astrattismo, con esiti estremamente interessanti (108, Eltono, Momo, ecc.). Penso che il carattere dissacrante o meglio – volendo chiedere un prestito alla musica – “dissonante” della street art delle origini sia da rintracciare proprio in quel suo essere “fuori luogo” a cui accennavo prima, che essa condivide con il writing, e che emerge dal metodo con cui il writing e la street art vanno a imprimersi sui luoghi. Entrambi instaurano, infatti, un rapporto dialettico con le superfici e i volumi su cui si iscrivono, dove l’architettura preesistente gioca il ruolo di tesi e l’opera d’arte quello di antitesi.
Così inteso, questo rapporto non potrà mai essere ornamentale: l’ornamento serve ad affermare e rafforzare un ordine prestabilito dall’architettura, mentre il writing e la street art delle origini, quelli praticati furtivamente in luoghi abbandonati o non custoditi, agiscono subordinando al proprio controllo e al proprio regime estetico tutto ciò che viene dettato dall’architettura. Essi possono decidere di adattarsi a quei dettami e, quindi, rispettare i limiti ortogonali delle pareti e delle aperture, così come ignorarli del tutto e debordare, invadere, infestare gli spazi.
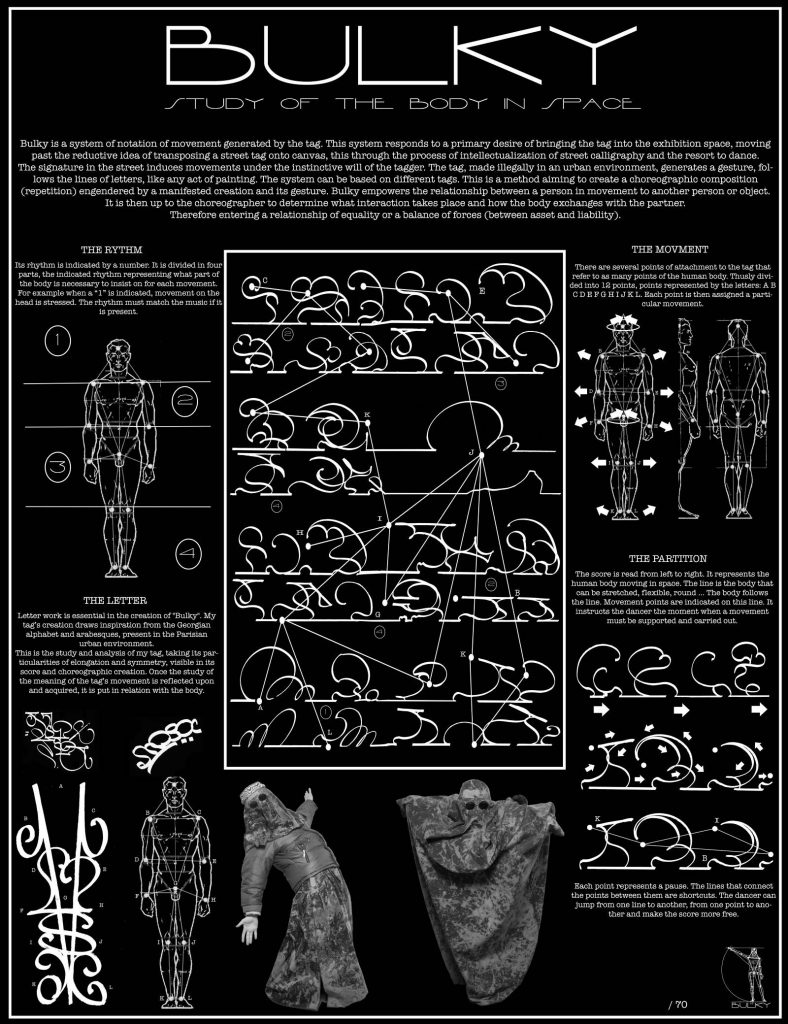
Ovviamente, questa autonomia estetica rispetto ai luoghi cessa di esistere nel momento in cui la street art diventa strumento amministrativo di presunta riqualificazione. Dico “presunta” perché, in effetti, non sono poi così certo che questa trasformazione da arte dal basso a arte amministrata abbia realmente prodotto coesione sociale, partecipazione e riqualificazione: sicuramente questi sono i principali gridi di battaglia delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati che sostengono progetti d’arte urbana, e non escludo che in certi casi e in certi contesti ciò abbia prodotto degli esiti concreti.
D’altra parte, è davvero complicato misurarne l’effettiva portata; vi è poi da considerare il rovescio della medaglia, e cioè il rischio della gentrificazione: si pensi al caso del murales di Blu sulla Cuvrystraße a Kreuzberg, cancellato per volontà dello stesso artista nel dicembre 2015 per non alimentare la sempre più frequente attenzione di investitori e speculatori edilizi in quello che è, ormai da tempo, l’ex quartiere underground berlinese».























