-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Graffitismo, Writing e Street Art: intervista a Vittorio Parisi (Parte II)
Street Art
Pubblichiamo la seconda parte dell’intervista a Vittorio Parisi (qui la prima), direttore degli studi e della ricerca dell’École nationale supérieure d’art et centro d’arte contemporanea Villa Arson a Nizza. Dottore di ricerca in estetica presso l’Université Panthéon-Sorbonne di Parigi, dove ha insegnato dal 2015 al 2019, i suoi studi indagano il rapporto tra il graffiti writing, la street art e i non-luoghi urbani. Nel 2013-14 è stato visiting scholar presso il dipartimento di filosofia della Columbia University a New York e curatorial intern alla Dia Art Foundation.
Da movimento culturale e artistico dal basso, dalla forte carica dissacrante, l’esperienza estetica della street art è diventata, quindi, strumento di coesione sociale, di partecipazione e di riqualificazione urbana sempre più di frequente utilizzata dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti privati per esprimere messaggi encomiastici o celebrativi. Per te è stata un’evoluzione o un’involuzione?
«Si intuisce dalle mie risposte precedenti che io abbia una preferenza, oltre che per il writing in particolare, per quella street art che è stata in grado di conservare la sua specificità estetica originaria. Detto ciò, a prescindere dalle inclinazioni personali, la trasformazione avvenuta è abbastanza comprensibile: ad un certo punto si è creato un mercato, un’offerta già esistente ha stimolato la creazione di una domanda che ha a sua volta e inevitabilmente trasformato quell’offerta. E ciò è un bene sotto diversi punti di vista e al di là di tutte le nostre letture filosofiche, perché ha permesso a tanti artisti di emergere, di lavorare, e spesso di produrre opere plasticamente pregevoli, anche nel caso di progetti su commissione. Soprattutto, gli artisti hanno cominciato a dialogare con il mondo dell’arte contemporanea e in alcuni casi a ottenere un riconoscimento istituzionale che va oltre la partecipazione ai festival o la visibilità su internet e sui social. Specialmente in questo caso parlerei di evoluzione, e prenderei ad esempio gli artisti francesi Olivier Kosta-Thefaine (Stak), Antwan Horfee (Horfee) e Alexandre Bavard (Mosa), tutti nati dal writing illegale – molti dei quali per altro ancora attivi su quel fronte – ma capaci di un percorso di sperimentazione e reinvenzione costante dei propri linguaggi, che nel corso degli ultimi cinque anni li ha portati a esporre in luoghi come il Palais de Tokyo a Parigi o Somerset House a Londra».

Street art o arte pubblica: le due azioni sono in contrapposizione?
«Penso che la street art così come il writing siano forme abbastanza particolari di arte pubblica, con una loro specificità e autonomia estetica, che tende ad allontanarsi da quello che tradizionalmente consideriamo arte pubblica (monumenti, interventi voluti o avallati da comunità, amministrazioni, istituzioni artistiche, etc.). Sono arte pubblica nella misura in cui esse hanno luogo nello spazio pubblico, ma a differenza dell’arte pubblica per come la intendiamo solitamente, la loro esistenza è sempre fuori luogo: un’interruzione inattesa nell’ordine urbano preesistente».

Data la potenza visiva e l’immediatezza che spesso caratterizzano sia il writing che la street art, non si rischia di “declassarle” a semplice riqualificazione urbana come fossero solo delle decorazioni?
«Questo accade precisamente quando si perde quel rapporto dialettico a cui facevo riferimento prima. A prescindere dalla potenza visiva e dall’immediatezza dell’opera, se quest’ultima non entra in un rapporto di tesi-antitesi con le superfici e i volumi urbani circostanti, subordinandoseli e mettendoli in discussione, rischia di agire come puro ornamento. Quando invece ciò avviene, il risultato di questo rapporto, la sintesi che chiude la successione dialettica dà vita a una categoria estetica a mio avviso del tutto autonoma, propria a quest’arte e a nessun’altra: un’“opera-luogo”, diversa quelle prodotte dall’architettura, dall’arte cosiddetta site-specific e dalla land art».

A tuo avviso negli ultimi anni si può dire che ci sia un nuovo interesse curatoriale nei confronti di street art e writing?
«Certo, anche qui conviene forse interrogarsi prima su come intendiamo la curatela applicata a questo particolare mondo dell’arte. Il curatore è da considerarsi ormai un creatore al pari dell’artista, e in quanto tale il suo ruolo è quello di progettare qualcosa che abbia una sua coerenza concettuale. In ambito urbano questa coerenza è la risultante di tanti fattori. Alcuni di essi sono abbastanza scontati: come nasce la collaborazione con l’artista o gli artisti, cosa si vuole produrre in termini di riflessione e di creazione artistica, a quale pubblico ci si rivolge (ammesso ci si voglia rivolgere a un pubblico!) e, naturalmente, quali sono i luoghi in cui si vuole intervenire.
Dopodiché entrano in gioco altri fattori: il progetto prevede la creazione di qualcosa che sia destinato a durare o a scomparire? Le opere sono autorizzate o realizzate illegalmente? Se il progetto ha luogo nello spazio pubblico, che tipo di dialogo si vuole instaurare con quest’ultimo? E se il progetto ha luogo in uno spazio chiuso…stiamo sempre curando dell’arte urbana, o siamo passati ad altro senza accorgercene? In Europa ci sono curatori che hanno fatto un ottimo lavoro assieme ad artisti provenienti dal writing e dalla street art, e con essi inventando modi di tradurre quella specificità estetica all’interno del white cube, senza banalmente replicare ciò che essi fanno all’esterno.
Volendo citare un caso in particolare, sarebbero le mostre curate da Rafael Schacter a Somerset House nel 2015 (Mapping the City) e nel 2016 (Venturing Beyond). Nello spazio pubblico, invece, penso che un grande lavoro sia stato fatto dal festival Bien Urbain a Besançon, in Francia, dove la curatela di ogni edizione viene affidata a un artista (l’argentina Hyuro, da poco scomparsa, ha curato l’ultima edizione del 2019)».
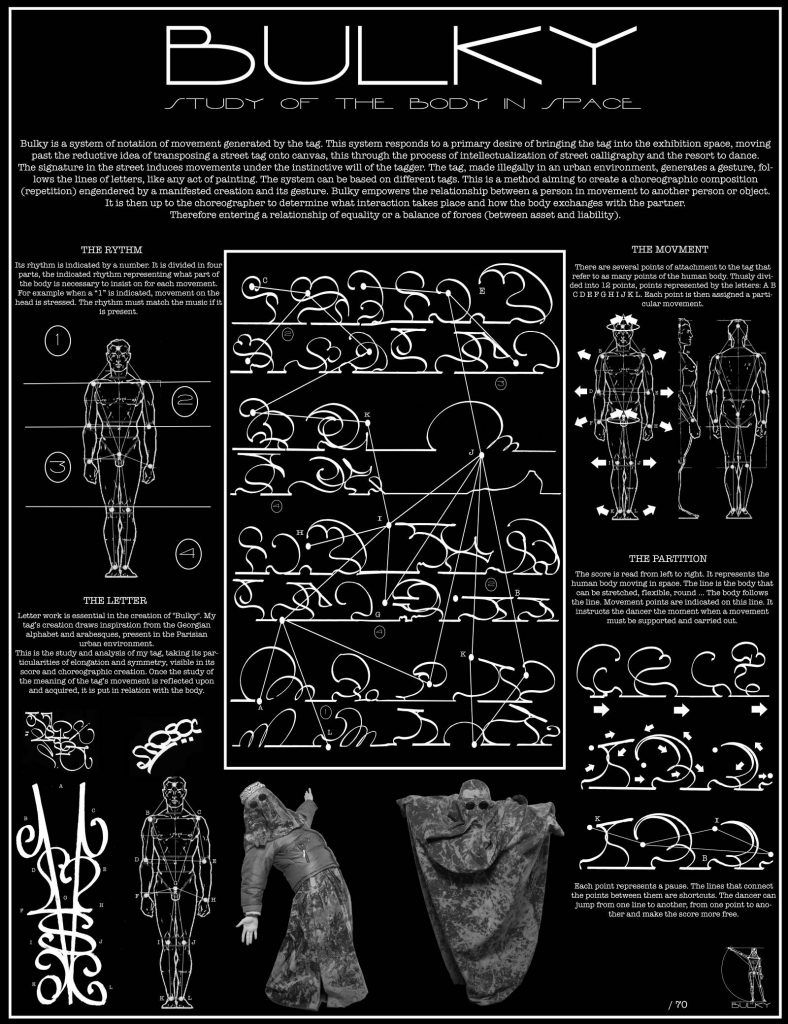
Quanto incide l’arte urbana come mezzo di comunicazione politica?
«Se per comunicazione politica intendiamo la comunicazione di contenuti di interesse politico (e non quindi le campagne elettorali), penso che certa street art di oggi funzioni in maniera analoga al muralismo: opere in grado di trasmettere soggetti e narrazioni politiche in modo particolarmente efficace, facendo cioè leva sulla monumentalità delle dimensioni, sulla creazione di simboli, su una grande capacità di sintesi e spesso sulla satira.
Le differenze col muralismo propriamente detto riguardano per lo più i contesti storici, sociali e culturali differenti: in Messico le opere raccontavano, attraverso la lente del marxismo-leninismo, la rivoluzione e l’epopea dei lavoratori; oggi i murales di Blu e Ericailcane parlano soprattutto della crisi ambientale, di quella dei migranti, dei disastri causati dalla globalizzazione nelle comunità dei paesi in via di sviluppo.
È difficile misurare quanto tutto ciò incida sulla realtà, ma in un contesto sociale e culturale come il nostro, saturo di immagini d’ogni genere, dubito che l’arte in generale possa essere un mezzo di rivoluzione efficace come lo è stato in certe situazioni del passato. A volte ho l’impressione che carichiamo l’arte di troppe attese, che le attribuiamo ruoli salvifici o responsabilità che non sono le sue (come nel caso della riqualificazione urbana).
Il writing continua senza dubbio ad avere un impatto politico nella misura in cui esso, come abbiamo visto, contravviene a qualsiasi regola dettata dall’ideologia del decoro. In questo caso però non parliamo più di contenuti, di comunicazione politica propriamente detta, parliamo semmai di vera e propria agency: parliamo, d’altronde, di un caso particolarissimo in cui creazione e distruzione, arte e vandalismo coincidono, sono un tutt’uno».























